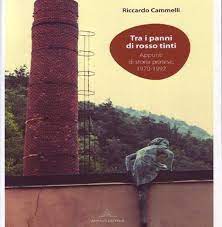Nel secondo dopoguerra l’industria tessile pratese, dopo la fase della ricostruzione, dovette affrontare, tra il 1949 ed il 1952 circa, una crisi drammatica che si risolse con una profonda modificazione della struttura produttiva, lo smantellamento dei grandi lanifici a ciclo completo e la nascita del distretto industriale. Al superamento della crisi fece seguito un lungo periodo di sviluppo. Tra il 1961 ed il 1981 i principali indicatori economici si mantennero costantemente in crescita: le unità locali, per esempio, che erano 10.700 nel 1971, salirono a 14.700 nel 1981, mentre gli addetti passarono, nello stesso arco di tempo, da 50.000 a 61.000.
Le prime avvisaglie di una nuova crisi, che investì soprattutto il settore del cardato, si manifestarono verso la metà degli anni Ottanta. I suoi effetti furono contenuti grazie allo sviluppo della fase di nobilitazione dei tessuti ed alla possibilità di ricollocare nel terziario parte dei lavoratori rimnasti disoccupati, ma l’inversione del trend positivo era un dato di fatto innegabile: fra il 1981 ed il 1991 i fusi di cardato scesero da 770.000 a 400.000, le unità locali tessili da 14.700 a 10.500 e gli addetti al tessile da 61.100 a 46.200.
La situazione si aggravò negli anni successivi in seguito ad un complesso di cause eterogenee, che per gli industriali erano rappresentate in primo luogo dal costo del lavoro – a loro avviso troppo elevato –, dagli alti oneri sociali, dalla mancanza di infrastrutture adeguate e così via, mentre il sindacato ed il Partito comunista insistevano soprattutto sull’eccessiva frammentazione della struttura produttiva. Valgano al riguardo alcuni dati: a Prato la media dei dipendenti per azienda era pari a 3,7 (e le aziende con più di quindici dipendenti costituivano dunque una minoranza); nel 1999, a parità di fatturato, i lanifici attivi a Biella, il più importante centro laniero italiano, erano cinquanta, nella città toscana cinquecento, molti dei quali strutturati in maniera inadeguata rispetto alle esigenze del mercato. Tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo l’industria tessile locale, già in seria difficoltà, precipitò in una crisi dalla quale non si sarebbe più ripresa: a determinarla furono l’entrata in vigore dell’euro (1999-2002) – che rese impossibile fare assegnamento sulla svalutazione della lira per ridurre i prezzi in moneta estera dei beni esportati e sostenere così le esportazioni – e l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio (11 dicembre 2001), dopo un negoziato durato una quindicina di anni. L’entrata in tale organizzazione consentì al gigante asiatico di usufruire di tariffe più vantaggiose per l’export in cambio di dazi minori sull’import (e del rispetto di una serie di impegni poi in larga parte disattesi). I mercati occidentali furono così invasi da una massa di prodotti cinesi a basso costo, e ciò produsse conseguenze pesantissime per il tessile manifatturiero in Italia e quindi anche per il distretto locale.
Alla fine degli anni Novanta i segnali di sofferenza del settore si moltiplicarono: ai primi di marzo del 1999 gli operai pratesi in attesa di riscuotere la cassa integrazione ordinaria erano cinquemila e lo stillicidio delle chiusure e dei licenziamenti appariva inarrestabile. Ai primi di aprile risultavano in attività duecentosettanta filature per conto terzi (nel 1995 le filature erano trecentottanta e nel 1985 quattrocentocinquanta). Negli ultimi quattro anni avevano chiuso i battenti ben sessanta aziende di cardato. La struttura economica di Prato stava insomma subendo una trasformazione irreversibile, caratterizzata da una progressiva riduzione del peso del comparto tessile.
Ma questo non significava che fosse in crisi l’economia cittadina: nel dicembre del 2002, in occasione del tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti, il presidente della Provincia, Daniele Mannocci, e l’assessore al lavoro, Fabio Giovagnoli, rilevarono che, pur essendo indiscutibile la gravità della crisi in cui il tessile si dibatteva, nel periodo gennaio-novembre l’occupazione era aumentata di 3.882 unità e che tale aumento si doveva principalmente allo sviluppo di settori diversi da quelli tradizionali. Prato si stava insomma muovendo verso un nuovo assetto produttivo, verso lo stadio postindustriale, contraddistinto dall’incremento delle attività terziarie e dalla diminuzione degli addetti alle attività industriali. In questo quadro, il tessile non poteva certo riconquistare le posizioni perdute. Ne fanno fede alcuni dati resi noti ai primi di giugno del 2023, secondo i quali dal 2001 al 2021 le aziende tessili sono passate a Prato da 4.301 a 1.816 (-57%), mentre il numero degli addetti del comparto è sceso da cinquantamila a trentacinquemila.
Nella primavera del 2000 la crisi che attanagliava il tessile a Prato raggiunse anche il Lanificio Pecci, l’unico che, a quell’epoca, aveva ancora mantenuto il ciclo completo di lavorazione: la vicenda del Pecci può essere considerata come l’emblema di quanto stava allora accadendo in città.
La ditta era all’epoca una società in accomandita semplice con un fatturato di circa ottanta miliardi. A dirigerla era Pierluigi Marrani, affiancato da Enrico Biguzzi, Fabio Faggi, Piergiuseppe Gremmo ed Andrea Bini (che si occupava delle trattative con il governo per le commesse militari). La proprietà reagì alle difficoltà puntando sull’abbattimento dei costi attraverso i licenziamenti: al Pecci erano in forza circa trecento lavoratori ed i licenziamenti, annunciati il 27 aprile all’assemblea degli operai, erano trentacinque, concentrati nei seguenti reparti: filatura a pettine, tessitura, tintoria e rifinizione. Non erano previsti tagli fra gli impiegati. Le motivazioni addotte dall’azienda per giustificare il ridimensionamento erano il progressivo calo degli ordini (in particolare delle commesse militari) e l’onerosità dei costi fissi. L’obiettivo dichiarato era quello di ritrovare quanto prima l’equilibrio di bilancio, ma la mancanza di un preciso piano di rilancio preoccupava molto i lavoratori (il fatto di avere almeno in parte intercettato il malcontento degli operai per i licenziamenti che si profilavano all’orizzonte permise all’Unione libertaria pratese – un sindacato di ispirazione anarchica che aspirava a diffondere fra i lavortatori il concetto di autorganizzazione – di ottenere il 15% dei voti in occasione delle elezioni per il rinnovo della Rsu aziendale svoltesi il 7 febbraio 2000).
Il 24 maggio i lavoratori del Lanificio scioperarono dalle dieci alle undici per riunirsi in assemblea. Al termine della discussione fu approvato un documento in cui si chiedeva di proseguire il dialogo con la direzione che, fino ad allora, era stato infruttuoso (da un incontro svoltosi alcuni giorni prima non erano infatti emerse novità significative, tranne una generica proposta da parte dell’azienda di ridurre i tagli nella filatura a pettine). Non vennero proclamate altre ore di sciopero. Il 18 luglio le parti raggiunsero una soluzione di compromesso per la chiusura della vertenza. L’ipotesi di accordo fu approvata all’unanimità da un’assemblea svoltasi il 21: i lavoratori da porre in mobilità – che da trentacinque si erano ridotti a ventiquattro nel corso delle trattative – sarebbero stati tredici (la maggior parte dei quali “volontari”: nove lavoratori, fra cui alcune donne vicine all’età pensionabile, si erano infatti detti disponibili a lasciare il posto). I tagli si sarebbero concentrati nella tintoria matasse. L’accordo finale, sottoscritto il 27 luglio nella sede dell’Unione industriale pratese (Uip), recepiva in sostanza i termini della bozza di accordo. Esso prevedeva tredici licenziamenti (di cui dieci “volontari”, cioè accettati in cambio di incentivazioni all’esodo). I tagli erano concentrati nei reparti della filatura a pettine e della tintoria matasse, che venne esternalizzata. La proprietà si impegnava infine ad effettuare investimenti nel reparto rifinizione.
Ma il raggiungimento di questo accordo significò per i lavoratori del Pecci soltanto una tregua. Nell’estate del 2001 cominciarono difatti a circolare voci sempre più insistenti di ulteriori tagli al personale: il 25 luglio i sindacati furono informati delle intenzioni dell’azienda nel corso di un incontro svoltosi all’Uip. Verso la metà di settembre, la ditta, che contava allora duecentocinquanta dipendenti e sviluppava un fatturato di cento miliardi, aprì la procedura di mobilità per ben settantatré lavoratori. I tagli riguardavano tutti i reparti, ad eccezione dell’orditura, ed erano così distribuiti: cinquantadue in filatura a pettine (della quale era previsto lo smantellamento, a meno che non si fosse trovato un nuovo socio di minoranza cui affidarne la gestione), cinque in tessitura, due in tintoria, sette in rifinizione ed altrettanti nei servizi generali. La proprietà presentò contestualmente un piano di ristrutturazione che contemplava dieci miliardi di investimenti in due anni e la divisione dell’azienda in due società: una di filati per maglieria diretta da Marrani, ed un’altra, a capo della quale sarebbe andato Filippo Busi, nipote di Alberto Pecci, che, pur non abbandonando il settore tradizionale della drapperia, avrebbe puntato su una linea di tessuti donna di qualità medio-alta.
Le organizzazioni sindacali proclamarono per il 19 settembre un’ora e mezzo di sciopero con assemblee alla fine di ogni turno, dichiarandosi assolutamente contrarie alla chiusura della filatura a pettine. La nuova vertenza era molto più complicata, rispetto a quella conclusasi con l’accordo del 27 luglio 2000, perché, stavolta, pochi fra gli operai in esubero erano in procinto di accedere alla pensione e nella filatura a pettine (che la ditta voleva assolutamente chiudere, giudicandola non più competitiva) erano in forza molte donne, la cui ricollocazione sul mercato del lavoro non sarebbe certo stata semplice. Secondo l’azienda, i tagli erano funzionali alla riconversione su un prodotto per donna di qualità medio alta ed alla necessità di riprendere la produzione di divise militari in Romania, dove era stato aperto da poco un ufficio (le commesse militari, perdute a causa della concorrenza di altri paesi, erano state pari al 15% del fatturato dell’azienda nel biennio precedente). Il sindacato chiedeva che la filatura non cessasse l’attività, una verifica del numero degli esuberi ed infine la riqualificazione ed il riassorbimento in altre ditte dei licenziati.
Il primo incontro fra le parti, svoltosi il 21 settembre, ebbe un esito interlocutorio: la ditta si disse disponibile a cercare di ricollocare le persone che avrebbero perso il posto di lavoro, ma ribadì la volontà di chiudere la filatura. Il mondo della politica si interessò della grave controversia, ma senza ottenere risultati concreti. Il 25 settembre i lavoratori del Pecci scioperarono per un’ora e mezzo e tennero un’assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento, confermando la loro recisa opposizione alla chiusura della filatura a pettine. Il 5 ottobre ebbe luogo un nuovo incontro fra l’azienda ed i sindacati, che però non fece registrare alcun passo avanti nella trattativa. In seguito al fallimento di questo incontro, tre giorni dopo gli operai del Pecci si astennero per un’ora e mezzo dal lavoro, tenendo un’altra assemblea fuori dai cancelli della fabbrica.
Le parti tornarono ad incontrarsi il 17 ottobre e la difficile vertenza giunse finalmente ad un punto di svolta. Il giorno successivo il sindacato informò i lavoratori dei termini dell’ipotesi di accordo siglata con la controparte: gli esuberi scendevano da settantatré a trenta ed erano così ripartiti: diciotto in filatura, sei in rifinizione, uno in tintoria e cinque tra gli impiegati. I lavoratori da collocare in mobilità sarebbero stati scelti – in accordo con quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 23 (art. 5) – tenendo conto di tre parametri: il carico familiare, il maggiore o minore grado di anzianità e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative. La filatura a pettine non sarebbe rimasta all’interno della fabbrica, ma, conformemente al piano di ristrutturazione aziendale, sarebbe passata, dal 1° gennaio 2002, alla Pecci filati (una nuova azienda, diretta da Marrani, che sarebbe nata dallo scorporo delle attività filati dal Lanificio Pecci). La Pecci filati, più piccola della filatura che faceva parte del vecchio lanificio a ciclo completo, avrebbe lavorato non solo per l’altra azienda prevista dal piano di ristrutturazione (quella specializzata nella produzione di tessuti, di cui avrebbe preso le redini Filippo Busi) ma anche in conto terzi. L’Uip si impegnava formalmente a favorire la ricollocazione degli operai licenziati (quest’ultimo era un forte elemento di novità in quanto a Prato la parte datoriale non aveva mai assunto in precedenza un impegno del genere). Dopo l’approvazione della bozza di accordo da parte dell’assemblea dei lavoratori, l’intesa definitiva fu siglata il 29 ottobre da Marrani per la ditta, da Manuele Marigolli per la Cgil, da Calogero Aronica per la Cisl e da Angelo Colombo per la Uil. Così, in poco più di un anno, tra uscite volontarie e licenziamenti, la proprietà era riuscita a ridurre in modo consistente il numero dei dipendenti, ed anche l’intesa sottoscritta il 29 ottobre poteva dirsi, dal suo punto di vista, soddisfacente dato che, stando a quanto fonti aziendali avevano lasciato trapelare, pur avendo parlato di settantatré esuberi, il vero obiettivo della ditta era quello di ottenerne fra i trantacinque ed i cinquanta.
Ma la serie dei tagli non era finita. Come si è accennato, dal piano di ristrutturazione aziendale del 2001 erano scaturite due ditte, e precisamente la Pecci filati (diretta da Marrani) e la Pecci tessuti (diretta da Busi). Ai primi di dicembre del 2002 quest’ultima informò le organizzazioni sindacali della necessità di ridurre il personale a causa della diminuzione del fatturato. Stavolta gli esuberi erano una ventina e sarebbero stati distribuiti in tutti i reparti, ma, stando alle voci che circolavano, essi si sarebbero concentrati soprattutto in tessitura ed in tintoria. Quanto alla tessitura (anche se negli ultimi anni erano stati acquistati nuovi telai, assunti nuovi tecnici e si era cominciato distinguere la tessitura vera e propria da quella a campioni), sarebbe stato eliminato il turno di notte. La tintoria in rocche era invece destinata alla chiusura: il lavoro scarseggiava e nell’arco di una giornata lavorativa veniva tinto solo qualche chilo di filato, a fronte di una potenzialità di quattromila chili al giorno. I tagli avrebbero forse interessato anche la tintoria in pezze, la rifinizione e gli uffici. Era questa un’altra tappa del processo di disimpegno della proprietà dal settore tessile, in linea con la strategia di diversificazione già avviata negli anni Sessanta con l’acquisto di una quota rilevante della Segnalamento marittimo ed aereo, una ditta che produceva radar per uso militare.
Il processo di ridimensionamento dell’azienda si concluse nel giro di qualche anno col suo smantellamento, reparto dopo reparto. Oggi – anche se la Pecci filati è ancora aperta a Capalle e, con un numero di dipendenti stimabile fra venti e quarantanove, rientra nella classe di fatturato che va dai tredici ai venticinque milioni di euro – la famiglia Pecci ha interessi in vari settori ed il tessile non è più il suo core business. Di particolare rilievo è il ruolo di Alberto Pecci all’interno della El.En., una società per azioni con sede a Calenzano che si occupa della produzione di sistemi laser: Pecci possiede infatti il 10,40% delle azioni e siede in consiglio d’amministrazione. Per avere un’idea dell’importanza di questa azienda, basti pensare che, fondata a Firenze nel 1981, la El.En. è oggi capofila di un gruppo formato da più di trenta imprese sparse in tutto il mondo: al 31 dicembre 2020 il gruppo vantava un fatturato consolidato di circa quattrocentodieci milioni di euro, un utile netto consolidato di venti milioni ed impiegava circa milleseicento dipendenti, di cui settecento in organico alla capogruppo.