Il lavoro femminile a Campo Tizzoro

La Società Metallurgica Italiana – Smi – nacque il 14 aprile 1886 a Roma. Già a partire dall’anno seguente iniziarono ad aprire i primi stabilimenti in Toscana e di particolare rilevanza furono quelli della Montagna Pistoiese: Limestre, Mammiano e Campo Tizzoro. La costruzione di quest’ultimo iniziò nel 1910 e divenne operativo a partire dall’anno seguente. Campo Tizzoro, trovandosi in un fondovalle isolato e stretto tra ripidi monti, veniva considerato un posto protetto da possibili attacchi, era inoltre una zona in cui era presente abbondante «manodopera a basso costo, di provenienza rurale e perciò non ancora politicizzata o sindacalizzata».
L’arrivo della Smi sull’Appenino toscano produsse numerosi cambiamenti a livello sia sociale che culturale: migliaia di persone vennero inserite nel lavoro salariato in zone rurali e montane, inoltre, nel 1915, la Smi contribuì alla costruzione della Ferrovia Alto Pistoiese e anche al finanziamento della rete telefoninca sulla montagna. Ciò che caratterizzava gli stabilimenti della Smi nella zona della Montagna era «l’autoritario disciplinamento delle maestranze, la volontà di consolidare nei lavoratori un sentimento di appartenenza all’azienda e di acquietare insubordinazioni», cose che vennero conseguite sia all’interno che all’esterno della fabbrica. Se da una parte la Smi era dunque centro propulsore del miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti e oprattutto degli operai della zona, dall’altra imponeva una presenza quasi autoritaria. A tal proposito, la Società realizzò numerose infrastrutture sociali che avevano lo scopo di pianificare la vita dei dipendenti e della comunità a vari livelli: culturale, ricreativo, sportivo, didattico. A Campo Tizzoro – zona deserta prima dell’avvento dello stabilimento industriale – venne per esempio creato quello che fu battezzato “Villaggio Orlando”, che racchiudeva istituti scolastici, impianti sportivi, ma anche un museo, una biblioteca, una chiesa, oltre a numerosi alloggi per le famiglie. Venivano organizzati corsi serali di scuola elementare per gli operai e le operaie analfabeti, oltre al cinematografo e alla filodrammatica.
Durante la Prima guerra mondiale, la Smi fu la principale fornitrice delle munizioni per l’esercito e la marina, in quel periodo venne inoltre avviata la costruzione del nuovo impianto di Fornaci di Barga, che cominciò a produrre nel giugno 1916. In occasione dei periodi bellici, la Società metallurgica era stata dichiarata «industria ausiliaria», per questa ragione usufruì non solo di agevolazioni nell’approvigionamento di materie prime e di privilegi relativi alla manodopera, ma anche dell’esonero delle maestranze maschili dal servizio militare, cosa che ebbe sicuramente delle conseguenze nella vita delle comunità locali.
Negli anni Venti, la produzione della Smi non fu costante: nel 1926, in seguito a un momento di crisi, recuperò, per poi retrocedere nuovamente con la crisi del ’29, tanto che a Campo Tizzoro le maestranze erano circa 700 nel 1927, mentre nel 1930 passarono a essere solo 126.
Per quel che riguarda il rapporto della fabbrica di Campo Tizzoro con il fascismo, soprattutto nel periodo dalla guerra di Spagna, emerse l’avversione verso il regime, tanto che nel 1943 cominciarono i rallentamenti per sabotare la produzione di munizioni e in seguito la S.A.P. – Squadra di Azione Patriottica – utilizzò le gallerie sotterranee della fabbrica per trafugare viveri, armi e munizioni destinate ai partigiani. Anche a Fornaci si registrano posizioni antifasciste tra gli operai.
Seguì, nel secondo dopoguerra, un momento di crisi e una diminuzione della manodopera, che portò a numerose mobilitazioni e proteste nel pistoiese in opposizione ai licenziamenti. Complice sicuramente anche il clima che si respirava a livello nazionale e internazionale in quegli anni, ci fu un inaspriamento del rapporto tra lavoratori e direzione aziendale, oltre a forti discriminazioni in base all’appartenenza politica: per esempio a Campo Tizzoro i comunisti furono i primi a essere licenziati.
Nel 1976, la Metallurgia Italiana si dotò di una nuova organizzazione finanziaria e le imprese produttive vennero concentrate nel gruppo La Metalli Industriale S.p.A (Lmi), così che la Smi diventò holding di un gruppo industriale metallurgico internazionale.
Una particolarità dell’industria metalmeccanica della zona della Montagna Pistoiese fu la forte presenza femminile, soprattutto a partire dal periodo del primo conflitto mondiale: nel 1918 le donne a Campo Tizzoro rappresentavano il 44,7% della manodopera, ma già da prima della Grande Guerra vi era comunque una partecipazione femminile considerevole all’interno dell’industria. Nonostante il brusco calo dell’occupazione delle donne nel secondo dopoguerra, il ruolo avuto dalle operaie precedentemente aveva permesso loro di creare un rapporto molto stretto con la fabbrica, di conseguenza iniziarono a ottenere ruoli sempre più importanti e maggiori responsabilità all’interno degli stabilimenti.
Fu proprio a Campo Tizzoro che Gabriella Venturi – sindacalista attiva tra fine anni ’60 e inizi 2000 – mosse i primi passi all’interno della fabbrica. Le vicende che hanno caratterizzato la sua vita sono ricostruibili attraverso i pochi documenti di archivio conservati, ma anche grazie alle parole di chi l’ha conosciuta personalmente: amici, compagni e parenti.
Gabriella nacque il 29 dicembre 1942 a Pistoia e visse tutta la vita a Pracchia, in via Fontana, dove, non essendosi mai sposata, abitò con i genitori. Non si ha una data precisa del suo ingresso alla Smi di Campo Tizzoro come operaia, probabilmente ciò avvenne attorno ai diciotto anni. Per quel che riguarda l’istruzione, sappiamo che Gabriella portò a termine il perscorso della scuola media, ma non frequentò mai le superiori, e, presubilmente, prima di iniziare il suo percorso nell’industria metallurgica, svolse qualche lavoro saltuario.
 Proveniente da una famiglia profondamente credente, inizialmente s’iscrisse alla Cisl, in quanto sindacato più vicino al mondo cattolico e quindi alla sensibilità con la quale era cresciuta. In seguito avvenne il passaggio dalla Cisl alla Cgil, nei primi anni Settanta, un passaggio che, nelle loro interviste, Renzo Innocenti e Simonetta Bartoletti descrivono come qualcosa che avvenne in maniera naturale e repentina[1]. La nipote Simonetta sottolinea il fatto che la svolta, quindi il passaggio dal sindacato cattolico alla Cgil, all’interno della famiglia di Gabriella aveva avuto un certo peso, quasi come se la donna avesse tradito alcuni ruoli e alcuni valori con i quali era cresciuta. Simonetta racconta che il padre di Gabriella si ritrovò presto a dover fare i conti con la realtà e ad adeguarsi a essa: i tempi erano cambiati e le cose «stavano andando avanti più vivacemente rispetto a quello che lui aveva vissuto». La trasformazione di Gabriella fu radicale: non solo entrò nella Cgil, ma si iscrisse al Partito comunista italiano nel 1974. Oltre a essere iscritta al Pci, la nipote Simonetta riporta che Gabriella, nel 1984, era iscritta anche all’Anpi. Purtroppo non ci sono elementi che permettono di attestare se fosse iscritta anche precedentemente.
Proveniente da una famiglia profondamente credente, inizialmente s’iscrisse alla Cisl, in quanto sindacato più vicino al mondo cattolico e quindi alla sensibilità con la quale era cresciuta. In seguito avvenne il passaggio dalla Cisl alla Cgil, nei primi anni Settanta, un passaggio che, nelle loro interviste, Renzo Innocenti e Simonetta Bartoletti descrivono come qualcosa che avvenne in maniera naturale e repentina[1]. La nipote Simonetta sottolinea il fatto che la svolta, quindi il passaggio dal sindacato cattolico alla Cgil, all’interno della famiglia di Gabriella aveva avuto un certo peso, quasi come se la donna avesse tradito alcuni ruoli e alcuni valori con i quali era cresciuta. Simonetta racconta che il padre di Gabriella si ritrovò presto a dover fare i conti con la realtà e ad adeguarsi a essa: i tempi erano cambiati e le cose «stavano andando avanti più vivacemente rispetto a quello che lui aveva vissuto». La trasformazione di Gabriella fu radicale: non solo entrò nella Cgil, ma si iscrisse al Partito comunista italiano nel 1974. Oltre a essere iscritta al Pci, la nipote Simonetta riporta che Gabriella, nel 1984, era iscritta anche all’Anpi. Purtroppo non ci sono elementi che permettono di attestare se fosse iscritta anche precedentemente.
Venne licenziata, per motivi non del tutto chiari, dalla Smi di Campo Tizzoro probabilmente nel 1983 o nel 1984, infatti le ultime attestazioni della sua presenza nella fabbrica trovate in archivio risalgono al 27 gennaio 1983, quando venne eletta, come anche precedentemente, nel reparto Nastro[2]. Nei primi anni Ottanta, all’interno della Lmi vennero eliminati migliaia di posti di lavoro, tanto che si passò dai circa 7’000 occupati nel 1980 ai 3’000 nel 1985. Dopodichè la ritroviamo assunta in Cgil il 2 gennaio 1985 e Simonetta Bartoletti afferma che Gabriella è stata la prima donna in Segreteria Confederale, cosa che, purtroppo, non si può confermare attraverso i documenti consultati.
 Renzo Innocenti – segretario provinciale quando Gabriella faceva parte della segreteria Fiom – nella sua intervista racconta che il suo primo incontro con Venturi avvenne nel periodo dell’autunno caldo, in occasione di un’occupazione – probabilmente la prima – dell’Istituto tecnico industriale di Pistoia frequentato dallo stesso Renzo. Gabriella, già dipendente della Smi di Campo Tizzoro, arrivò alla scuola con una delegazione. Si tratta di un evento che conferma il fatto che anche a Pistoia il movimento degli studenti aprì un fronte di confronto e unità con gli operai. Innocenti afferma che, fin dall’inizio, Gabriella gli diede l’impressione di essere una combattente, una persona molto concreta, pragmatica, tenace e una donna che emergeva in un mondo di uomini. Del suo animo guerriero si hanno delle attestazioni grazie ai documenti di archivio. A tal proposito, colpisce un evento in particolare: durante le assemblee di fabbrica del 20 ottobre 1971, viene indetto, attraverso il volantino «No! Ai 400 licenziamenti», uno sciopero per il giorno seguente. In quell’occasione, insieme ad alcuni compagni, Gabriella venne accusata di aver organizzato una manifestazione non autorizzata, di aver ostacolato la libera circolazione e di avere usato violenza contro alcune guardie giurate. Per queste ragioni, venne citata a comparire il 21 novembre 1973.
Renzo Innocenti – segretario provinciale quando Gabriella faceva parte della segreteria Fiom – nella sua intervista racconta che il suo primo incontro con Venturi avvenne nel periodo dell’autunno caldo, in occasione di un’occupazione – probabilmente la prima – dell’Istituto tecnico industriale di Pistoia frequentato dallo stesso Renzo. Gabriella, già dipendente della Smi di Campo Tizzoro, arrivò alla scuola con una delegazione. Si tratta di un evento che conferma il fatto che anche a Pistoia il movimento degli studenti aprì un fronte di confronto e unità con gli operai. Innocenti afferma che, fin dall’inizio, Gabriella gli diede l’impressione di essere una combattente, una persona molto concreta, pragmatica, tenace e una donna che emergeva in un mondo di uomini. Del suo animo guerriero si hanno delle attestazioni grazie ai documenti di archivio. A tal proposito, colpisce un evento in particolare: durante le assemblee di fabbrica del 20 ottobre 1971, viene indetto, attraverso il volantino «No! Ai 400 licenziamenti», uno sciopero per il giorno seguente. In quell’occasione, insieme ad alcuni compagni, Gabriella venne accusata di aver organizzato una manifestazione non autorizzata, di aver ostacolato la libera circolazione e di avere usato violenza contro alcune guardie giurate. Per queste ragioni, venne citata a comparire il 21 novembre 1973.
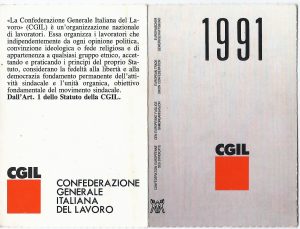 Gabriella aveva inoltre un’attenzione e un legame profondo nei confronti della Montagna Pistoiese, sentiva la necessità di scommettere su un suo ruolo più forte e visibile, in modo tale da contribuire a contrastare la perdita del ruolo industriale e manifatturiero dovuto al ridimensionamento della presenza della Smi, ma voleva anche impedire la chiusura di aziende occupate in altri settori nella zona della Montagna. Nonostante Renzo Innocenti non ricordi che Gabriella abbia mai seguito le lavoratrici a domicilio, in un documento risalente al 21 maggio 1985 e a lei destinato, emerge che la donna era stata nominata come componente della Commissione Comunale per il lavoro a domicilio «per il comune di San Marcello Pistoiese in rappresentanza dei lavoratori».
Gabriella aveva inoltre un’attenzione e un legame profondo nei confronti della Montagna Pistoiese, sentiva la necessità di scommettere su un suo ruolo più forte e visibile, in modo tale da contribuire a contrastare la perdita del ruolo industriale e manifatturiero dovuto al ridimensionamento della presenza della Smi, ma voleva anche impedire la chiusura di aziende occupate in altri settori nella zona della Montagna. Nonostante Renzo Innocenti non ricordi che Gabriella abbia mai seguito le lavoratrici a domicilio, in un documento risalente al 21 maggio 1985 e a lei destinato, emerge che la donna era stata nominata come componente della Commissione Comunale per il lavoro a domicilio «per il comune di San Marcello Pistoiese in rappresentanza dei lavoratori».
Il rapporto di Venturi con il movimento femminista è interessante, dal momento che, a partire dal secondo dopoguerra, in Italia ci fu un radicale mutamento all’interno dei sindacati, sia della partecipazione femminile, sia dell’organizzazione delle strutture delle donne. La maggior parte della nuova generazione delle sindacaliste aveva preso parte alle vicende che avevano caratterizzato il loro tempo: avevano beneficiato della scolarizzazione di massa e in molte avevano preso parte al movimento del 1968. Si erano inoltre distanziate e avevano iniziato a guardare con scetticismo alcune posizioni delle loro precorritrici. Dall’intervista di Renzo Innocenti emerge però il fatto che Venturi non sembrerebbe aver mai avuto stretti rapporti con il femminismo, anzi, in diverse occasioni pare abbia criticato alcune posizioni radicali del movimento. Simonetta Bartoletti ricorda che Gabriella era spesso in giro, in diverse occasioni si recava anche all’estero, e più che cercare di trovare un proprio spazio in quanto donna all’interno del sindacato, con i suoi tempi e le sue differenze, sembrava piuttosto voler adeguarsi a uno stile di vita che solitamente caratterizzava la sfera maschile. Era sicuramente molto legata alla famiglia, ma allo stesso tempo era sempre sui fronti, passava poco tempo in casa. Non erano molte le donne disposte a dedicare tutto il loro tempo a un impegno così totalizzante e questo fu sicuramente un elemento che colpiva tutti coloro con i quali si trovava a confrontarsi Gabriella. Nonostante questa presa di distanza dal movimento femminista, Gabriella era comunque consapevole delle difficoltà, delle differenze e delle disparità di genere all’interno del movimento sindacale per i ruoli di responsabilità e di direzione.
Andata in pensione nei primissimi anni 2000, Gabriella si spense nel 2002, ma il suo ricordo è sopravvisuto a lei. Una prova dell’affetto e dell’importanza che ha avuto la donna all’interno del sindacato si ha in occasione della tredicesima edizione di CGIL INCONTRI del 2009, che si svolse tra il 23 giugno e il 5 luglio. L’incontro del 2 luglio con i ragazzi del campo di lavoro Liberarci dalle Spine s’intitolava «….dedicato alla Lella (Gabriella Venturi) “Racconti di lotte al femminile”», coordinato da Maria Cangioli e con la partecipazione di Anna Goretti.
Martina Lopa studia storia all’Università di Firenze, dove sta lavorando a una testi di laurea sulle prime organizzazioni femminili e l’animalismo nell’800, e collabora con la Fondazione Valore Lavoro, per la quale sta curando una mostra sul 70° anniversario della prima Conferenza nazionale della donna lavoratrice svoltasi a Firenze il 23-24 gennaio 1954.









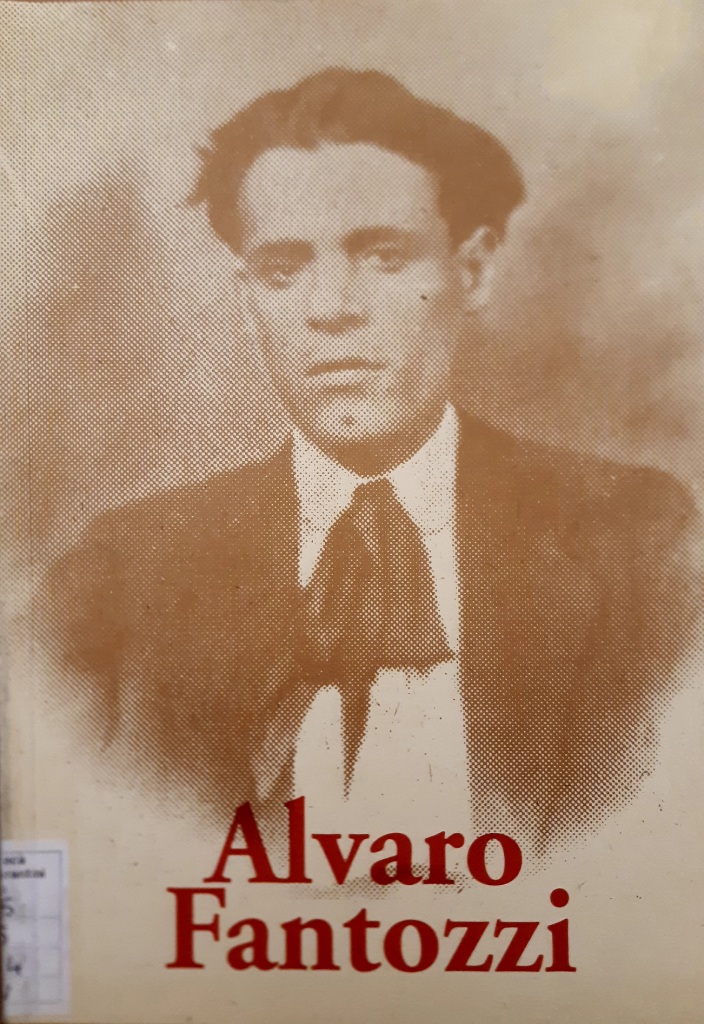




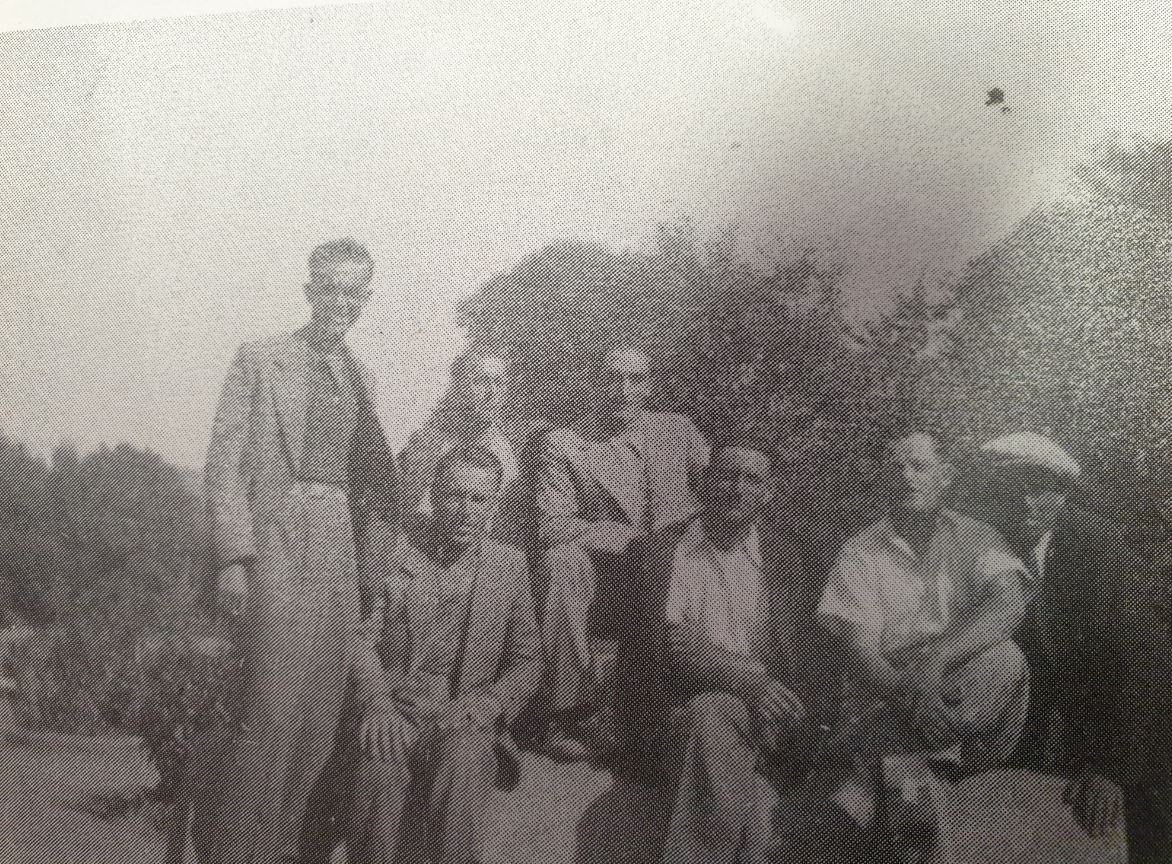
![Antifascisti grossetani nel 1928. Da sx in piedi: Attilio Vitali, Gino Franchi, Paolino Ancarani, Luigi Franchi, [...], Artino Meconcelli, Ferdinando Nardini, Adamo Tonini, Augusto Boschi,. Da sx seduti: Dino Berti, Pietro Ginanneschi (pHOTO CREDITS: a.- bANCHI, sI VA PEL MONDO)](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2021/10/antifascisti-grossetani-3.jpg)

