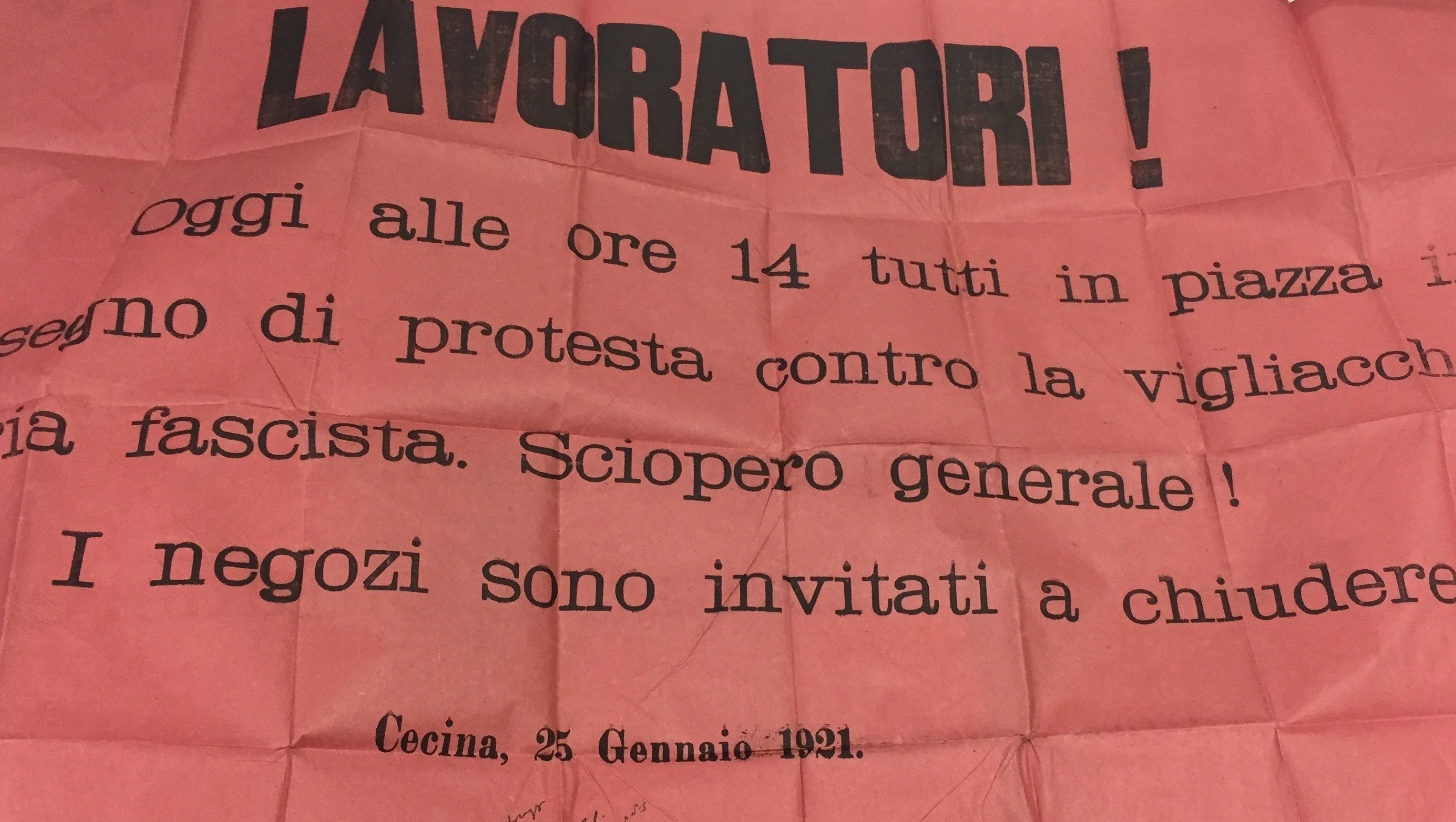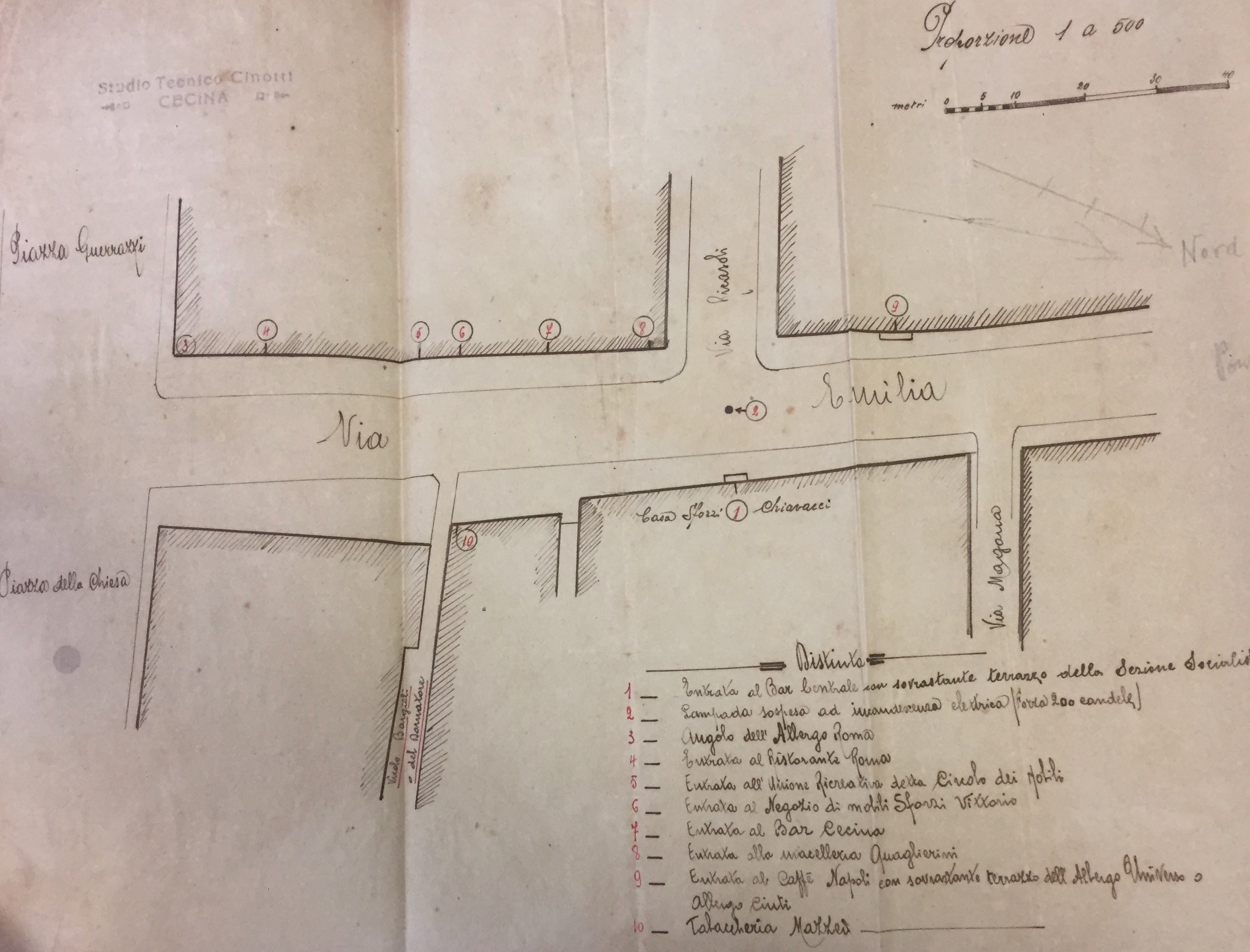Dirty dancing: balli “peccaminosi” alla Casa del popolo di Tobbiana

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, una novità esplosiva irruppe sulla scena musicale dell’Italia del Boom: il rock’ n’ roll faceva infatti la sua comparsa nella Penisola, dove avrebbe trovato un’intera generazione pronta a scatenarsi al suo ritmo dirompente.
Questa tendenza musicale proveniente dagli Stati Uniti andò subito diffondendosi nell’Italia del Miracolo: infatti, i giovani del Boom prediligevano, nei loro gusti musicali, suoni dai tratti “esotici” che, almeno all’inizio, provenivano da cantanti statunitensi (come Neil Sedaka e Paul Anka). Il rock’ n’ roll trovò di lì a breve un equivalente locale nei cosiddetti “urlatori”- Adriano Celentano, Giorgio Gaber, Mina e molti altri – che sfidarono a colpi di grida e note musicali i cantanti melodici tradizionali. Questi nuovi ritmi contribuirono fortemente a definire l’identità di una generazione che considerava la sfera ricreativa come un luogo essenziale per la creazione della propria identità.
È dalla campagna che analizzerò il rapporto che si creò fra le Case del popolo e la diffusione, fra la generazione del Miracolo, della passione per la musica e per il ballo. Prendendo infatti come esempio la Casa del popolo di Tobbiana (posta nel comune di Montale, in provincia di Pistoia), vedremo come queste istituzioni ebbero un ruolo decisivo nell’accompagnare la gioventù di allora nei suoi “balli peccaminosi”.
Era il 1965 quando fu inaugurata la grande sala della Casa del popolo di Tobbiana. Adesso anche in paese c’era un luogo dove ritrovarsi per convegni, conferenze e… ballare! La domenica, dalle 21.00 in poi, i giovani danzavano sulle note di Jimmy Fontana, di Don Backy, di Little Tony. La serata di inaugurazione fu un grande evento per il paese: nasceva così il Dancing La Roccia.
Molti amori sono nati sulle canzoni suonate al Dancing La Roccia, dove i cuori dei giovani palpitavano a ritmo di musica. Vi è da fare però un’importante precisazione. Ancora alla metà degli anni Sessanta, il paese di Tobbiana restava diviso fra lo schieramento comunista e quello democristiano. I democristiani evitavano di recarsi alla Casa del popolo, e proibivano ai loro figli di frequentarla: infatti, i giovani provenienti da famiglie democristiane non andavano al Dancing La Roccia. In particolare, erano le ragazze a non recarsi a ballare alla Casa del popolo del paese.
Ciò non accadeva solo a Tobbiana: infatti, le ragazze di provenienza democristiana non ballavano in generale. Ancora nel secondo dopoguerra, il ballo era visto dalla Chiesa cattolica come un “diabolico trattenimento”. I balli sono sempre dannosi, a maggior ragione per le donne. È l’essenza stessa del ballo che mette a repentaglio la virtù delle giovani: la vicinanza dei corpi avrebbe infatti portato a uno scoppio dei “bassi istinti” e, di conseguenza, a una relazione sessuale. Per le adolescenti, a cui è richiesta la salvaguardia delle verginità, la cosa migliore sarebbe perciò evitare i balli. Chi, al contrario, si reca a ballare, sa già di poter perdere l’illibatezza e, con essa, la possibilità di un matrimonio soddisfacente. Ma, anche se la verginità non dovesse essere perduta, anche la sola “compromissione coi balli” precluderebbe alla donna la possibilità di trovare un uomo disposto a sposarla: questo spiega il gran numero di sermoni cattolici che insistevano sul tema del ballo peccaminoso, destinato a condannare le impenitenti ballerine alla condizione di sedotte e abbandonate o inevitabili zitelle.
Certamente, alla metà degli anni Sessanta, il condizionamento della Chiesa sulla morale era ancora molto forte, soprattutto nei riguardi del sesso femminile. Del resto, la maggior parte della popolazione italiana avrebbe condiviso ancora a lungo la tradizionale mentalità maschilista e misogina, che prescindeva dal colore politico di appartenenza. Ma vi è da dire che, nei confronti della musica e del ballo, i comunisti potevano vantare, rispetto ai democristiani, una mentalità più aperta e un’esperienza ventennale, iniziata nell’immediato secondo dopoguerra.
Infatti, dopo la fine del conflitto, i primi locali danzanti “popolari” nacquero proprio nelle Case del popolo: e quella di Tobbiana non fece eccezione. Già nel 1947, la dirigenza prese in affitto un piccolo appezzamento di terreno dove costruire una pista da ballo all’aperto. Nacque allora il Dancing Fico Verdino, grazie al quale i paesani giovani e meno giovani poterono riscoprire la loro capacità di divertirsi dopo una guerra particolarmente dura e sanguinosa. Osservando i tobbianesi ballare al Fico Verdino, possiamo notare come la dirigenza della Casa del popolo non fosse mai stata chiusa nei riguardi della dimensione ricreativa – ma che, anzi, avesse creato essa stessa dei momenti di svago per tutta la popolazione. Il Dancing La Roccia pare essere la naturale evoluzione del piccolo Dancing Fico Verdino.
La direzione della Casa del popolo sapeva bene che la grande sala sarebbe divenuta il luogo dove i giovani avrebbero finito per ballare “a ritmo di rock”. Sebbene i ragazzi e le ragazze, al Dancing La Roccia, non restassero mai da soli senza gli adulti (gli attivisti “anziani”, i genitori che accompagnavano a ballare i loro figli), è indubbio che, in generale, da parte dei comunisti vi fosse una maggiore apertura riguardo ai “balli peccaminosi” che tanto preoccupavano la controparte democristiana e la Chiesa cattolica.
Insomma, possiamo dire che, per il paese di Tobbiana come per tante altre realtà simili, fu proprio la Casa del popolo a costituire il primo e più importante luogo di diffusione, fra i giovani, dell’amore per il ballo (peccaminoso!). Di lì a breve, ognuno di loro avrebbe preso la propria strada. Ma, nonostante il fatto che la vita li avrebbe poi portati verso altri luoghi ed esperienze, quei ragazzi e quelle ragazze non avrebbero mai dimenticato quei giorni spensierati trascorsi ballando alla Casa del popolo di Tobbiana.
Daniela Faralli si è laureata all’Università di Firenze in storia contemporanea, con una tesi sulle case del popolo negli anni ’50 e ’60. Attualmente è consigliere dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia.
Articolo pubblicato nell’ottobre del 2018.