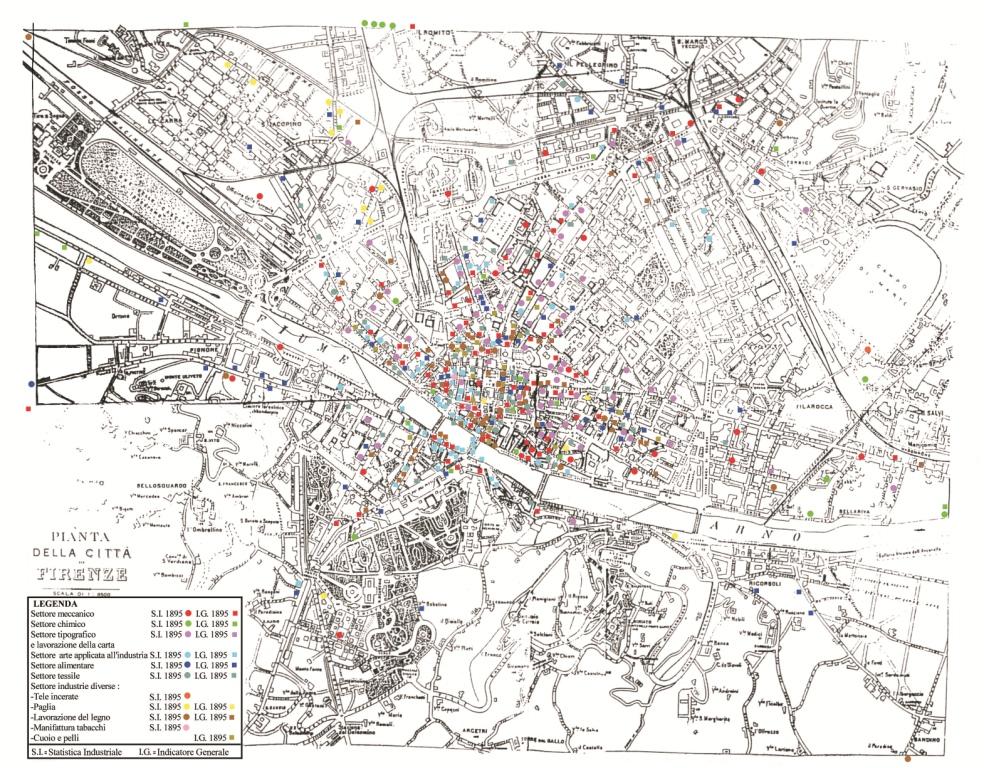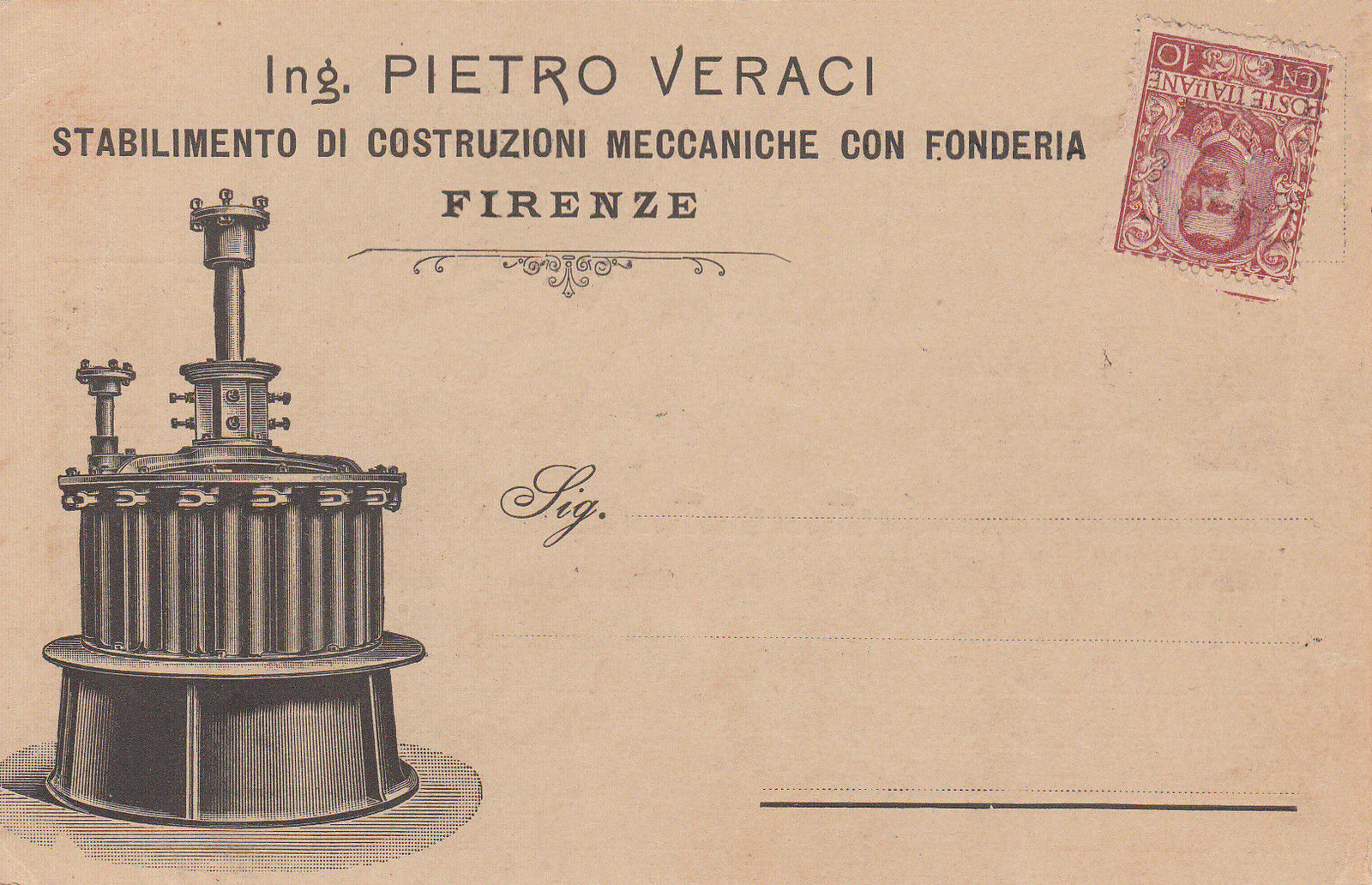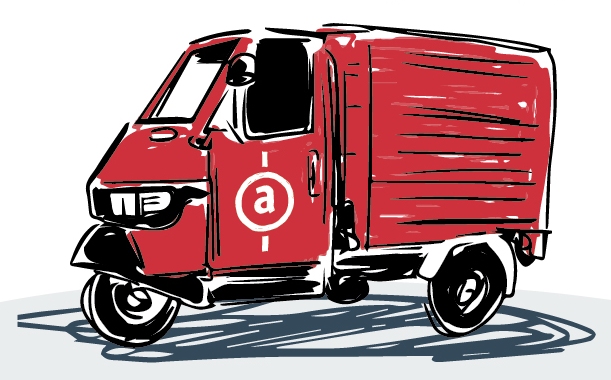13 aprile 1921: l’assassinio di Carlo Cammeo, segretario della Federazione socialista di Pisa

A Porta Nuova, in via Contessa Matilde sull’edificio della Circoscrizione n. 6, è posta una lapide che porta il seguente testo:
“Per sicaria mano fascista / cadeva assassinato / il 13 aprile 1921 / Carlo Cammeo / glorificando col sangue / la santità della scuola / e la sua fede nell’idea socialista / la giunta municipale di Pisa / all’alba della libertà / interpretando i sentimenti della cittadinanza”.
L’edificio in cui è murata la lapide è l’ex scuola dove insegnava Carlo Salomone Cammeo (nato a Tripoli il 6 maggio 1897) e dove fu assassinato. La via che oggi dall’incrocio di Porta Nuova si congiunge a Piazza Manin è dedicata al militante socialista e, dove è sepolto Cammeo – ebreo e ateo –, sul monumento funebre è incisa una falce e martello su di un libro aperto, caso unico per il cimitero israelitico. A parte la strada, la lapide e la tomba con i suoi simboli, oggi a Pisa resta ben poca cosa della memoria di Cammeo. All’epoca dei fatti il suo nome però era ben conosciuto e nonostante la giovane età aveva alle spalle già un discreto curriculum vitae, tanto da ricoprire ruoli importanti ai vertici del Partito socialista. La sua tragica morte segnò una svolta nella storia politica e sociale della città della torre pendente, che fu contrassegnata negli anni seguenti dall’affermarsi della violenza fascista e statale contro il movimento dei lavoratori e le sue organizzazioni politiche.
La guerra civile scatenata dai fascisti, con la complicità di buona parte delle forze dell’ordine dello Stato liberale, fu una risposta politica e militare alle lotte del “Biennio rosso” (1919-1920). Il primo dopoguerra fu caratterizzato da una grande partecipazione popolare, spesso spontanea, alle lotte di rivendicazioni salariali e sociali. Si era creato un clima diffuso di attesa per un cambiamento radicale della società, si aspettava l’esplodere della rivoluzione, com’era successo in Russia nel 1917 e questo aveva fortemente intimorito le classi dirigenti che sembravano impotenti a contrastare tale movimento. La nascita del fascismo toscano, la riorganizzazione delle organizzazioni padronali e la ripresa su vasta scala della repressione statale coincise con il declinare dell’iniziativa politica delle forze della sinistra che non seppero cogliere l’occasione per dare una svolta al paese. La violenza fascista e statale aprì un periodo, che per numero di vittime e di distruzioni, potremmo definire il “Biennio nero” (1921-1922) e che segnò la fine della democrazia liberale.
La Toscana nei primi mesi del 1921 fu attraversata da uno scontro violentissimo tra le squadre di fascisti, organizzate soprattutto dalla direzione fiorentina del movimento, e le forze della sinistra, anarchici, comunisti, socialisti e sindacalisti. Angelo Tasca in un suo noto volume sulla nascita del fascismo afferma che nei primi sei mesi del 1921 in Toscana furono distrutti 137 edifici: 11 case del popolo, 15 camere del lavoro, 11 cooperative, 70 circoli socialisti e comunisti, 24 circoli operai e ricreativi, 2 società mutue, 1 sindacato operaio e 3 redazioni di periodici.
Pisa non fu esente da quest’ondata di violenza. Il fascismo locale, riorganizzatosi da poco dopo una prima infruttuosa esperienza, guidato dal capitano Bruno Santini, ex ardito di guerra originario di Carrara, aveva raggiunto la notorietà all’inizio del 1921 con l’attacco alla nuova Giunta provinciale guidata da Ersilio Ambrogi socialista – poi comunista –. Il fascismo trovò consensi fra gruppi di studenti, ex militari, liberi professionisti, esponenti delle forze dell’ordine – soprattutto carabinieri – e giovani esponenti delle principali famiglie benestanti tra cui alcuni della comunità ebraica.
Il 25 marzo 1921 da Pisa una squadra di fascisti parte dirigendosi a Lucca e precisamente a Ponte a Moriano. Scopo della missione è di dar man forte ai camerati locali per togliere dalla sede del circolo ricreativo socialista il simbolo dei “soviet”, cioè la falce e martello. L’obiettivo è raggiunto ma gli operai avuta notizia del fatto corrono in paese e i fascisti si danno alla fuga; alcuni di loro rimangono staccati dal gruppo principale a causa di un guasto all’autocarro su cui viaggiano e ben presto vengono circondati dagli operai. Nasce una rissa e alla fine a terra rimane ferito mortalmente il fascista pisano Tito Menichetti. Sulla dinamica della sua morte ci sono versioni discordanti, il processo, che si tenne un anno dopo i fatti, individuò come unico responsabile il ferroviere Giuseppe Neri, originario di Castagneto Carducci, che subisce una condanna a 17 anni e 7 mesi di reclusione.
Pisa venne listata a lutto, un manifesto fascista invitava allo scontro:
“Cittadini. Si muore per voi. Si muore per salvare la nostra Italia travagliata dalla rovina e dal terrore ove tentano di trascinarla i folli criminali del comunismo e dell’anarchia per ricondurla sulla via della pace e del lavoro. Fascisti! Il corpo sanguinante di un’altra giovane vita si frappone fra noi ed i nostri nemici. Nessuno pianga. Nessuno si pieghi di fronte alla bara. Tutti in piedi! Con la fronte alta giuriamo. Tito Menichetti sarà vendicato! Senza pietà!”.
Lo stesso Bruno Santini durante i funerali incita pubblicamente alla vendetta.
 Carlo Cammeo scrisse un articolo sul settimanale socialista pisano «L’Ora nostra» del 1° aprile 1921, in risposta alle minacce fasciste, nel quale si richiamavano le responsabilità di chi, sulla morte di Tito Menichetti, stava imbastendo una “indegna speculazione patriottica”. È un j’accuse che espone il giovane socialista alla reazione fascista, che non si farà attendere. Un nuovo articolo di Cammeo, uscito sul numero successivo del settimanale, nel quale si ironizzava sulla partecipazione di alcune donne alle marce fasciste, fa scattare la vendetta fascista: la mattina del 13 aprile Mary Rosselli-Nissim e Giulia Lupetti raggiungono la scuola dove sta insegnando Cammeo e con una scusa lo invitano ad uscire dalla classe. Il maestro appena raggiunto il cortile è fatto segno di due colpi di pistola, sparati dal fascista Elio Meucci, cade a terra esangue, di fronte ai bimbi terrorizzati, mentre il gruppo di fascisti si dilegua repentinamente.
Carlo Cammeo scrisse un articolo sul settimanale socialista pisano «L’Ora nostra» del 1° aprile 1921, in risposta alle minacce fasciste, nel quale si richiamavano le responsabilità di chi, sulla morte di Tito Menichetti, stava imbastendo una “indegna speculazione patriottica”. È un j’accuse che espone il giovane socialista alla reazione fascista, che non si farà attendere. Un nuovo articolo di Cammeo, uscito sul numero successivo del settimanale, nel quale si ironizzava sulla partecipazione di alcune donne alle marce fasciste, fa scattare la vendetta fascista: la mattina del 13 aprile Mary Rosselli-Nissim e Giulia Lupetti raggiungono la scuola dove sta insegnando Cammeo e con una scusa lo invitano ad uscire dalla classe. Il maestro appena raggiunto il cortile è fatto segno di due colpi di pistola, sparati dal fascista Elio Meucci, cade a terra esangue, di fronte ai bimbi terrorizzati, mentre il gruppo di fascisti si dilegua repentinamente.
L’autore dell’assassinio è uno studente di farmacia dell’Università di Pisa mentre le due donne sono figlie di alti ufficiali del distaccamento militare. In particolare la Lupetti, che pochi mesi dopo per i suoi meriti sarà nominata segretaria del fascio femminile, è figlia del comandante del presidio militare. I fascisti responsabili della morte di Cammeo, grazie alla complicità delle autorità e all’interessamento del sottosegretario alla giustizia Arnaldo Dello Sbarba, saranno tutti prosciolti dall’accusa di omicidio. Le coperture di cui beneficia il gruppo di fuoco rappresentano la testimonianza dell’intreccio che da subito s’instaura fra i gruppi di fascisti locali, le autorità militari e quelle di carabinieri e guardie regie. Questo stretto rapporto è testimoniato anche dal prefetto di Pisa De Martino che in una missiva del 21 aprile al presidente del consiglio Giolitti testimoniava questa complicità.
Le organizzazioni della sinistra pisana – la Federazione prov.le socialista, il Gruppo comunista, la Camera del lavoro confederale (CGdL), la Camera del lavoro sindacale (USI), i Sindacati ferrovieri, la Lega Proletaria e l’Unione anarchica pisana – firmano un manifesto di condanna dell’assassinio di Carlo Cammeo e proclamano due giorni di sciopero generale.
I funerali di Cammeo sono imponenti per partecipazione popolare e di associazioni, alcuni esponenti politici prendono la parola, tra gli altri il segretario della Camera del lavoro (CGdL) Giuseppe Mingrino, il socialista Amulio Stizzi, il repubblicano Italo Bargagna e l’anarchico Gusmano Mariani. Questa volta sono funerali di classe, proletari, a rimarcare ormai il netto distacco tra il movimento operaio organizzato da una parte e lo Stato e le forze reazionarie dall’altra.
Articolo pubblicato nell’aprile del 2015.