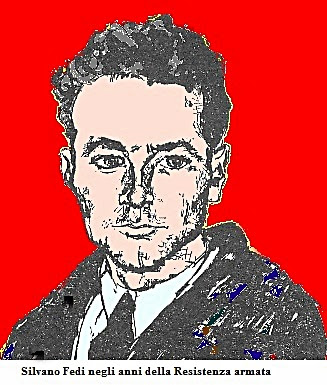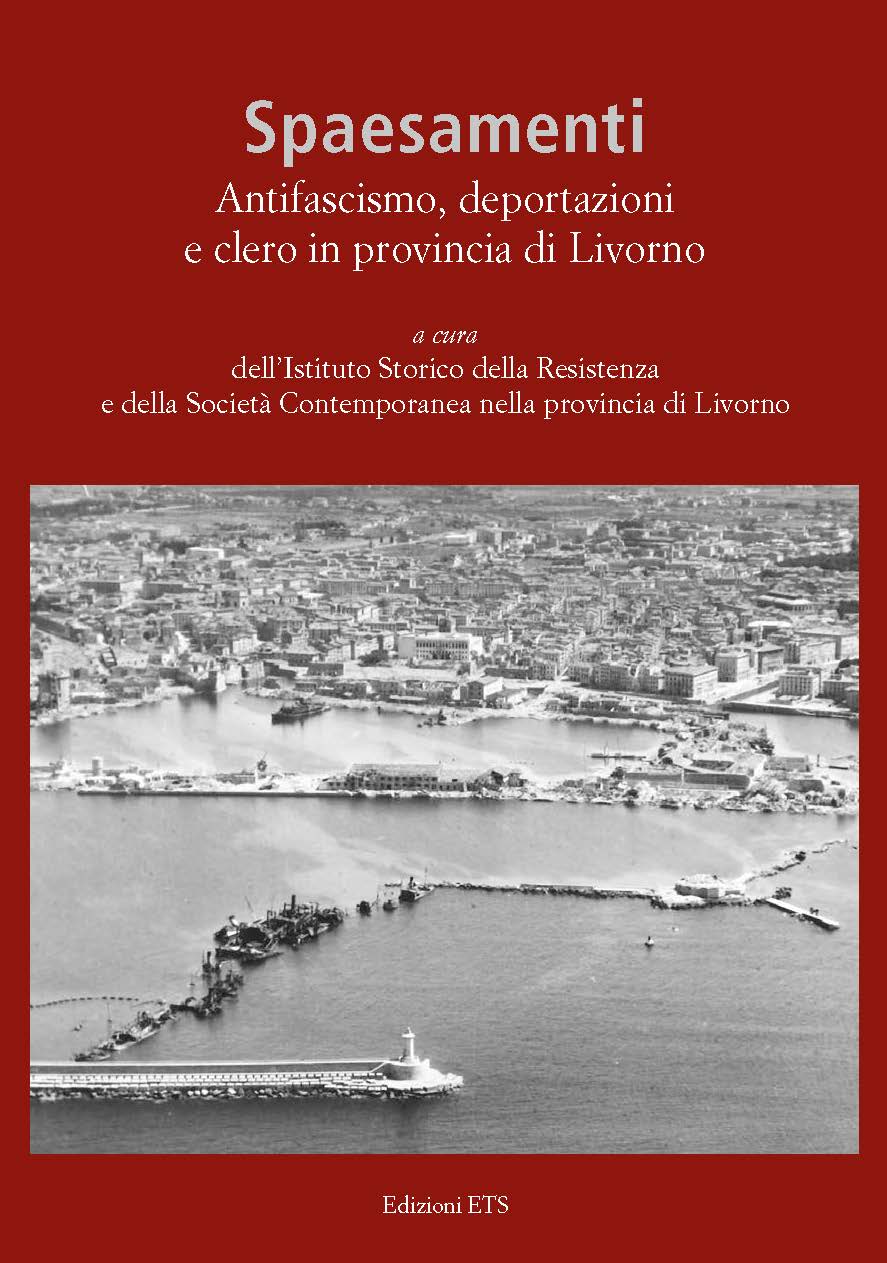La memoria della Shoah e la costruzione dell’Europa: percorsi e sfide dal dopoguerra ad oggi

Gentili signore e signori, consiglieri, autorità presenti, Rabbino Levi, sono molto onorato di essere stato invitato come relatore in occasione di questa importante ricorrenza e vorrei esprimere per ciò un sentito ringraziamento al Consiglio regionale, al suo Presidente Eugenio Giani e al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Lo scorso anno le celebrazioni della Giornata della Memoria furono contrassegnate dal forte impatto emotivo suscitato dagli attentati terroristici di matrice islamista condotti a Parigi contro la sede del giornale Charlie Hebdo e un supermercato di prodotti Kosher. Nel cuore dell’Europa era stato lanciato un attacco omicida ai valori della laicità e della democrazia. E quell’attacco aveva assunto anche le vesti di un virulento antisemitismo. Dodici mesi dopo il clima purtroppo non è cambiato, anzi – dopo i tragici episodi avvenuti nella capitale francese lo scorso novembre, l’emergenza profughi, i fatti di Colonia, lo stillicidio di minacce e atti terroristici riconducibili al cosiddetto Stato islamico (ISIS) – la situazione appare ai nostri occhi ancora più allarmante. Come allarmante, per altri aspetti, risulta il fenomeno correlato, ben evidente da tempo in ogni paese europeo, rappresentato dall’erompere di movimenti nazionalisti xenofobi, non privi – soprattutto ad est – di un imprinting antisemita. Un fenomeno che rischia di far saltare i cardini su cui poggia la nostra civiltà democratica.
Dunque, anche quest’anno, qui a Firenze, come in tutta Europa, celebrare la Giornata della memoria ha un sapore particolare; ci chiama ad un compito particolare. Infatti, fare memoria della Shoah non significa semplicemente ricordare lo sterminio degli ebrei e delle altre vittime del nazismo, non significa rievocare il passato, ma implica attribuire al passato – a quel passato – un significato capace di illuminare l’oggi, per aiutarci a compiere le nostre scelte in una situazione difficile.
Ma come si può svolgere questo compito? Da storico ritengo sia utile – direi necessario – riflettere sul significato della memoria della Shoah collocandola nell’ambito più ampio della memoria europea della seconda guerra mondiale, che rappresenta ancora un punto di riferimento fondamentale per la nostra memoria collettiva.
Vorrei dunque provare a tracciare, molto sinteticamente, il percorso evolutivo di questa memoria europea. Lo farò appoggiandomi alle considerazioni di un brillante storico britannico purtroppo prematuramente scomparso, Tony Judt.
Judt ha indicato due grandi fasi della memoria europea del secondo dopoguerra: la prima che ha preso forma dopo il 1945, la seconda dopo il 1989. A suo giudizio, subito dopo il crollo del Terzo Reich, l’Europa è stata ricostruita – ad ovest come ad est – su una memoria fortemente selettiva imperniata su due pilastri comuni: da un lato, il mito della Resistenza come epica e corale lotta di liberazione nazionale contro i nazisti; dall’altro, l’attribuzione alla Germania e ai tedeschi dell’esclusività della colpa per le sofferenze e i crimini della guerra. They did it! Loro l’hanno fatto!
Naturalmente dietro tale raffigurazione stava un corposo nucleo di verità: in tutti i paesi che avevano subito l’occupazione nazista (e dovremmo aggiungere anche fascista) – dalla Norvegia alla Jugoslavia, dalla Francia alla Polonia – erano sorti movimenti di resistenza che avevano coraggiosamente lottato contro l’occupante pagando un prezzo altissimo e non c’è dubbio che sulle spalle dei tedeschi gravasse la responsabilità predominante per lo scatenamento della guerra e i crimini commessi. La “soluzione finale” porta un indelebile marchio germanico. Tuttavia, la glorificazione della Resistenza e la stigmatizzazione dei tedeschi hanno finito per oscurare altri aspetti importanti: la presenza ovunque nell’Europa occupata di forze collaborazioniste che avevano attivamente spalleggiato il nazismo e il fascismo, nonché il fatto che gravi crimini di guerra erano stati commessi da tutti i belligeranti, compresi i vincitori. Basti pensare – solo per fare degli esempi – alle uccisioni di migliaia di ufficiali polacchi perpetrate dall’Armata Rossa (le cosiddette fosse di Katyn), agli stupri compiuti dal Corpo di spedizione francese in Italia (le “marocchinate”), alle foibe (per restare al caso italiano) o alla serie di bombardamenti sui civili di natura terroristica condotti dagli anglo-americani culminati nelle due atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki. Secondo Judt, la rimozione dalla memoria ufficiale di questi aspetti ha marchiato il Vecchio continente con quella che egli ha definito a vicious legacy – una “eredità maledetta” – caratterizzata da “una deliberata distorsione della memoria”, dall’”oblio come stile di vita”. Oblio del collaborazionismo filo-fascista, non riducibile ad un fenomeno di pochi invasati, e oblio dei crimini compiuti dagli altri, dai non tedeschi.
Il 1989, con la fine della guerra fredda e il ricongiungimento delle due Europee, è stato contrassegnato all’opposto da un “eccesso compensativo di memoria” che le istituzioni hanno promosso in ogni paese per fondare, o rifondare, nuove identità collettive dopo il crollo del Muro di Berlino. Il processo si è indirizzato lungo due nuove direttrici. A ovest, a partire dagli anni Novanta è emersa al centro della scena la memoria della Shoah. Il ricordo dello sterminio degli ebrei era stato certamente presente anche prima, ma – potremmo dire – solo come uno degli aspetti della memoria antifascista. Gli ebrei erano stati considerati una delle tante categorie di vittime del nazismo. Solo col passare degli anni la memoria della Shoah ha guadagnato autonomia e propulsione fino a diventare “mito fondante negativo” della memoria europea. Essa rimanda infatti ad una vera e propria “frattura di civiltà”, rappresenta il “crimine per eccellenza”: “il tentativo di un gruppo di europei di sterminare tutti i membri di un altro gruppo di europei”. In una Europa scossa dal riapparire di manifestazioni di odio antisemita e razzista e dal ripetersi nei suoi confini, dopo l’implosione della Jugoslavia, di crimini atroci contro i civili (si pensi a Sebrenica), la memoria della Shoah è assurta a “narrazione unificante” con valore di monito contro il rischio del ripetersi del Male. “Mai più!”
A est, invece, i paesi usciti da oltre quarant’anni di regimi comunisti sotto il controllo dell’Unione sovietica hanno proceduto a riedificare memorie nazionali rimaste a lungo congelate e hanno coltivato la memoria ancora scottante del comunismo. Essi hanno mostrato alcune differenze fra loro ma anche alcuni importanti tratti comuni: la tendenza a esternalizzare il comunismo come mero frutto dell’imposizione attuata dall’Armata rossa; la conseguente raffigurazione delle società nazionali nei panni di vittime innocenti e l’esaltazione dell’ostinata resistenza popolare – attiva e passiva – ai regimi comunisti; la rivendicazione infine dell’assimilazione dei crimini del comunismo ai crimini del nazismo.
A partire soprattutto dalla seconda metà degli anni Novanta, nel pieno dell’accelerazione del processo unitario dopo Maastricht, anche le istituzioni dell’Unione europea sono intervenute sul terreno della memoria attraverso politiche del ricordo sempre più incisive. Alla tradizionale narrativa europea della riconciliazione e della pace fra i paesi che si erano scannati nella prima e nella seconda guerra mondiale si è presto affiancata un’azione istituzionale – promossa soprattutto dal Parlamento di Strasburgo – per la costruzione di una comune memoria europea. Questa è stata fondata su due cardini: la Shoah e l’antitotalitarismo.
Dopo la dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma sull’Olocausto nel 2000, l’Unione europea ha trasformato progressivamente la memoria della Shoah in una sorta di religione civile alla base dei suoi valori fondamentali di democrazia, pace e difesa dei diritti umani. Come già fatto da numerosi Stati membri, anche a livello europeo il 27 gennaio è stato scelto dieci anni fa come Giornata europea della Shoah e nel novembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia volta ad uniformare la legislazione comunitaria attraverso l’adozione di una normativa antinegazionista.
All’allargamento dell’Unione europea ad est nel 2004 e nel 2007 ha fatto seguito una spinta crescente dei nuovi membri dell’Europa centrale ed orientale per l’adozione a livello comunitario di politiche della memoria incentrate sull’antitotalitarismo attraverso l’equiparazione fra nazismo e comunismo. A questo ha puntato la Dichiarazione di Praga del giugno 2008, primo firmatario l’ex leader del dissenso e Presidente cecoslovacco Vaclav Havel. Il documento chiedeva di riconoscere comunismo e nazismo come “eredità comune” dei paesi europei, definiva i crimini del comunismo come crimini contro l’umanità, perorava l’istituzione di una specifica giornata europea in ricordo delle vittime dei due totalitarismi, auspicava la revisione dei manuali di storia europei e la nascita a livello comunitario di un istituto scientifico e di un museo dedicati ai totalitarismi. Molte di queste proposte sono state recepite dalle istituzioni europee. Già nel settembre 2008 il Parlamento europeo ha istituito una “Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo” scegliendo come data il 23 agosto, giorno della firma nel 1939 del Patto Ribbentrop-Molotov, letto come un accordo per la spartizione dell’Europa fra la Germania nazista e l’Unione sovietica. L’anno successivo (aprile 2009) il Parlamento ha votato la risoluzione su “Coscienza europea e totalitarismo” che pone al centro della memoria europea il ricordo dei due totalitarismi. Nel 2011 è nata la Piattaforma della memoria e della coscienza europea, un progetto educativo dell’UE per la diffusione della conoscenza dei regimi totalitari. Inoltre, ricordiamo che già dal 2007 l’Azione 4 del Progetto “Europa per i cittadini”, istituito dal Parlamento e dal Consiglio per promuovere la “cittadinanza europea attiva”, ha previsto un cospicuo finanziamento destinato alla memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo.
Dalla prospettiva delle istituzioni europee, questo intenso investimento economico e culturale indirizzato alla creazione di una memoria comune dovrebbe rafforzare se non creare quei legami di appartenenza e di identità fra i paesi membri indeboliti dal fallimento del trattato costituzionale dopo l’esito negativo dei referendum in Francia e in Olanda (2005). Legami che sono stati messi ancor più a repentaglio dagli effetti della crisi economica dopo il 2008, segnata da una contrapposizione interna all’Europa lungo l’asse nord-sud, dal diffondersi di movimenti populisti antieuropei, nonché dalla reviviscenza generalizzata di sentimenti e stereotipi antitedeschi.
Ma che effetti ha avuto la politica della memoria promossa da Bruxelles? Sul piano generale, essa ha ripreso e rafforzato alcuni indirizzi di fondo che, come abbiamo visto, si erano già manifestati nel contesto europeo post-89: una raffigurazione molto semplificata del Novecento come secolo della violenza, dei crimini e dei genocidi scatenati dalle opposte ideologie totalitarie, nazista e comunista, con i rispettivi apparati del terrore; una veloce erosione (radicale nei paesi ex-comunisti) del paradigma antifascista rimpiazzato da quello fondato sull’antitotalitarismo; la sostituzione come figura centrale dell’eroe partigiano con quella della vittima, la vittima innocente delle stragi naziste e delle violenze comuniste; l’arrivo sulla scena memoriale dei cosiddetti “giusti”, ovvero uomini e donne comuni che si sono distinti in azioni di solidarietà e protezione nei confronti dei perseguitati dai regimi totalitari. Si veda a questo proposito l’istituzione della “Giornata dei giusti” votata dal Parlamento europeo nel 2012.
Nel tentativo di abbinare la Shoah e il paradigma antitotalitario, la UE ha assunto con ogni evidenza come proprio modello la Vergangenheitsbewältigung tedesca, prima messa in atto da Bonn e, dopo la riunificazione, da Berlino. Nel caso della Germania, non vi è dubbio che si possa parlare di un percorso virtuoso che ha mantenuto al centro della memoria nazionale la resa dei conti con i crimini del nazismo culminati nello sterminio degli ebrei d’Europa e ha poi integrato tale memoria con quella del regime comunista nella DDR, la Germania orientale. Il più importante monumento tedesco è quello dedicato agli Ebrei d’Europa assassinati che sorge a Berlino, a due passi dal Bundestag,
Ma il modello tedesco, legato alle esperienze storiche vissute dalla Germania, può essere “europeizzato”? In verità, quel che funziona bene nella vigile democrazia tedesca non sembra funzionare altrettanto bene a livello europeo, dove sono emerse varie ombre. Innanzitutto, persiste una frizione memoriale fra est e ovest caratterizzata da una persistente concorrenza fra le “vittime del Gulag” e le “vittime del Lager”. Dietro la forte insistenza da est sul paradigma antitotalitario è poi apparso in molti casi un atteggiamento asimmetrico, tutto sbilanciato nella condanna del comunismo, che ha finito per riabilitare in maniera indiscriminata come eroi della patria tutti i nemici del comunismo, compresi noti – o meglio famigerati – esponenti di spicco del collaborazionismo filonazista degli anni della seconda guerra mondiale, come ad esempio Ante Pavelic in Croazia, il maresciallo Antonescu in Romania, Josef Tiso in Slovacchia; per non dire dei giovani volontari lettoni delle Waffen-SS cui gli ex-commilitoni hanno dedicato alcuni anni fa a Tallin una targa commemorativa come “combattenti della libertà”. É giusto che i paesi dell’Europa occidentale prendano coscienza di cosa hanno rappresentato per l’altra metà d’Europa i decenni di dominio comunista, ma non al prezzo di riabilitare collaborazionisti che molto spesso hanno avuto parte attiva nella persecuzione degli ebrei.
L’Italia non è immune da rischi di questo genere. Solo pochi anni fa, ad esempio, è stata realizzata con soldi pubblici ad Affile, un paesino vicino a Roma, la costruzione di un mausoleo dedicato al Maresciallo Rodolfo Graziani, capo delle forze armate della Repubblica sociale italiana e responsabile di numerosi crimini di guerra nelle colonie africane. Persiste poi l’attitudine a scaricare su altri le nostre responsabilità. Questo è particolarmente evidente proprio osservando la memoria della Shoah. Le leggi razziste del 1938 contro gli ebrei, volute da Mussolini e firmate dal Re, sono state – per riprendere un’espressione usata lo scorso anno dal presidente Rossi – “una vergogna assoluta che pesa ancora sulla storia dell’Italia, del nostro amato Paese”. Ebbene, non sono pochi in Italia coloro che continuano a credere che quelle leggi siano state imposte al Duce riluttante dallo spietato Führer di Berlino. Un’autentica frottola che nasconde le responsabilità del governo fascista che agì invece in piena autonomia. Ma c’è anche un altro aspetto importante. La celebrazione mediatica dei “giusti”, dei generosi “salvatori di ebrei”, come l’abile e coraggioso Giorgio Perlasca, ha finito per oscurare le responsabilità avute da tanti italiani nella persecuzione dei loro concittadini ebrei. Come ha scritto Simon Levis Sullam, l’Italia sembra essere passata dall’”era del testimone” – imperniata sulla memoria delle vittime – all’”era del salvatore” senza passare per alcuna “era del carnefice”. Un “colpevole oblio” sembra sceso sui tanti italiani che furono attori e complici della Shoah, coloro che parteciparono all’arresto degli ebrei (poco meno della metà degli arresti fu compiuto da italiani), i delatori che li denunciarono, coloro che si appropriarono dei loro beni e dei loro posti di lavoro, quanti semplicemente stettero a guardare o rivolsero lo sguardo altrove. Figure di salvatori di ebrei, come Perlasca, sono giustamente molto famose, ma quanti in Italia conoscono ad esempio il commissario prefettizio Giovanni Francesco Martelloni capo dell’Ufficio Affari ebraici di Firenze, uno spietato cacciatore di ebrei responsabile di decine di arresti di uomini, donne e bambini finiti ad Auschwitz? Basta dare un’occhiata a Google per farsi un’idea: per Perlasca risultano 139 mila contatti; per Martelloni 150!
Anche in Italia, infine, come in Europa, si è assistito negli ultimi quindici anni ad una competizione fra memorie diverse della seconda guerra mondiale, tutte riconosciute e promosse dalle istituzioni statali. Mi riferisco alle principali di esse: la memoria appunto della Shoah, che stiamo celebrando oggi, la memoria delle foibe legata alla celebrazione del Giorno del ricordo il 10 febbraio, la memoria della Resistenza incentrata sul 25 aprile. Secondo alcuni storici come Giovanni De Luna e Sergio Luzzatto, la memoria della Shoah avrebbe eroso se non scalzato la memoria della Resistenza. Ora, la memoria della Shoah ha sicuramente – e per fortuna – guadagnato spazio nella coscienza pubblica, ma la memoria della Resistenza – grazie soprattutto all’impegno del Quirinale, da Ciampi a Mattarella – è rimasta un punto di riferimento fondamentale. Non sono due memorie in conflitto. Anzi, per certi aspetti sono complementari: infatti, se la memoria della Shoah può essere vista come strumento di salvaguardia dei diritti umani contro ogni tipo di discriminazione, la memoria della Resistenza – col suo forte vincolo alla Costituzione – resta una base di riferimento per i diritti di cittadinanza, il diritto al lavoro, alla salute, all’educazione, ad un ambiente sano… Entrambe sono vitali per la salute della nostra democrazia.
Introdotta dal Parlamento nel 2004, la memoria delle foibe ha avuto nei primi anni un carattere antagonistico rispetto a quella della Resistenza e competitivo rispetto a quella della Shoah. Restano impulsi in questa direzione, ma è importante – a mio avviso – che negli ultimi anni del suo mandato l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano abbia fatto molto per trasformarla da una memoria di matrice nazionalista con venature antislave in una memoria europea riconciliata basata su un impegno comune fra Italia, Slovenia e Croazia. Un impegno a riconoscere i torti che storicamente un paese ha inflitto all’altro (prima delle foibe ci sono stati i crimini italiani in Jugoslavia) per collaborare attivamente da ora in poi, senza il peso di un passato conflittuale, come membri dell’Unione europea. Questo quadro europeo è del resto la corretta cornice di riferimento in cui agisce nella sua azione memoriale la Regione Toscana, grazie anche all’impegno dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana e della rete degli istituti collegati.
Sono dunque tornato al contesto europeo da cui ero partito. E vorrei qui concludere con alcune considerazioni finali.
All’indomani dei sanguinosi attacchi jihadisti a Parigi dello scorso 13 novembre, una delle firme di punta del Sole24Ore, Alberto Negri, ha dedicato un articolo lucido e appassionato alla lotta cui siamo chiamati oggi per sconfiggere la minaccia dell’ISIS. E Negri ha esordito citando quello che secondo Sartre era (e potremmo dire – è) il più bel romanzo dedicato alla Resistenza: “Educazione europea”, opera del grande scrittore Romain Gary, ebreo lituano – eroe della resistenza francese. “Come va la battaglia di Stalingrado dei russi contro i nazisti?”, si chiedono i partigiani polacchi nel romanzo.
“Come va la battaglia contro il Califfato? Se avessimo ancora un’educazione europea – scrive Alberto Negri – questa è la domanda che dovremmo farci tutti i giorni e che forse si faranno adesso (…) i francesi. Rispondere al terrore con la solidarietà e le bandiere a mezz’asta va bene ma se avessimo ancora un’educazione europea dovremmo replicare colpo su colpo al terrorismo e alla sua minaccia, entrata nella nostra vita quotidiana con una strage di innocenti”.
Di fronte alla minaccia e alla sfida del terrorismo dunque Negri, e insieme a lui molti altri, si richiamano – in molti casi riscoprono – l’eredità della Resistenza, un’eredità che era sembrata molto appannata dopo il 1989. Ma attenzione: alla Resistenza contro il pericolo islamico si sono appellati e si appellano anche i movimenti xenofobi europei. “Widerstand, Widerstand!” (Resistenza! Resistenza!) hanno gridato i sostenitori di Pegida (i cosiddetti Patrioti europei contro l’islamizzazione dell’Occidente) dopo i gravi fatti di Colonia fomentando la caccia agli immigrati. Dobbiamo dunque fare attenzione e tenere assieme l’eredità della Resistenza con quella della Shoah. La prima ci sprona ad una difesa attiva della democrazia, la seconda ci ricorda di essere vigili contro ogni forma di razzismo e di xenofobia, inclusa l’islamofobia. É questa la nostra “educazione europea”.
Vi ringrazio dell’attenzione.
Articolo pubblicato nel gennaio del 2016.