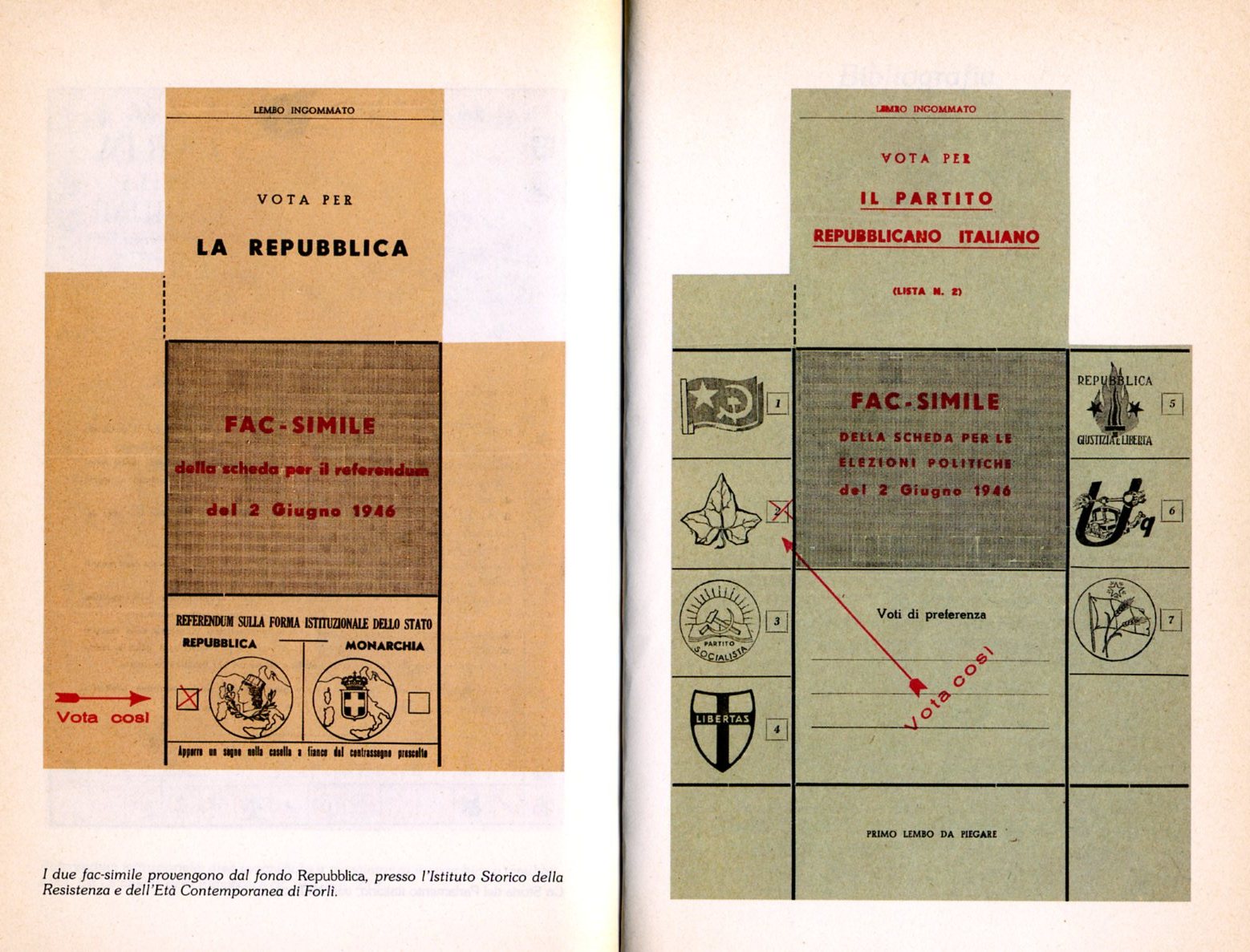Nel 1973, con l’art. 28 del Ccnl Metalmeccanici venne riconosciuto ai lavoratori il diritto a permessi retribuiti per frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio al fine di migliorare la propria cultura. La conquista di questo monte ore retribuito, noto come “150 ore”, fu utilizzato per ottenere il diploma di terza media, frequentare seminari o insegnamenti monografici nella scuola secondaria superiore e all’Università configurandosi come un vero e proprio laboratorio collettivo di innovazioni didattiche per l’ educazione degli adulti: la struttura seminariale delle attività invitava infatti gli studenti alla ricerca-apprendimento autonoma e alla ricerca-azione su tematiche e questioni che concernevano la vita quotidiana e le condizioni di lavoro degli operai. Una scommessa da parte del movimento operaio e sindacale riguardo alla democratizzazione di una scuola ancora selettiva ed elitaria, che traeva vigore dall’influenza del movimento studentesco, dall’esperienza di Don Milani a Barbiana, come da altri fermenti innovatori che si erano delineati ad inizio degli anni ‘60.
Le 150 ore non potevano pertanto rappresentare per i lavoratori un ritorno nella stessa scuola con voti, insegnanti autoritari, compiti a casa, dai contenuti astratti e lontani dalla loro esperienza di vita. Tra gli argomenti specifici possiamo ricordare l’analisi della busta paga e della contingenza, il ruolo della fabbrica, la situazione dell’agricoltura, l’ambiente di lavoro, mentre in merito alla riflessione storica i filoni più diffusi furono la storia dell’industrializzazione, del fascismo, dell’immigrazione. Tematiche affrontate con metodologie didattiche nuove alternative al libro di testo (il lavoro di gruppo, l’inchiesta, l’uso della statistica, il teatro) che aprivano orizzonti e percorsi inediti, superando l’atteggiamento passivo nei confronti dello studio e proponendosi di conoscere la realtà per cambiarla ed intervenire anche sulla propria situazione.Orizzonti e percorsi inediti che si concretizzarono soprattutto nell’utilizzo conoscitivo e relazionale del metodo autobiografico in direzione di un apprendimento basato sulla propria quotidianità e con la volontà di proporre una sorta di controcultura operaia antagonista a quella dell’impresa e alla “scienza dei padroni”.
Uno dei temi più ricorrenti che vide impegnati anche in Toscana corsisti, insegnanti e sindacalisti fu quello della nocività e salute nei luoghi di lavoro. L’attenzione a tale problematiche non era casuale dato che si trattava non solo di mantenere certe conquiste sul tema della sicurezza ottenute con le lotte del ‘68-‘74 ma anche di esprimere al meglio le nuove opportunità derivanti dall’ Inquadramento unico[1]: era impensabile migliorare la professionalità e la qualità del lavoro se non miglioravano le condizioni in cui esso veniva esercitato[2]. La monetizzazione del rischio, ossia l’indennizzo per un lavoro nocivo, pericoloso, eccessivamente faticoso, incorporata nel salario, era una strada ormai del tutto impraticabile come ricordano queste emblematiche parole di un operaio empolese: “La salute del lavoratore è più importante delle 5.000 lire di aumento mensile” (corsista 150 ore, Scuola media Fucini- Empoli 1975-1976, Archivio Cisl fondo Flm, b.13844 fasc.1).Di pari passo con lo sviluppo della Medicina del lavoro in materia di salute e sicurezza, il movimento dei delegati di fabbrica fece proprio il modello sindacale della prevenzione fondato sull’azione diretta dei lavoratori: elaborato già nella metà degli anni ‘60 in alcune esperienze torinesi, lo socializzò fra gli operai, facendolo circolare e sperimentandolo attraverso una capillare attività di formazione nei corsi delle 150 ore [3].
A Firenze, nel 1975-’76, si tennero diversi corsi nella scuola media inferiore sul tema “Ambiente di lavoro e salute in fabbrica”, cui parteciparono i delegati delle più grandi fabbriche dell’area urbana. I filoni principali seguiti nei corsi furono: l’analisi delle officine e dei reparti (inquinamento, incidenti e infortuni, rischi in generale); la prevenzione sanitaria (malattie professionali, regole e standard); la promozione di un sistema sanitario pubblico e la storia dell’ambiente di lavoro industriale[4]. “Per Siena come primo momento per l’utilizzo delle ore di studio pagate per i lavoratori può essere visto come epicentro l’Istituto di Medicina del Lavoro”, recita una proposta di discussione per l’utilizzo delle 150 ore dove si elencano anche le possibili discipline di studio: Medicina sociale, del lavoro, farmacologia, malattie mentali ma anche collegamenti interdisciplinari con economia, lettere e diritto[5]. Ugualmente a Follonica si affrontarono le malattie professionali nelle miniere con preliminari cenni di anatomia[6]. Nel 1974, a Prato, uno dei maggiori distretti industriali tessili italiani, a conclusione di un corso da 120 ore (la quantità di ore contrattuali previste per il diritto allo studio retribuito di questo comparto) venne pubblicato in forma ciclostilata un volume-dispensa, dedicato all’organizzazione del lavoro e all’ambiente nelle piccole e piccolissime imprese, comprese quelle familiari (120 ore, Fondo Flm, b.13845, fasc. 2).
Nel 1975 ad Empoli presso la Scuola Media Statale Fucini, in un contesto di distretto industriale e di piccole e medie imprese diffuse, si svolse un corso avente per oggetto “il problema della salute in fabbrica e nella società” attraverso lavori di gruppo e “verifiche assembleari”. Il programma, raccolto in un’antologia, si strutturò attorno alle storie di vita dei lavoratori con un particolare accento riservato ai problemi della fabbrica. Quelli “ di sopra”, “gli altri”, “quelli che comandano” che stabiliscono turni, ritmi, che tarano le macchine, che decidono il salario, che assumono o licenziano, che valutano la malattia o l’invalidità, sono quelli “che hanno studiato”, che sono rimasti dentro la scuola, cosicché la fuga dal ripetitivo e stressante lavoro manuale e la distribuzione ingiusta del sapere si fondono nelle motivazioni a riprendere a studiare: “mi piace soprattutto che a scuola ognuno di noi, operaio, casalinga etc. si esprime come può ed insieme possiamo parlare, discutere di tanti problemi di cui siamo vittime” [7]. Molte le testimonianze riguardo all’ ambiente lavorativo e la sua nocività, ne riportiamo alcune tratte dal Fondo Flm dell’Archivio Cisl (b. 13844 fasc.1):
Ogni lavoratore deve essere tutelato prima che si ammali perché quando l’operaio di fabbrica si ammala può essere solo curato ma non guarito. I nostri datori di lavoro dicono sempre che c’è troppo assenteismo, ma se ogni operaio lavorasse con più sicurezza per la sua salute, con meno nocività in fabbrica, e con più garanzie da parte dello Stato o degli organi competenti, si avrebbe tutti più salute e maggiore benessere.
Sono un operaio metalmeccanico, ed ho sempre lavorato continuamente da circa 12 anni. Cosicché penso di avere acquistato una certa conoscenza di quello che può essere il rapporto di lavoro e la salute nella fabbrica. Io credo che si debbano affrontare in questo corso i problemi che ci aspettano quotidianamente. Il rapporto di lavoro si sta dimostrando col passare del tempo sempre più difficile perché aumentano le difficoltà del lavoratore all’interno della fabbrica. Il ritmo di produzione è sempre più elevato e richiede maggiore logorio fisico, senza contare lo stato d’animo, sospesi come siamo, fra licenziamenti e cassa integrazione. La salute è una cosa indispensabile per tutti, ma soprattutto per noi operai, che tutte le mattine dobbiamo lavorare senza tante attenuanti, perciò l’ambiente deve essere non sano, ma sanissimo.
Altri corsisti sottolineano la pesantezza della linea di montaggio, il difficile adattamento del corpo ai tempi e ai modi di funzionamento delle macchine, la dura disciplina della “fabbrica orologio”:
Lavoro da circa 6 anni, prima ero alla catena con ritmi elevati, durante il giorno non potevo neanche andare in bagno altrimenti rimanevo indietro, ora sono alla mazzetta. Circa 3 anni fa ebbi una colica renale, il mio medico mi disse che dipendeva tutto dallo stare sempre seduta, chiesi se mi potevano cambiare posto. Ma non fu possibile neanche col certificato medico, che poi lo chiedevo soltanto per qualche mese. Così sono andata avanti fino ad oggi.
Spesso con un ammodernamento degli impianti, l’operaio vede arrivare in fabbrica una macchina che fa, magari più velocemente, quello che faceva lui, tale e quale. E vede bene che se lui non può decidere niente, la semplice forza delle sue braccia non vale molto. Lui diventa un semplice accessorio da adattare alla macchina, un ingranaggio e non il più importante. Il padrone ha molta più cura della macchina che di lui. Se si guasta la macchina si ferma tutto, se si guasta un operaio il padrone ce ne mette un altro e non è successo niente di grave. Tutto ciò è umiliante per un uomo.
Io sono una confezionista, lavoro alla Lebole, che comprende 7.000 dipendenti ed è divisa in succursali. Io lavoro alla succursale di Empoli, che impiega circa 500 lavoratori e, come in genere in tutte le fabbriche, i problemi non mancano. Il ritmo molto elevato causa tensione, sensazione di paura, ansietà, fatica, nervosismo, depressione, per questo ogni giorno ci sono delle crisi isteriche e assenze dal posto di lavoro. Il padrone reagisce chiamandoci massa di vagabondi, ma non fa niente per trovare una soluzione a questi problemi. La ripetitività della mansione è un avvilimento continuo. Pensare di avere un cervello e non poterlo utilizzare in quanto l’uomo è al servizio della macchina e non la macchina al servizio dell’uomo.
In molti operai matura così la consapevolezza e l’importanza di trattare la Medicina preventiva, “dopo anni che sono assente dagli studi per motivi economici, mi ritrovo di nuovo in aula non come scolaretto ma per capire qual è il male che nuoce alla salute di noi lavoratori”:
Mi rendo conto di quanto è importante studiare a fondo la medicina preventiva, nelle fabbriche ci sono moltissime cose dannose per la salute; alcune mie colleghe sono ammalate di nervi e questo per tante cose ingiuste, il ritmo di lavoro e tante altre.
Sono contento che questo corso studi il problema della salute. Lavoro in vetreria e quello è senza dubbio uno dei posti dove la salute va curata in tempo perché se si aspetta i sintomi della malattia la maggior parte delle volte è troppo tardi. Sono contento anche di imparare l’italiano e le altre materie, per avere una maggiore cultura che mi serve nella società e anche nell’ambiente di lavoro, dove spero di poter parlare meglio soprattutto con il datore di lavoro che crede di sapere sempre tutto lui.
Per quanto riguarda i rischi che corriamo, si potrebbe parlare di tantissime cose, in quanto la mia fabbrica è un calzaturificio e, come è noto, in questo tipo di lavorazioni i fattori di nocività non si contano. Finalmente è entrato nella nostra fabbrica l’ispettorato della Medicina Preventiva; così abbiamo avuto la possibilità di farci vigilare di più.
Abbiamo lavorato con assoluta mancanza di controlli sanitari periodici, abbandonati quindi dalla scienza medica, ognuno pensava per proprio conto alla salute, se stava attento altrimenti quando si manifestava un malessere questo era già cronico. Finalmente viene istituito un servizio di Medicina Preventiva.
Come si evince da queste testimonianze, la consapevolezza che “lavorare in fabbrica fa male alla salute”[8] indirizzò gli operai più o meno scolarizzati verso un nuovo atteggiamento nei confronti del lavoro e ad una maggior percezione del rischio. E in questa presa di coscienza operaia, a livello di massa, la socializzazione educativa delle 150 ore giocò un ruolo fondamentale: i lavoratori, analizzando le loro esperienze, anche attraverso le storie di vita, contribuirono infatti in modo del tutto originale ad approfondire alle conoscenze di medici, tecnici e sindacati[9] e la prospettiva finale fu quella di utilizzare le ricerche svolte nei corsi per definire le strategie di azione sindacale e le piattaforme rivendicative dei Consigli di fabbrica.
Avendo come oggetto di studio e di indagine le condizioni di lavoro e l’organizzazione produttiva, anche sul piano della salute e della sicurezza, le 150 ore rappresentarono per molti aspetti “un vero e proprio caso di auto-educazione di massa attraverso la ricerca-azione” [10] la cui ricostruzione storica consente di riflettere su sfide ancora assolutamente attuali: alcune di esse purtroppo rimandano ad episodi di cronaca ed immagini tragicamente note.
Un suono che si distingue dagli altri numerosi rumori della fabbrica; la sirena dell’ambulanza che a tutta velocità percorre per l’ennesima volta la strada verso l’ospedale. E’ un altro incidente sul lavoro: un altro lavoratore vittima di un macchinario. (corsista 150 ore, Scuola media Fucini- Empoli 1975-1976)
Monica Dati è dottoranda presso il corso di “Scienze della Formazione e Psicologia” dell’Università degli studi di Firenze. Collabora con il Comune di Lucca e con la Biblioteca Agorà con cui ha inaugurato il progetto “Madeleine in biblioteca”.
[1]Sistema di classificazione che viene introdotto in seguito alla lotta contrattuale dei Metalmeccanici del 1972-73 che porta al superamento della distinzione tra operai ed impiegati.
[2]P. Causarano, Unire la classe, valorizzare la persona. L’inquadramento unico operai-impiegati e le 150 ore per il diritto allo studio, Italia contemporanea, 278, pp. 224-46, 2015.
[3] Questo modello operaio fu reso noto in migliaia di fabbriche grazie alla dispensa L’ambiente di lavoro, edita prima dalla Fiom nel 1969 e poi dalla Flm nel 1971. Scaturita dall’opera di Ivar Oddone, medico e psicologo del lavoro, fu il frutto di un’elaborazione collettiva pluriennale che raccolse l’esperienza di alcuni lavoratori metalmeccanici della 5a Lega di Mirafiori.
[4]P. Causarano, Il male che nuoce alla società di noi lavoratori. Il movimento dei delegati di fabbrica, la linea sindacale sulla prevenzione e i corsi 150 ore nell’Italia degli anni Settanta, Giornale di Storia Contemporanea, 2016, n. 2 p. 70
[5] Proposta di discussione per l’utilizzo a Siena delle ore di studio pagate per i lavoratori. Materiale per le 150 ore a Siena 1976-1977, a cura della Commissione Sindacale 150 ore di Siena, Archivio storico del movimento operaio e contadino in provincia di Siena (Amoc), Fondo zona sindacale Amiata b. VIII Fasc. 1
[6] Documenti sui corsi 150 ore. Malattie professionali e ambiente di lavoro in miniera, Fondo CGIL, 1 (b. 85), Archivio della Camera del Lavoro di Grosseto
[7]Antologia del Corso 150 ore, Scuola Media Fucini R., Empoli, 1975 ciclostilato, Archivio Cisl, Fondo Flm, b. 13844 fasc.1
[8]Come titola il famoso libro di medicina del lavoro di Jeanne Stellman e Susan Daum (Feltrinelli, 1975)
[9]Sul rapporto tra formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro si veda anche P. Federighi, G. Campanile, C. Grassi (a cura di), Il circolo di studio per la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ETS, Pisa, 2010
[10]P. Causarano, Il male che nuoce alla società di noi lavoratori. Il movimento dei delegati di fabbrica, la linea sindacale sulla prevenzione e i corsi 150 ore nell’Italia degli anni Settanta, op. cit., p. 67







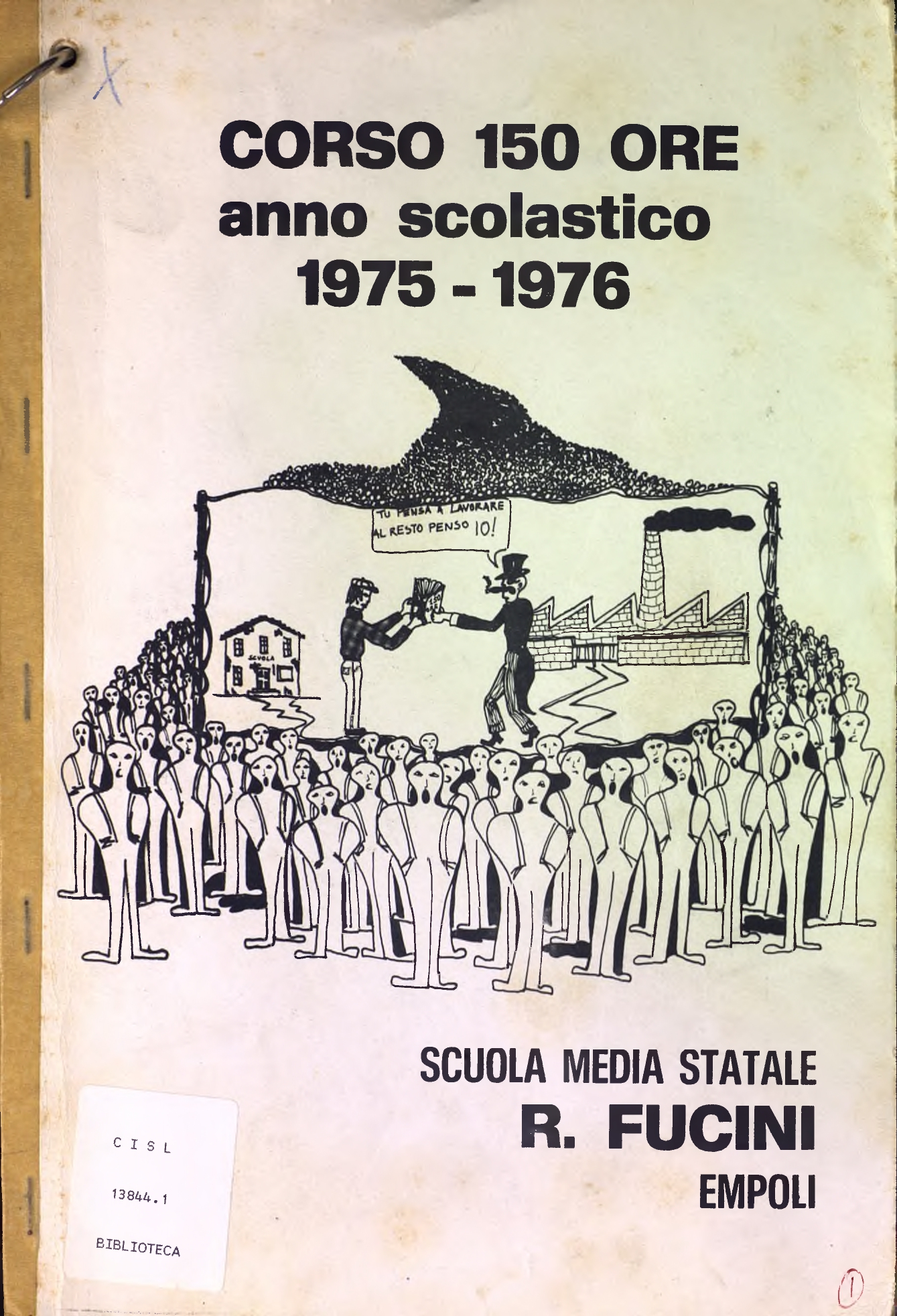

 I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di
I fascisti “forestieri” circolavano in regione per dare coraggio agli elementi locali, ma soprattutto per suscitare disordini che potessero costituire quella “provocazione” necessaria come pretesto per una sistematica campagna di