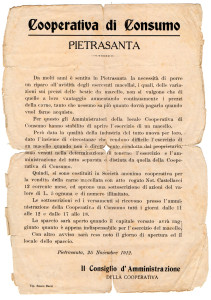IL CAMPO FINO AL 10 SETTEMBRE 1943[1]
Nel giugno 1940 l’Italia fascista entrò in guerra. Fin dai primi giorni il Ministero degli Interni istituì su tutto il territorio nazionale campi per i militari nemici catturati. Contestualmente inasprì la legislazione antiebraica del 1938 e, con norme che si fecero sempre più restrittive, impiantò campi di concentramento e luoghi per il “normale internamento di guerra degli stranieri nemici e/o indesiderabili, e degli italiani pericolosi”. [2]
Il campo P.G. n.60, sorse[3] come campo per soldati e sottufficiali angloamericani ma dopo il tragico episodio del 10 settembre 1943, oggetto di questa nota, fu ristrutturato e servì al fascismo repubblicano come campo di concentramento – fino alla metà del ’44 – per ebrei e oppositori alla RSI e ai tedeschi occupanti.
Fu scelta l’area paludosa del Pollino, paradiso dei cacciatori di uccelli acquatici,[4] appartenuta al conte Gaddo della Gherardesca e da lui parzialmente bonificata grazie a un’idrovora inaugurata nel 1925. Al tempo della requisizione da parte dell’Esercito Regio, ne era proprietario il genovese Giuseppe Ravano che, con la moglie Candida Bombrini, vi gestiva una fattoria. Non ci è documentato l’assetto originario del campo; possiamo però ricavarne alcune caratteristiche – dimensione e strutture – oltre che da testimonianze – da una pianta di poco successiva. [5] La recinzione, con “fili spinosi“, abbracciava un perimetro di circa 600 mt, con diverse garitte per le sentinelle. Vi trovavano posto baracche di legno utilizzate come dormitori cui si aggiunsero tendoni di tipo “Roma” per fare fronte alle maggiori esigenze. Un luogo insalubre e soggetto ad alluvioni, assai freddo d’inverno per la nevicate sui monti antistanti e infestato da insetti nei mesi estivi; situato a tre km dal primo posto di ristoro (un dopolavoro[6]), ma con il vantaggio della prossimità (grazie a una stradina vicinale che attraversava il campo) alla piccola stazione di Colle di Compito, sulla linea Lucca-Pontedera: all’epoca uno snodo ferroviario vitale, soprattutto per il collegamento con la Piaggio. La linea, dopo il bombardamento della stazione di Pisa, il 31 agosto ’43, era diventata arteria logistica nevralgica per i tedeschi e, proprio perciò, bersaglio di frequenti e rovinose incursioni aeree alleate che ne decretarono il finale abbandono, spesso colpendo anche il campo. [7]
In questa fase (prima dello “sbandamento”) la sorveglianza e il controllo fanno capo al Ministero degli Interni. Il comando del campo è affidato a un colonnello dell’esercito coadiuvato da ufficiali, carabinieri e soldati. [8] Nonostante le forti carenze igieniche rilevate anche da ispezioni della CRI[9] e qualche problema di convivenza[10] i prigionieri vengono trattati con umanità: ricevono pacchi con generi di prima necessità; presso il campo è in servizio per un certo tempo un capitano medico; in certe occasioni possono, accompagnati, uscire in paese. La popolazione locale – che vede “i neri” per la prima volta – prova nei loro confronti curiosità e sentimenti di solidarietà; non mancano i piccoli baratti (molto richiesta la canapa, per fumarla) e l’abituale quota di mercato nero. Nel complesso le relazioni, anche tra soldati e popolazione locale, sono buone. Lo scenario bellico, però, evolvere. Nel giro di soli tre mesi, da luglio a fine settembre 1942, il numero dei prigionieri, soprattutto inglesi e sudafricani, cresce vertiginosamente. È un picco cui farà seguito un brusco e drastico calo. [11] Lo Stato Maggiore dell’Esercito decide comunque la trasformazione del campo da ‘attendato‘ a ‘baraccato’, ma alla fine di agosto alcune “difficoltà” impongono il ripiegamento delle tende e il trasferimento altrove di tutti i prigionieri di guerra. [12] Si rendono necessari alcuni lavori per la riapertura del campo che però, nonostante l’ordine dello Stato Maggiore del 31/12/42, figura ancora chiuso al marzo ’43. [13] Sicuramente il campo P.G. n. 60 è di nuovo in funzione nell’agosto del 1943, come si evince da forniture fatte in quel mese.
IL SACRIFICIO DEI MILITARI E LA SOLIDARIETA’ AI FUGGIASCHI
L’armistizio coglie di sorpresa anche i militari che gestiscono il campo. Lo dirige, da quasi un anno, il 65enne colonnello Vincenzo Cione, un veterano decorato della Grande Guerra, (di intuibili sentimenti antitedeschi) per la seconda volta richiamato in servizio. Un “uomo bravo” secondo un testimone[14] che spesso lo accompagna alla stazione dalla casa dove abita, sul vicino Colle dell’Uccelliera. Da due giorni incertezza e inquietudine gravano sulle guarnigioni di un esercito lasciato senza direttive dopo la fuga del re e del generale Badoglio a Brindisi. Forse già nelle ore immediatamente successive all’annuncio la mancanza di ordini ha prodotto anche lì qualche riuscito tentativo di fuga. Il giorno 10 settembre[15] verso metà mattinata, il campo è in allerta. Qualcuno ha avvertito del prossimo arrivo di una pattuglia tedesca che, infatti, giunge poche ore dopo dal vicino aeroporto di Tassignano dove è di stanza la Luftwaffe. Non sono molti, i tedeschi: arrivano in moto e sidecar, forse soltanto in quattro, ma ben armati. Intimano la consegna del campo, dei prigionieri e della relativa documentazione. Cione non obbedisce, forse perché spera ancora di poter ottenere ordini superiori, forse perché preoccupato per la sorte dei soldati e dei prigionieri. [16] Certo è che non riconosce subito l’autorità degli avieri del Reich, non si piega immediatamente agli ordini seccamente impartiti. Sulla dinamica dell’episodio si sono date versioni diverse. Alcune testimonianze, nessuna però “in presa diretta”,[17] hanno attribuito l’inizio dell’eccidio (a questo, più che a un vero scontro a fuoco mi pare assimilabile) a cause accidentali: un gesto di sorpresa male interpretato, il terreno sconnesso, le mani alzate in segno di resa. Incidenti, dunque, che avrebbero provocato la “reazione” tedesca, ovvero le raffiche di mitra che freddano, insieme a Cione, il capitano Massimo De Felice e il soldato Felice Mastrippolito, mentre un altro ufficiale resta ferito. È lecito dubitare di questa versione. Quella forse più rilevante (anche se riferita),[18] è del trombettiere del campo, Giuseppe Mangino, presente ai fatti. “Beppe” raccontò chiaramente, la sera stessa, di un allarme da lui suonato su ordine di Cione e del suo netto rifiuto di consegnare il campo. “E subito lo mitragliarono all’istante“. Una “postura” resistenziale, dunque, diversa da quanto accade a Cefalonia o a Rodi, ma espressione di valori (senso di responsabilità e protezione verso i prigionieri nemici affidati alla propria custodia; sentimento di appartenenza all’Esercito Regio, anche se in disfacimento; incompatibilità con la prepotenza brutale degli occupanti) che ritroviamo anche negli ufficiali che, al Sud, stanno ricostituendo i Gruppi di Combattimento e nella “lunga resistenza” degli IMI. I momenti che seguono immediatamente la tragedia sono di inevitabile caos. Difficile che 4 tedeschi possano controllare cosa accade lungo tutto il reticolato. Numerosi testimoni raccontano di soldati e carabinieri (anch’essi allo sbando) che aprono varchi o cancelli per far uscire i prigionieri. Non sappiamo con certezza chi, generosamente, lo fece per primo; non abbiamo i nominativi né il conteggio preciso di quanti riuscirono a fuggire e di quanti invece, soldati e prigionieri, restarono intrappolati in quel recinto che sarebbe poi diventato uno dei “Campi di Salò” riservati all’internamento civile di ebrei (pochi giorni dopo inizierà la “caccia”), oppositori, “diversi”. Abbiamo però una costellazione di episodi, belli e significativi: da quelli ricordati da A. Mancini[19] alle testimonianze rese a Galli e ai successivi studi di E. Pesi e ISREC Lucca. Perfino troppi gli esempi. La famiglia di Giulia Angelini che vuota “le casse dei vestiti” per rivestire i prigionieri; la contadina Zaira di Castelvecchio Alto, che ospita e nutre il trombettiere Beppe e altri tre paracadutisti inglesi; oppure la “Bianca” di S. Leonardo (il “maternage” delle donne fu decisivo). È tutto un pullulare di storie di solidarietà (e futura amicizia) tra chi soccorre e chi fugge, se non dal campo PG. 60, da altri distaccamenti di lavoro. A Matraia, ad esempio, dove l’assistenza delle famiglie è corale. [20] È la nascita di quella rete di protezione che estenderà il suo operato, a dispetto delle pene severissime,[21] anche a renitenti, ebrei, partigiani. Ne faranno parte luminose figure di sacerdoti che si prodigano fino all’estremo sacrificio per fornire, continuativamente e spesso in accordo con CNL e formazioni partigiane, riparo e assistenza ai perseguitati dalla Guardia Nazionale Repubblicana e dai nazisti occupanti.
Il C.P. 60 continuerà ancora per alcuni giorni ad esistere. Trasferiti i militari, deportati i prigionieri e rimasto dunque incustodito, divenne quasi interamente oggetto di appropriazione da parte della popolazione ormai allo stremo. [22] I corpi di Cione e De Felice furono portati a Lucca, nel “campo dei soldati” e deposti in un apposito sacrario, per essere poi sepolti, nel 1990, nei loro luoghi d’origine, ad Avellino e a Chieti. [23]
PROSPETTIVE FUTURE
La vicenda del Campo per prigionieri P.G. 60, fissatosi nella memoria popolare postbellica come “campo di concentramento di Colle di Compito“, ha acquistato negli ultimi due decenni, grazie anche a un’accresciuta visibilità mediatica,[24] una forte carica simbolica, travalicando il livello locale. Da un lato, l’immediata adiacenza all’annuncio armistiziale ne fa un epicentro ideale in quanto primo – unico forte e tragico – episodio di resistenza dei militari in Provincia di Lucca (e tra i primi in Toscana). Dall’altro, la concorde gara di solidarietà verso i prigionieri in fuga, che vede protagonista la popolazione del compitese, arricchisce i profili biografici ed esemplifica il nesso tra le diverse resistenze. Non mancano, certo situazioni, analoghe[25] che però, nel panorama nazionale, restano assai contenute.
A ridosso della via dei cipressi, un cippo posto nel 1993 ricorda oggi il sacrificio dei tre militari in un luogo di notevole bellezza paesaggistica: il lago della Gherardesca, zona turisticamente vocata e mèta frequente di passeggiate nella via della Memoria.
A conclusione di quanto finora esposto risulteranno forse utili due raccomandazioni: l’urgenza di sperimentare nuove forme di valorizzazione di questo importante “luogo della memoria” (benché, rispetto ad altre realtà preda di “oblio”, non sia mai venuta meno nei due decenni trascorsi l’attenzione istituzionale) e, soprattutto, l’esigenza ormai matura di procedere ad una sistematica trattazione in sede storiografica.
NOTA:
[1] Il primo, essenziale, lavoro di raccolta di una parziale ma significativa documentazione, arricchita da 19 testimonianze sui periodi in cui il campo era in funzione, si deve al pionieristico impegno del Prof. Italo Galli, appassionato conoscitore della realtà storica locale coadiuvato dalla Associazione Il Melograno. Italo Galli. I sentieri della memoria: il campo di concentramento di Colle di Compito: i documenti e le voci dei testimoni 1941-1944. Consiglio Regionale della Toscana, 2005.
[2] C.S. Capogreco, I campi del Duce, 2004 p.9; sulle norme: https://www.annapizzuti.it/normativa/testocircolari40.php
[3] I. Galli (op.cit., p.31-33) ritiene di poter assumere per la decisione formale d’allestimento il luglio 1940, anche se la costruzione inizierebbe dal 1941; la fonte è una nota del Podestà di Capannori in cui si cita un decreto (17/7/40) del Comandante della Zona di Pisa che ne dispone, insieme ad altri campi, la costruzione. Le testimonianze rese, pur se discordanti, sono perlopiù inclini a posticipare tale data. Vedi, più oltre, anche la nota n. 7. Il sito “Campi Fascisti” (che riporta documentazione d’archivio consultabile online) ne colloca addirittura al luglio 1942 la piena operatività (cfr: https://campifascisti.it) individuandolo come uno dei sette campi per prigionieri censiti in Toscana (tra cui l’ospedale di guerra per prigionieri n. 202 a Lucca).
[4] Lo scherzoso addio ai beccaccini lo si legge nella targa apposta il 22/8/1925 in prossimità dell’impianto idrovoro.
[5] Una relazione dell’Ufficio tecnico provinciale (LU) (20/12/1943) reca una pianta allegata: si tratta del nuovo progetto di ricostruzione (in forma più ampia, dopo lo smembramento all’indomani del 10 settembre) come “campo di Salò”, operantetra la fine del ’43 e l’inizio del ’44 (I. Galli, op. cit. p.157). Un testimone che, ‘nel 41, aveva lavoratoalla costruzione del campo parla di due casette in legno – altri invece di quattro – lunghe una trentina di mt. “imperliate e incatramate sopra”. Le costruzioni per i soldati (dall’altro lato della via vicinale) erano invece “scialbate e murate” mentre le garitte distavano tra loro 50 mt. (I. Galli, op. cit; p.130-31) e passarono dalle iniziali 4 angolari a 12. (I. Galli, op. cit, p.34)
[6] Ne fa menzione una donna di Castelvecchio C. che in data 2/7/42 chiede al podestà il permesso di vendere bibite e frutta nel campo di concentramento “che viene montato” vicino al paese.
[7] Cfr. Documenti e Studi (Isrec Lucca) n.32/2010 p. 285. Nell’incursione del 21/5/’44 fu ucciso l’industriale James C. White (Glasgow, 1889) che risulta – dalla documentazione riferita – internato lì, assieme alla moglie, fin dall’agosto del 1941.
[8] La presenza di ufficiali risulta da testimonianze e documenti, oltre che dai tragici fatti del 10/9/43. Edo Toschi, carabiniere che aveva accesso al campo, poi passato con i partigiani dell’XI zona Patrioti, parla di 9 carabinieri, un maresciallo e un centinaio di soldati in forza nell’agosto ’43 (I. Galli, op.cit. p.37). Il colonnello Vincenzo Cione(dopo il Col. Crarino Di Pietro) assume il comando il 1/10/1942. Neanche un anno dopo il suo rifiuto di consegnare il campo ai tedeschi ne segnerà la sorte.
[9] Le latrine esterne sono assi di legno sul fossato; mancano libri o simili, l’assenza di zanzariere genera 180 casi di malaria. Cfr.https://www.liberationroute.com/it/pois/1477/colle-di-compito-concentration-camp
[10] Alcune testimonianze parlano di “risse” e “pestaggi” tra bianchi e neri e di conseguente divisione degli ambienti.
[11] Al 1/8/’42 sono registrati nel campo 2.465 prigionieri di guerra. Al 30/9/’42 salgono a 3.970, così suddivisi: 2.224 inglesi, 1.737 sudafricani, e 9 di altre nazionalità. Cfr. https://campifascisti.it/documento_doc.php?n=685. Il numero dei prigionieri, fin dall’inizio costante e non molto elevato (alcune centinaia), conosce invece nel secondo semestre del ‘42 andamenti opposti: un’impennata e un crollo. Tant’è che il Prefetto Marotta, in una lettera al colonnello medico scrive (15/11/’42): “il campo dei prigionieri si sta sciogliendo e non si sa dove verranno destinati gli ufficiali medici ad esso addetti” (I. Galli, op cit. pag. 47). Nel settembre ’43 il numero risalirà a 1000-1200, forse anche di più (E. Toschi in I. Galli, op.cit., p.37).
[12] La stasi nel funzionamento del campo che risulta “ripiegato per l’inverno” meriterebbe – ci pare – una ricerca approfondita, quantomeno sulla destinazione di un numero così rilevante di prigionieri e sulla natura delle “difficoltà” insorte. Su questo aspetto anche la fonte da cui attingiamo (https://campifascisti.it/documento_doc.php?n=738) non va oltre l’esibizione dei documenti. Probabili cause della sospensione: l’inizio delle piogge, la scarsa illuminazione e l’assenza di riscaldamento.
[13] Il 23 aprile 1943, (si legge nella stessa fonte) “si propone di utilizzare alcuni prigionieri di guerra tratti dal campo n. 82 di Laterina per portare a termine i lavori di riapertura del campo. In particolare si propone per evitare gli inconvenienti che hanno portato alla chiusura del campo lo scorso inverno” di “spostare l’area cintata dalla parte opposta di quella attuale; montare le tende sui terrazzi a nord e a sud della nuova area utilizzando lo spazio centrale per le adunate e come campo sportivo per i prigionieri”.
[14] Capini Vito, in I. Galli, op.cit. p.99
[15] La data dell’episodio e del decesso di Cione (e dei due militi) verrà definitivamente certificata con rettifica del 21/4/’47 sul suo Stato di servizio. Ciononostante, alcune testimonianze raccolte da I. Galli continuano a indicare date diverse. Edo Toschi, ad es., indica, dichiarandosene certo, il 9/9 come data dell’uccisione dei tre militari.
[16] Del tutto realistica l’interpretazione di G.L. Fulvetti con cui concordiamo: “Cione cerca di guadagnare tempo per consentire la fuga sia ai suoi uomini che ai prigionieri ma i tedeschi indovinano subito le sue intenzioni”. Cfr. G.L. Fulvetti, Una comunità in guerra, L’Ancora del Mediterraneo, 2006. Fondamentale su tutta la vicenda dei prigionieri evasi e sulla assistenza ricevuta dalla popolazione del compitese (e non solo) resta: E. Pesi, Resistenze civili, M.P. Fazzi, 2010, in particolare p.111 e sgg.
[17] Cfr. I. Galli, op.cit., pagg.53-54
[18] Testimonianza di Giulia Angelini (I. Galli, op.cit. p. 124-25). “Beppe” (a cui la famiglia di Giulia forniva latte) ha mantenuto rapporti di amicizia con loro fino alla morte.
[19] A. Mancini (illustre antifascista lucchese, filologo e storico, promotore e presidente del CLN) nelle sue “Memorie dal carcere” (Le Monnier, 1986, p.49) scrive di come molti contadini, nel loro rudimentale inglese di ex emigranti in America, chiamavano i fuggiaschi: “Come, come into my house!” e li ospitavano a prezzo di grandi rischi.
[20] Storie esemplari, come quelle del carbonaio Ghigo e di Doug Harrison del North Yorkshire; oppure quella di Giuseppe Taddeucci e Thomas Dormant dell’Essex.
[21] Il decreto del governo della RSI del 9/10/’43, diffuso a mezzo stampa e manifesti, ricorda che “qualsiasi borghese italiano che potrà dare indicazioni in merito a prigionieri americani o inglesi evasi, atte a facilitare la cattura, avrà una ricompensa di L.500. Ogni borghese italiano che darà alloggio ai prigionieri o suddetti o comunque li aiuterà, sarà immediatamente arrestato e passato per le armi”. In diversi, invece, riceveranno come riconoscimento il “Diploma Alexander”.
[22] Una nota dell’Ufficio tecnico Provinciale di Lucca del 20/12/43 elenca minuziosamente i materiali asportati da ignoti con “vandalico saccheggio” (Cfr. I. Galli, op.cit. pp.157-158).
[23] La famiglia di Mastrippolito, di S. Buoro (CH), raggiunta dopo molti tentativi, lo aveva dato per disperso in Russia; si trovava invece, in licenza, al CP.60.
[24] Oltre al citato libro del Prof. I. Galli, ricordiamo: la prima delle dieci “Pillole di Resistenza” (visibile anche su canale YT Isrec Lucca) e il fumetto Come into my house, M.P. Fazzi, 2019, con testi di E. Pesi e disegni di L. Lenci
[25] Soprattutto le popolazioni dell’Appennino tosco romagnolo, fin dal settembre 1943 accolsero e salvarono dalla prigionia e dalla morte decine di migliaia di persone, ricercate e perseguitate dall’occupante tedesco e dai fascisti della Repubblica sociale italiana (https://percorsisolidarieta.istorecofc.it/)