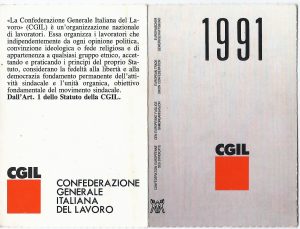Nella notte fra il 3 e il 4 marzo 2022 il mondo è rimasto con il fiato sospeso alla notizia del bombardamento russo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, una fra le più grandi d’Europa. Un evento che ha suscitato sdegno, timori, ansie e paure apocalittiche, anche sulla scorta della memoria del disastro di Cernobyl del 1986, sempre in Ucraina. Ma una notizia che in Toscana, per la precisione a Pistoia, ha anche risvegliato molti ricordi e senso di vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra, che si sono concretizzati in una serie di telefonate e messaggi al segretario provinciale della Camera del lavoro CGIL. Con il corso della storia cambiano gli stati, i confini, i sistemi di traslitterazione dall’alfabeto cirillico a quello latino, ma non erano in pochi a capire subito che si trattava proprio di quella città a lungo gemellata con il sindacato pistoiese e al tempo dell’Unione sovietica nota in Italia con il nome di Zaporojie (o con sue varianti quali Zaparojie, Zaporojki…). Chi si faceva vivo intendeva segnalare le proprie emozioni nel sentire il nome di quel luogo carico di ricordi associato all’immane tragedia della guerra, ricercando al tempo stesso tracce di quella storia e di quella memoria. Tracce che fortunatamente sono ben custodite nell’archivio storico della Camera del lavoro di Pistoia gestito dalla Fondazione Valore Lavoro, dove è conservata un’intera busta titolata proprio Zaporoje URSS, che conserva tutti i documenti del gemellaggio
Si tratta di una vicenda di cui fu promotrice proprio la CGIL locale nel 1969. Era la vigilia dell’Autunno caldo e in Italia già si respirava l’aria delle mobilitazioni degli anni Settanta, mentre nel mondo continuava il processo di decolonizzazione. L’internazionalismo, l’amicizia fra i popoli, l’unità dei lavoratori erano temi molto sentiti. L’occasione fu data da un incontro fortuito fra il Segretario della CGIL di Pistoia Giuliano Lucarelli e la delegazione dei sindacati sovietici, fra cui il Segretario generale Nicolai Romanov, al congresso nazionale della Confederazione a Livorno nel giugno di quell’anno. A seguito di uno scambio reciproco informale di disponibilità ad ospitare delegazioni sindacali, il 19 giugno e il 2 agosto Lucarelli scrisse a Mosca a Romanov per finalizzare l’accordo, allegando una scheda descrittiva sulla provincia di Pistoia con specificati i settori industriali presenti e lasciando la scelta della città da gemellare ai sovietici, dichiarando al contempo la volontà dei pistoiesi di ospitare per primi la delegazione in visita. Lucarelli aggiungeva anche che di recente un sindacalista pistoiese, Angiolo Mungai, si era recato in visita in URSS ospite dei sindacati delle istituzioni di Stato, tornando entusiasta dell’esperienza vissuta[1]. Il 12 agosto da Mosca veniva comunicato che il Consiglio dei sindacati di Zaporoje aveva risposto favorevolmente alla richiesta dei pistoiesi[2]. Ne nasceva uno scambio epistolare tra l’organizzazione di Pistoia e quella di Zaporojie, con il francese usato come lingua franca, che si prolungava per alcuni mesi, con alcuni ritardi nelle risposte dovuti anche, come apprendiamo da una lettera di Lucarelli del 14 aprile 1970, «à l’intense développement des luttes ouvriéres en Italie ces derniers mois».
Alla fine la prima delegazione sovietica da Zaporojie arrivò il 2 luglio 1970. Nel dare notizia della visita a enti locali, associazioni ed aziende del territorio la CGIL fornì anche una descrizione della città gemellata attraverso l’opera sindacale: «La regione di Zaporojié che si estende su un territorio di 27mila kmq con una popolazione di 1 milione e 700mila abitanti, è un importante centro industriale nel Sud dell’Ucraina ai confini con la Crimea. La città omonima, che conta 650mila abitanti, oltre che grande centro industriale è un importante centro culturale e di istruzione altamente qualificato. L’acciaieria di Zaporojié produce 4 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio all’anno e oltre 3milioni di tonnellate di laminati e profilati destinati alle industrie ferroviarie, trattoristiche, automobilistiche. Occupa 17mila operai (di cui 6.000 donne) 1.400 ingegneri e tecnici, 500 impiegati. Un altro colosso è la “Zaporojski Transpormaber Zavod”, che produce attrezzature elettriche e soprattutto trasformatori per 50 milioni di Kilovolts-ampere all’anno. La sua manodopera, in larga parte formata da giovani e ragazze, è costituita da 12.000 operai e 2.300 tecnici e impiegati. Anche l’agricoltura è altamente sviluppata. Zaporojié è un importante centro culturale con 135 scuole generali dell’obbligo con 10 anni di frequenza, 10 Istituti Tecnici e Facoltà di Ingegneria, di Medicina, di Pedagogia, di Ricerca scientifica ecc. Nella città vi sono 128 Biblioteche, 30 cinema, studio televisivo, il Palazzo della Cultura ecc.» [3].
Il programma della visita, che si prolungò fino all’11 luglio, non trascurava niente e portava i sovietici a stretto contatto con il territorio. Furono invitati ad incontrare la delegazione gli altri sindacati, CISL e UIL, i partiti PCI, PSI e PSIUP, l’ARCI[4], furono richiesti materiali per organizzare visite alle bellezze artistiche della città all’Ente provinciale per il turismo, si chiese a Renato Risaliti, storico dell’URSS e dell’Europa orientale ed al tempo impegnato anche nella politica locale, di fornire la sua opera di conoscenza linguistica[5] , furono organizzati gli incontri con i comuni e la Provincia e con le aziende del territorio ed anche ì colazioni con le diverse case del popolo, fra cui quella del Teso sulla montagna[6]. Di numerose aziende disponiamo della risposta positiva ad accogliere la delegazione: Arco di Montecatini (confezioni); Unione cooperativa della Valdinievole; Fratelli Capecchi piante[7]. Dal programma sappiamo anche che la delegazione visito la Supercoop di Montecatini, le municipalizzate ad Agliana, la centrale del latte, il centro riconversione rifiuti solidi, lo zoo, l’azienda Franchi, la cooperativa Di Vittorio, l’oleificio cooperativo di Lamporecchio. La SMI rispose freddamente comunicando di aver trasmesso l’invito alla propria Direzione generale[8], poi se ne perdono le tracce. La Breda invece si rifiutò di accogliere la delegazione nel proprio stabilimento, provocando la reazione ferma della CGIL che scrisse all’Intersind accusando la Direzione aziendale di addurre motivi fittizi[9]. Nel saluto alla delegazione, ricevuta in Camera del lavoro, Lucarelli rivendicava le lotte dell’autunno del ’69 che avevano coinvolto numerose categorie anche localmente e rilanciava l’unità internazionale dei lavoratori per la pace e contro il capitalismo e l’imperialismo: «È con questa visione internazionalista e di unità del movimento operaio internazionale , che abbiamo voluto allacciare rapporti fraterni con i rappresentanti dei sindacati di Zaparojié per conoscersi più a fondo, nell’intento di contribuire tutti assieme alla battaglia generale che i lavoratori di tutto il mondo conducono per la pace, contro l’imperialismo, contro le forze totalitarie e fasciste, per l’emancipazione dei lavoratori, la libertà dallo sfruttamento capitalistico»[10].
Nel 1972 fu la volta della visita dei pistoiesi a Zaporoije. Inizialmente doveva svolgersi nel 1971 ma un’improvvisa e grave malattia di Lucarelli – che in seguitò venne a mancare – fece saltare il viaggio. Nonostante la grave perdita del promotore del gemellaggio l’iniziativa andò avanti e la delegazione che si recò in URSS nel 1972 fu composta anche da un rappresentante della CISL, Sauro Gori, su esplicita richiesta dei sovietici di includere gli altri sindacati italiani[11], e fu guidata da Silvano Cotti, nuovo segretario della Camera del lavoro. Il gruppo, composto anche da Duilio Puccianti del consiglio di fabbrica della SMI e da Paolo Innocenti della FILLEA di Montecatini, arrivò in URSS il 30 agosto. La stampa sovietica diede risalto alla visita dei sindacalisti italiani. Oltre ai consueti incontri nelle sedi sindacali, la delegazione fu portata a visitare la diga sul Dnepr, i servizi sociali, la palestra sul ghiaccio, l’acciaieria, le case di riposo, i centri culturali, i gruppi di pionieri, i servizi sanitari, incontrò il sindaco, si recò sul mare d’Azov dove visitò anche un sovchoz e un asilo. Tra le altre, il gruppo visitò anche un’azienda dove venivano prodotti i materiali oleosi per lo stabilimento FIAT di Togliattigrad. Durante la permanenza uno degli italiani, Puccianti, si ammalò e venne ricoverato in una clinica sovietica, dove rimase in osservazione per diversi giorni essendogli stati diagnosticati problemi renali seri che vennero curati in loco. Di conseguenza il Puccianti rientrò in Italia successivamente al resto del gruppo. In una lettera inviata a Pistoia durante la degenza esprimeva una valutazione che racchiudeva tutte le speranze che ancora buona parte degli operai italiani riponevano nell’URSS a quel tempo: «vi dirò che i medici sono sorpresi che nelle attuali condizioni fisiche si possa ancora essere operai metalmeccanici, anche se valutiamo tutta l’attenzione ed il valore che essi danno della persona e dell’uomo, e non come da noi dopo la macchina»[12].
La soddisfazione della delegazione italiana per la visita fu tale che il 30 settembre il Cotti inviò una lettera al sindaco di Pistoia, il comunista Francesco Toni, per invitarlo a prendere in considerazione un gemellaggio anche istituzionale con Zaporojie, rispetto al quale il sindaco della città ucraina aveva già dimostrato a voce un interesse[13].
Negli anni successivi i rapporti fra i sindacati di Zaporoje e quelli di Pistoia andarono avanti. Lo scambio di auguri in occasione del Primo maggio, del nuovo anno ed anche per le feste della Liberazione divenne abituale e furono organizzati nuovi scambi. Nel 1973 i pistoiesi invitarono nuovamente i sovietici per il 1974, questi ultimi si resero disponibili a tornare nel 1975[14]. La seconda visita avvenne nel mese di settembre per esplicita volontà della Camera del lavoro che voleva far partecipare i sindacalisti sovietici alle celebrazioni della Liberazione di Pistoia l’8 settembre. La visita però, inizialmente prevista dal 4 all’11 del mese, all’ultimo momento slittò al 18-25 settembre. Da un appunto manoscritto sappiamo che Sanguinetti dell’ufficio internazionale della CGIL a Roma aveva indicato per quell’occasione di «avere con sindacati sovietici rapporto più vivace aderente alla nuova realtà internazionale. Cile, Portogallo, cosa facciamo…? Porre esigenza che nei rapporti – a livello internazionale – fra CGIL e sindacati sovietici, si esca dal semplice formalismo degli “evviva” e si istauri rapporto più politico, che affronti problemi “nuovi” che emergono nel mondo»[15]. La delegazione era composta da Petr Pavlov, segretario regionale, Victor Kazatchovsky, presidente comitato sindacale dell’azienda Azovcabel, e da Nicolai Medvedkov. Fu organizzata anche una visita a Collodi al Parco di Pinocchio, circostanza che alcuni mesi dopo diede luogo alla donazione al Parco delle edizioni in lingua russa delle Avventure di Pinocchio, a quanto pare molto diffuse in Unione sovietica[16]. Nonostante il ritardo rispetto alle celebrazioni resistenziali, in quell’occasione fu comunque organizzata una visita nel paese di Agliana al monumento dedicato al partigiano sovietico Ivan Baranovskij, nome di battaglia Paolo, combattente della Brigata Bozzi caduto in quella località, una visita alla Breda – che questa volta non si negò – con un incontro con il Consiglio di fabbrica e un incontro con gli operai della Ital Bed in “assemblea permanente” da diversi mesi[17]
La delegazione pistoiese tornò in URSS nel 1978, questa volta composta da Graziano Battiloni della segreteria CGIL, Floriano Frosetti del consiglio di fabbrica Breda e Marcello Vettori del sindacato enti locali[18]. Nel consueto discorso di saluto, oltre ai temi all’ordine del giorno del programma sindacale che venivano sempre richiamati, Battiloni ricordò Baranovsky ed enfatizzò in più occasioni il successo elettorale delle sinistre, e del PCI in particolare, alle elezioni politiche del 1976[19].
Nonostante l’uscita della CGIL dalla Federazione sindacale mondiale (FSM) legata all’URSS in favore dell’adesione alla Confederazione europea dei sindacati (CES) a fine anni Settanta, nel novembre del 1980 una nuova delegazione sovietica giungeva a Pistoia, composta da Juri Vladimirovc Efrenov e Valentin Vassilievic Podporin. Il discorso di saluto di Battiloni era però molto diverso da quegli degli anni Settanta. L’accento si spostava dalle lotte operaie e dalla vicinanza con il paese della rivoluzione del ’17 ai temi della politica internazionale del tempo, assicurando l’azione di contrasto alla guerra fredda e di sostegno alle politiche di disarmo del sindacato italiano, condannando la politica americana in Iran e l’espansionismo israeliano ma sottolineando anche che «gli avvenimenti della Polonia aprono, nella società polacca, importanti possibilità di sviluppo democratico» e che «il sindacato italiano ha espresso, a suo tempo, la contrarietà e il disaccordo per l’intervento sovietico in Afghanistan. Per questo, facciamo un appello perché, attraverso la vostra delegazione sia accelerato il ritiro delle truppe e sia garantito al popolo afghano il diritto a decidere da sé le proprie scelte». Parole forti, che si tentava poi di stemperare richiamando l’amicizia tra gli italiani e il popolo sovietico e la volontà di non rompere il sodalizio anche a fronte di disaccordi su alcune scelte, perché fra amici era lecito rimproverarsi qualcosa[20].
Quella del 1980 fu l’ultima visita. Da lì in poi gli scambi si interrompono. L’archivio tace sui motivi, che tuttavia è lecito ipotizzare vadano ricercati nei mutati rapporti che le parole di Battiloni del 1980 facevano cogliere, nella nuova collocazione internazionale della CGIL ed anche nella situazione particolarissima che l’URSS attraversò nel corso degli anni Ottanta fino alla sua dissoluzione. Tuttavia, almeno per i pistoiesi, sembrava trattarsi di una pausa più che di un addio. Il gemellaggio doveva essersi radicato fra i sindacalisti italiani. Lo testimonia l’ultimo fascicolo della busta d’archivio, titolato 1990 Zaporozhye. Nel clima post ’89 a Pistoia si pensò subito di riallacciare i rapporti di scambio. Ma evidentemente era troppo tardi, il mondo cambiava inesorabilmente, di lì a poco l’URSS cessava di esistere e dei sindacati di Zaporojie si perdevano le tracce. Il fascicolo era destinato a rimanere vuoto, testimone silenzioso di una volontà mai concretizzatasi.
Da quest’ultimo tentativo sono passati più di 30 anni ed è arrivata una centrale nucleare che prima non c’era. Del gemellaggio il ricordo si era affievolito fin quasi a scomparire. Ma non del tutto. La tragica notizia del bombardamento ha spazzato via la polvere che si era depositata su questa vicenda, ed a Pistoia, come già nel 1990, ci si è ricordati della città sulle rive del Dnepr. La Camera del lavoro ha interrogato i propri archivi prendendo spunto da questa amicizia del passato per lanciare un appello pubblico per la pace. Battiloni, ormai anziano, intervistato dai giornali locali ha ricordato con emozione quel tempo e quei viaggi, ed anche i punti di divergenza con i sovietici che erano progressivamente emersi, vivendo con sofferenza i fatti di guerra del presente[21]. Una piccola storia di amicizia internazionale, che continua a scagliarsi contro la grande storia della guerra fra i popoli.
[1] Archivio storico Camera del lavoro CGIL Pistoia, Busta Zaporoje URSS (d’ora in poi ASCGILPT, B. Zaporoje), Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettera di Lucarelli al Segretario generale dei sindacati sovietici 19 giugno 1969; lettera di Lucarelli a Romanov 2 agosto 1969.
[2] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettera del 12 agosto 1969 a firma Sergueev, originale in cirillico copiata in traduzione francese.
[3] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, modello di lettera del 1° giugno 1970.
[4] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettere dl 27 giugno 1970.
[5] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettere del 26 giugno 1970.
[6] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, Programma visita delegazione sovietica Zaparoje’ 30 giugno 1970.
[7] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS.
[8] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettera della Società metallurgica italiana del 4 giugno 1970.
[9] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettera di Lucarelli del 26 giugno 1970.
[10] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, Saluto del segretario generale della CCdL di Pistoia alla delegazione dei sindacati di Zaparojié nell’URSS.
[11] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Rapporti sindacati Zaporoje URSS, lettera di Nedobyvailo a Lucarelli, originale in francese; lettera di Lucarelli alla CISL del 13 aprile 1971; lettera di Lucarelli al Presidente del consiglio dei sindacati di Zaporojie Nedobyvaile del 4 maggio 1971. ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, lettera del 31 luglio 1972.
[12] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, resoconto manoscritto del viaggio; lettera manoscritta di Puccianti del 7 settembre 1972.
[13] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, lettera di Cotti a Toni del 30 settembre 1972.
[14] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, lettera di Silvano Cotti a Pavel Nedonuyailo e la risposta.
[15] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. 1975 visita delegazione Zaporozhye (URSS), appunto manoscritto. Le sottolineature sono nell’originale.
[16] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. 1975 visita delegazione Zaporozhye (URSS), lettera del 9 gennaio 1976.
[17] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. 1975 visita delegazione Zaporozhye (URSS), documento Una delegazione dei sindacati sovietici di Zaporojie ospite della nostra provincia.
[18] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, comunicato stampa del 1° agosto 1978.
[19] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc. Zaporojie 1972-1978, discorso di saluto manoscritto.
[20] ASCGILPT, B. Zaporoje, Fasc.1980 Zaporoje URSS delegazione materiale. Documento Battiloni saluto alla delegazione di Zaporoje 24 novembre 1980.
[21] La nazione, 6 marzo 2022; Il giornale di Pistoia e della Valdinievole, 11 marzo 2022.
Stefano Bartolini, direttore della Fondazione Valore Lavoro e della rivista “Farestoria”, responsabile degli archivi CGIL Toscana e coordinatore del gruppo dell’AIPH dedicato alla Public History del lavoro. Fa parte della redazione della rivista Il De Martino. Ha pubblicato articoli di approfondimento sulla Public History sulle riviste “Clionet” e “Officina della storia”