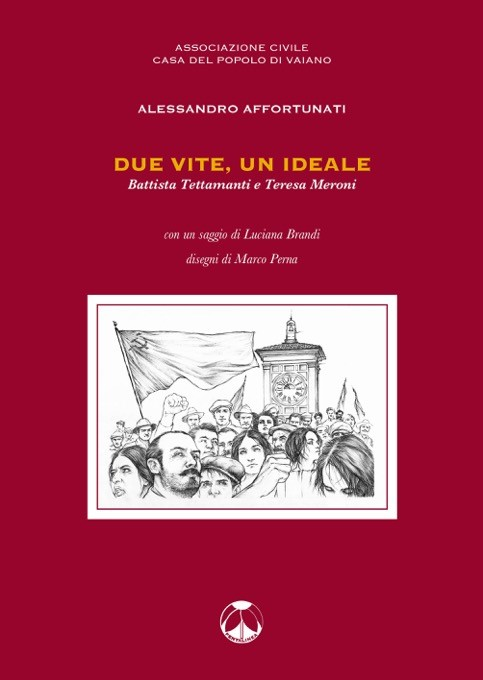L’operaio che guidò la Regione Toscana

Gianfranco Bartolini, classe 1927, nasce a Fiesole il 17 gennaio e proprio questa terra, dove abiterà fino alla sua scomparsa nell’ottobre del 1992 segna in modo indelebile la sua attività, politica e istituzionale. Autodidatta (ha la quinta elementare), figlio della sua generazione, dove il mestiere si imparava “a bottega”, all’età di otto anni inizia a lavorare come fabbro presso il negozio del padre Domenico in via Matteotti a Fiesole.
A quattordici era già operaio allo stabilimento delle Officine Galileo dove l’impegno politico e antifascista, certamente attinto in ambito familiare – il padre era stato consigliere comunale socialista prima dell’avvento al potere del fascismo – comincia a farsi largo nell’indole di un ragazzo che, già dalla giovanissima età, mostrava convinzioni culturali e impegno civile. Più volte ricordato come uomo ‘del fare’, Bartolini sussume pienamente quel clima di militanza collettiva, di impegno civile e municipale che caratterizza gli anni successivi al dopoguerra, avendo già partecipato come partigiano alla lotta di liberazione nel 1944. Proprio la Resistenza rappresenta un capitolo molto importante per la sua vita e per la sua città natale, Fiesole. Durante la terribile esperienza del passaggio del fronte nell’estate del 1944, anche quest’ultima fu infatti gravata – in particolare nel mese di agosto – dal peso e dalla violenza dell’occupazione nazista, culminante nel noto eccidio dei tre carabinieri. In questa fase i Bartolini svolsero un ruolo molto importante. Mentre il padre di Gianfranco si impegnò a lungo per aiutare la popolazione locale a sopravvivere nella situazione di emergenza, il figlio – al tempo diciassettenne – fu protagonista di alcune azioni di guerra con la “Banda partigiana di Fiesole” (poi diventata SAP di Fiesole) dipendente dal CLN cittadino fino alla liberazione avvenuta il 1° settembre.[1]
Le Officine Galileo segnano un altro momento fondamentale della sua vita. Dopo aver rivestito il ruolo di Segretario nella Commissione interna della grande fabbrica fiorentina, venne infatti chiamato alla segreteria della Camera Confederale del Lavoro di Firenze negli anni ’60 del XX secolo, diventandone segretario nel 1965. Dirà di lui Giorgio Napolitano che proprio il suo impegno come dirigente sindacale, la sua militanza politica, l’esperienza del lavoro in fabbrica sono state le prove superate con serietà, impegno e sobrietà che gli hanno permesso di diventare un autentico uomo di governo.
Solo 6 anni più tardi, nel 1971, ebbe l’incarico di segretario regionale della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), entrando nel Direttivo nazionale della CGIL e della Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL.
Ma il legame con le radici rimase sempre inalterato e l’impegno politico lo vide entrare nell’amministrazione comunale di Fiesole giovanissimo. Già nel 1951, all’età di 24 anni, capolista del Partito comunista, riportò 215 voti di preferenza a fronte dei 644 voti ottenuti da Luigi Casini, rappresentante del Partito socialista e figura emblematica dell’antifascismo fiesolano. Alle elezioni amministrative successive (nel 1954, quando lo stesso Casini conseguirà 341 voti e Gianfranco 510) viene rieletto e riconfermato Assessore ruolo che manterrà fino al 1964.
Il suo sguardo attento di Assessore al bilancio non mancava di osservare i limiti oggettivi della cittadina collinare e il difficile rapporto con il capoluogo di Regione; è nel commentare il bilancio del 1964 che ebbe a dire:
Fiesole è oggi sempre più pressata dai bisogni che sono bisogni propri di una città moderna, una città che adesso è un po’ la periferia di Firenze […] È un problema che investe un po’ tutti i Comuni limitrofi, ma specialmente Fiesole ne risente in misura maggiore per cui il suo bilancio va sempre più in deficit. [Noi] non siamo certo in grado, oggi, di poter assicurare a Fiesole questi servizi che dovrebbero essere, io penso, in dotazione ad una città moderna, e forse non lo saremo mai […]. Fiesole ha un po’ il carattere di “Città – dormitorio”, infatti il Capoluogo ha avuto un certo sviluppo edilizio costituito da una serie di villette per il ceto medio, mentre nelle frazioni si è visto uno sviluppo per l’edilizia popolare per operai, ecc. …[2]
D’altro canto l’economia era la sua “fissazione”, non solo per retaggio sindacale, ma anche per la convinzione che il modello toscano dei distretti fosse un successo e che quindi intrecciare impresa, infrastrutture, attrezzature del territorio, mondo dell’università e della ricerca fosse il perno sul quale progettare il futuro. Bartolini aveva la percezione, e ciò emerge spesso nei suoi discorsi, che i meccanismi di globalizzazione in atto stiano portando l’industri italiana, il sistema produttivo, l’economia in generale verso il declino.
Sarà il 1975 a segnare la sua piena maturità politica, quando già Consigliere provinciale a Firenze, venne eletto con la seconda legislatura al Consiglio della Regione Toscana: nella lista del Pci e nella circoscrizione di Firenze, riportò 9.488 preferenza e divenne Vicepresidente della Giunta Regionale (Vicepresidente di Lelio Lagorio e, dal settembre 1978, di Mario Leone) con la responsabilità diretta della programmazione economica e del bilancio.
Alle consultazioni successive, giugno 1980, conquistò 15.489 preferenze e per questo è confermato nei suoi incarichi Vicepresidente e Assessore (sempre a programmazione e bilancio, con Presidente Leone) divenendo – dal 31 maggio 1983 – presidente della Giunta, carica che assume, pur modesto e schivo di carattere, con il fermo impegno di tentare la ricerca di soluzioni di governo e la collaborazione con realtà internazionali facevano perno sull’idea e sulla pratica della programmazione.[3]
Le vicende politiche regionali lo portano, infatti, alla guida di un governo “quasi” monocolore, retto da una scarsa maggioranza che godeva di un’altrettanto scarsa fiducia, soprattutto da parte dei vecchi alleati del Psi, che lo consideravano debole, soprattutto a causa del suo insediamento sociale “limitato alla classe operaia”.[4]
Eppure ci si dovette ricredere e accettare che il temuto monocolore rappresentasse, in realtà, una risorsa volta verso un impegno comune per l’innovazione del sistema produttivo, un confronto diretto con le forze sociali, con l’imprenditoria, con la Chiesa e con le Forze armate. Dall’’85 al ’90, con la fine naturale della terza legislatura, l’alleanza di governo sarà più ampia: una compagine determinata dal rientro dei socialisti e l’avvento dei socialdemocratici; ma per le Regioni saranno anche gli anni più difficili: da una parte il Governo le considera meri uffici decentrati dall’altra il Parlamento legifera in tutti i campi regionali.
Gianfranco Bartolini affronta la sfida da riformista e regionalista convinto. Del resto, già nel 1984, come Presidente di turno della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, aveva consegnato al Presidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Aldo Bozzi, la proposta della Camera delle Regioni. Un Governo Regionale in fieri e in via di stabilizzazione, uno sviluppo delle autonomie locali, un’idea – insomma – regionalista e autonomista della quale Bartolini si fa portavoce e promotore in grado di accettare e gestire le sfide della modernità, facendo perno sull’idea e sulla pratica della programmazione:
Bartolini si cimenta in particolare modo con un’idea di programmazione “concordata e contratta”, e lo fa con modernità e apertura; batte e ribatte su esigenze cruciali di innovazione; non si chiude in vecchie visioni statalistiche ma sostiene “nuovi rapporti tra pubblico e privato”, difende “una sorta di gemellaggi tra la Regione e le imprese”, suggerisce “intese che si propongano di suscitare investimenti e occupazione, di dare risposta ai problemi dello sviluppo tecnologico, di affrontare quelli dell’ambiente e delle infrastrutture”.[5]
Rimarrà in carica per l’intera durata della quarta legislatura del governo toscano, fino al 1990, mantenendo ininterrottamente la delega per le politiche della programmazione e i rapporti con il Parlamento, il Governo e Comunità Europea. Come era nella sua natura, o forse come gli aveva insegnato l’esperienza, negli anni in cui si pone a guida della Regione Toscana non perse occasione per intrecciare rapporti di varia natura: il dialogo e il confronto si sviluppava verso ogni espressione della società toscana partendo dalla cittadinanza, passando per il mondo dell’industria e dell’imprenditoria, rivolgendosi all’associazionismo e alle cariche vescovili, fino alle più alte sfere istituzionali. Questa fitta rete di relazioni rispecchiava la sua naturale tendenza alla concretezza nell’agire locale, legandosi, d’altra parte, a un’interpretazione dei fatti globale e internazionale. Non a caso poi, all’inizio del 1989, di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, traccia un importante bilancio del regionalismo italiano esordendo proprio con la dimensione europea di questo movimento[6].
Gianfranco Bartolini esprime un riformismo forte. Ancorato alla fermezza dei valori, alla fine degli anni ’80 già intravedeva un’era di crisi politica, l’assenza di grandi propositi di rinnovamento dovuta, forse in parte, anche alla paralisi delle istituzioni marchiate da un centralismo soffocante che alimentava “le diseguaglianze e il divario fra le aree del paese, aprendo varchi pesanti a larghe fasce di illegalità e a fenomeni che reclamavano la centralità della questione morale”. La libertà, affermava, non può tradursi nelle ingiustizie e nelle inefficienze che vanno mortificando l’intera società e piegando la democrazia agli interessi dei più forti.[7]
Non solo sull’economia tout-court si basava però la sua azione di governo: la difesa del suolo,[8] il regionalismo, l’autonomia statuaria, le “aree vaste” come risposta alla crisi della società toscana. Su quest’ultimo tema, affrontato per la prima volta in maniera organica in occasione del dibattito in Consiglio regionale, avviato dall’approvazione del Programma regionale di sviluppo 1988-1990, Bartolini svilupperà un’approfondita analisi sulle difficoltà che il sistema policentrico toscano stava affrontando sul piano economico. Se le strategie interne non sono più in grado di garantire le condizioni necessarie e i livelli di efficienza adeguati per attestarsi sui mercati sarà necessario “individuare nuovi ambiti, all’interno dei quali sia possibile stabilire le condizioni necessarie per annullare le diseconomie esistenti e per rilanciare il policentrismo, che è un valore nella nostra regione, ma ad una scala diversa e meno angusta, se vogliamo stimolarne il rilancio e fargli ritrovare il dinamismo del passato”. [9]
Gianfranco Bartolini muore a Firenze il 10 ottobre 1992.
Elena Gonnelli, archivista, direttrice della sezione Montecatini Terme-Monsummano dell’Istituto storico lucchese, collaboratrice dell’Istituti storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea per il quale ha curato l’inventario del fondo G. Bartolini e la mostra “Gianfranco Bartolini: il sindacalista, l’amministratore, il Presidente”.
Note:
[1] I. Tognarini in La Toscana e il Riformismo: una riflessione a 15 anni dalla scomparsa di Gianfranco Bartolini, Associazione Autonomie Locali Legautonomie Toscana, Pisa, 2009, p. 22.
[2] G. Bartolini. Il governo regionale cit., pp. 13-15.
[3] Archivio Comunale di Fiesole, Delibere del Consiglio Comunale, Serie I, n. 44, 25/03/1964
[4] P. Ranfagni, Il coraggio della sfide, in Gianfranco Bartolini. Un uomo del popolo alla guida della Regione, a cura di P. Ranfagni, Direzione generale della Presidenza Giunta Regione Toscana, Firenze, 2014, pp. 20-24.
[5] G. Napolitano, Presentazione in G. Bartolini. Il governo regionale, a cura di M. Badii, F. Gigli, P. Ranfagni, Edizioni della Giunta Regionale, Firenze,1995, p. 14.
[6] Archivio Gianfranco Bartolini, d’ora in avanti AGB, Scritti e discorsi, b. 10, 33.14, 1989.
[7] I. Tognarini in La Toscana e il Riformismo, cit., pp. 19-28.
[8] Bartolini stigmatizzerà più di una volta la mancanza di una normativa nazionale per la difesa del suolo, lamentando in generale l’assenza dello Stato su queste tematiche, facendo particolare riferimento all’alluvione del 1966 di Firenze e la Toscana. Cfr. AGB, Scritti e discorsi, b. 8, 30.33 e 30.36, 1986.
[9] AGB, Scritti e discorsi, b. 9, 32.15, 1988. Sul concetto di “area vasta” (compresa la Firenze-Prato-Pistoia) e su quello, conseguente, della Città-metropolitana Bartolini tornò molte volte, anticipando il varo della legge 142/90.
Articolo pubblicato nel luglio del 2018.