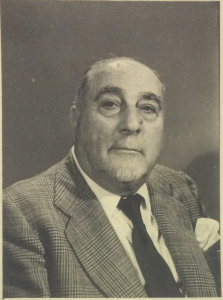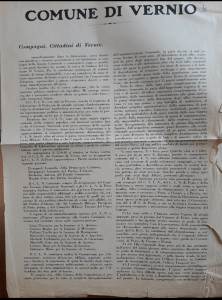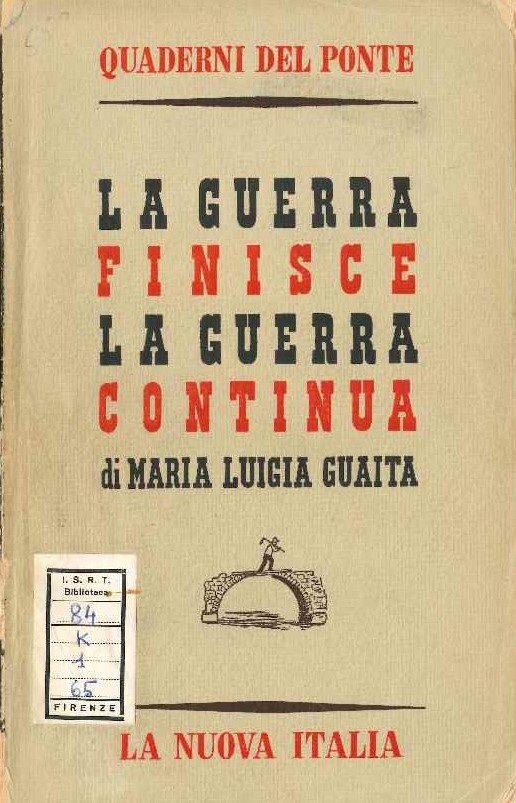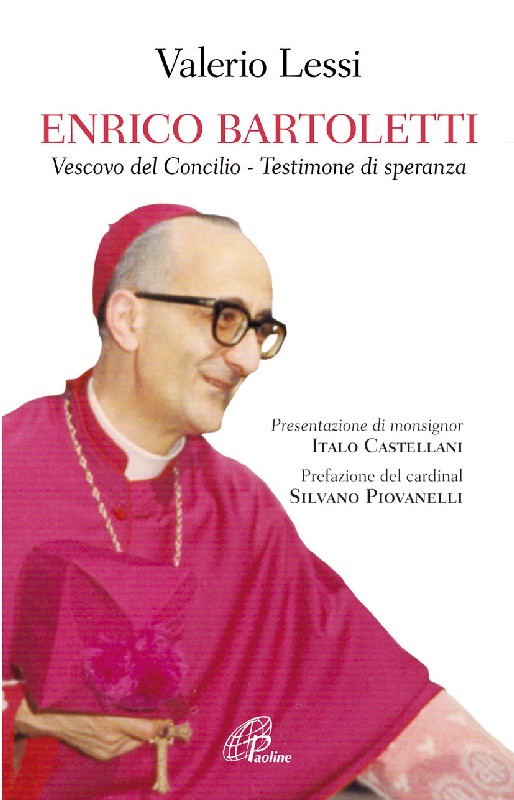PISA 1944, IL RITORNO DEL GATTOPARDO

Dall’incrocio di archivi pubblici e privati, il racconto di come, nel caso emblematico di Pisa, poté imporsi quella continuità di uomini e apparati che segnò il dopoguerra[1].
Per vent’anni aveva vissuto in esilio a Roma, sognando ogni giorno il grande ritorno. Con la Liberazione il momento era arrivato. In una provincia devastata dalla guerra, c’era chi invocava l’avvento di un ordine nuovo. Lui no: già settantenne, ma in ottima forma, lui voleva chiudere in fretta non solo la “parentesi fascista”, ma anche quella partigiana.
Così tornò a Pisa l’ex Ministro Arnaldo Dello Sbarba nell’anno di grazia 1944. Agendo da regista tra Roma, la “sua” Pisa e l’ancor più “sua” Volterra, strinse la giovane forza dei CLN in una morsa di poteri convergenti: prefetti, partiti moderati, governo Bonomi, tribunale, stampa. Ecco come fece e chi lo aiutò.
Collesalvetti, 31 agosto 1944: il CLN di Pisa tiene la sua ultima riunione clandestina. I nazisti abbandonano la linea dell’Arno, dopodomani si entra in città. Tutti i ponti sono stati fatti saltare, la guerra ha fatto migliaia di vittime. Ma in quest’ultima seduta si respira l’aria dei giorni grandi. Vanno nominati gli uomini che la rivoluzione democratica insedierà ai vertici di tutti gli enti pubblici, dal comune agli ospedali, dalla Cassa di Risparmio alla polizia municipale. Come sindaco viene proposto Italo Bargagna, commissario politico della 23a Brigata bis Garibaldi “G. Boscaglia”; come questore Alberto Bargagna, comandante della stessa Brigata Garibaldi; come prefetto il comunista Armando Monasterio. Su ogni nomina il CLN dovrà fare i conti con il governatore militare alleato. E mette le mani avanti: “Si delibera di mandare una relazione al governo di Roma allo scopo di evitare la nomina di Dello Sbarba a prefetto di Pisa”[2].
Da giorni circolano voci in proposito. A Roma il governo del CLN è guidato da Ivanoe Bonomi, che ha resuscitato un “Partito democratico del Lavoro” (PDL) raccogliendo vecchi notabili del prefascismo. Per Claudio Pavone “partito trasformista per eccellenza”[3]. Si sa che Bonomi, nell’Italia già liberata, sta sostituendo i “prefetti del CLN” con funzionari di carriera o con compagni del suo stesso partito. A Roma ha nominato prefetto Giovanni Persico, suo braccio destro.
Si sa che Arnaldo Dello Sbarba è tra i cofondatori di questo PDL: “A Roma, prima del 25 Luglio – racconta lui stesso – io mi tenevo in contatto con alcuni dei principali esponenti dell’antifascismo”[4]. Si sa che nella Siena appena liberata è stato lo stesso CLN a proporre a Dello Sbarba di fare il commissario dell’ospedale di Santa Maria della Scala. Lui ha declinato l’invito: gli interessa tornare a casa. A Volterra. E poi a Pisa.

Anni ’20, Arnaldo Dello Sbarba, (secondo da destra) ministro del governo Facta, in una cerimonia a Roma
L’ex ministro conta su protezioni altolocate. Come quella di Adalberto Berruti, potente capo di gabinetto al Ministero dell’interno (che il presidente Bonomi ha tenuto per sé). Berruti è stato prefetto di Pisa dal 1941 al 1943: “In quel periodo – scriverà Berruti – ebbi occasione di conoscere l’on. Arnaldo Dello Sbarba e di avere con lui, in parecchie circostanze, colloqui e scambi di vedute. Ebbi così modo di apprezzare l’elevatezza di pensiero e di sentimento dell’on. Dello Sbarba. Dopo il 25 luglio 1943 fu tra i miei più validi collaboratori nella liquidazione del fascismo pisano”[5]. I due non si erano più persi di vista. Appena lasciata Pisa, Berruti aveva ricontattato Arnaldo: “Eccellenza, le mando da Roma il mio saluto. Conservo di Lei il miglior ricordo e mi auguro di incontrarla presto”. Come dire: si tenga pronto[6].
Berruti è un piemontese la cui antipatia verso i fascisti è pari al suo rigore istituzionale[7]. Diventato capo di gabinetto, Berruti ha voce in capitolo sulla nomina dei prefetti. Pisa gli sta particolarmente a cuore. Vi destina quindi un suo uomo di fiducia: Vincenzo Peruzzo. Anche la vita di Peruzzo si era già incrociata con quella di Arnaldo Dello Sbarba. Peruzzo era stato dal 1921 al 1922 al Gabinetto per le pensioni di guerra nel governo in cui Arnaldo era ministro del lavoro. La carriera di Peruzzo aveva attraversato il fascismo. Per otto anni aveva addirittura lavorato per l’ufficio stampa di Mussolini. Il suo rapporto col regime si era guastato con la guerra: “Per noi – scrive nella sua autobiografia – si sarebbe comunque conclusa con una disfatta: soggiogati dai tedeschi vincitori, o vinti dagli alleati”[8].
Vincenzo Peruzzo arriva a Pisa il 7 settembre 1944: è “il primo prefetto dopo la Liberazione”. Scosso dalle drammatiche condizioni della città, Peruzzo se ne prende cura con una dedizione che la gente ammira. Con la politica però è diverso: ha rapporti difficili col sindaco Bargagna, consulta il meno possibile i CLN, appena può sostituisce i sindaci nominati dalla Resistenza, soprattutto se comunisti. Ai politici preferisce i tecnici. “Ma i tecnici da lui nominati – scrive Carla Forti nel suo saggio su Pisa nel dopoguerra – sono immancabilmente o rappresentanti dei poteri forti, o funzionari pubblici in carica nel precedente ventennio”[9].
Peruzzo lega subito con Arnaldo. Già il 5 ottobre – ignorando i desiderata del CLN – lo nomina commissario della Cassa di Risparmio di Pisa. “Dopo i primi sondaggi con le autorità locali e con le persone più autorevoli dell’ambiente pisano – racconta Peruzzo – mi parve di aver scelto l’uomo adatto al posto importante”.
Secondo passo. Nel novembre il prefetto nomina la giunta provinciale. “Dopo opportuni sondaggi”, Peruzzo designa come presidente il democristiano Aldo Fascetti e, tra gli assessori, l’avvocato Gino Sossi. Sossi è cognato di Arnaldo Dello Sbarba, nonché suo socio in affari e in politica.
Terzo passo. Il 23 novembre Peruzzo istituisce la “Commissione provinciale istruttoria per l’epurazione” composta dal presidente del Tribunale Tito Cangini, dal magistrato Giovanni Miele e dal matematico Leonida Tonelli. Anche Tito Cangini è legato ad Arnaldo Dello Sbarba: è stato giudice al tribunale di Volterra e presidente della locale Cassa di Risparmio[10]. In entrambi gli ambiti Arnaldo è di casa. La commissione per l’epurazione, scrive Carla Forti, “giudicherà da non punirsi quasi tutti i sospesi dal servizio”. In perfetta assonanza col prefetto che, preso in consegna dagli alleati il campo di prigionia per ex fascisti di Coltano, lo svuoterà a tempo di record dei 32.000 internati “con la liberazione – scrive ancora Forti – di quasi tutti i prigionieri”[11].
Come se non bastasse, all’inizio del 1945 il prefetto Peruzzo nomina Arnaldo Dello Sbarba anche presidente del neo-istituito “Comitato provinciale per la ricostruzione”, con l’incarico di fare “la ricognizione dei danni e le opportune proposte da sottoporre al governo per chiedere aiuti adeguati”. Il comitato ha un ruolo vitale per la ripresa economica e sociale della provincia pisana. Ma è anche uno schiaffo al sindaco Bargagna, che “senza un preventivo concerto tra noi – dice Peruzzo – aveva pure pensato di costituire una commissione”. Per Peruzzo, però, è dal prefetto e non dal Comune che devono passare le relazioni con Roma.
L’incarico per la ricostruzione offre ad Arnaldo Dello Sbarba la possibilità di dire la sua sulle scelte della città. Lo fa grazie a compiacenti interviste sul «Tirreno» diretto dal suo vecchio amico Athos Gastone Banti. Banti nel 1924 dirigeva a Firenze il «Nuovo Giornale» e aveva tentato di promuovere la candidatura di Dello Sbarba nel “Listone” fascista con una intensa campagna di stampa. Arnaldo lo compensò con due assegni da 5.000 lire firmati dal direttore della Solvay di Rosignano, generosa finanziatrice della sua carriera politica. Adesso, sul «Tirreno» di Livorno, Dello Sbarba può vantarsi della sua intimità col ministro dei Lavori Pubblici Meuccio Ruini, suo compagno di partito: “Sono mesi che io faccio la spola tra Pisa e Roma!”[12].
Oltre a Pisa c’è Volterra. Arnaldo la considera città “sua”. Ma Volterra è il baluardo della 23a Brigata bis Garibaldi “G. Boscaglia” e i partigiani pretendono l’epurazione radicale degli ex fascisti. A Volterra è forte il Partito d’azione, il più determinato a chiedere un cambio netto di classe dirigente. Presidente del CLN è l’intellettuale azionista Umberto Borgna, innovatore nell’arte dell’alabastro. Azionisti sono Giovanni Salghetti Drioli, dirigente del CLN nell’ufficio tecnico del Comune, e lo scrittore Carlo Cassola, direttore del settimanale «Volterra Libera». Membri del CLN nel giorno della liberazione sono anche il socialista Amedeo Meini, i comunisti Mario Giustarini e Fernando Frattini e il democristiano Aldo Tozzi. Ma il personale disponibile scarseggia. Così nella Giunta comunale ricorrono gli stessi nomi, ma a parti scambiate: Meini sindaco e Borgna vice, oltre a due comunisti e due socialisti come assessori e un agrario “apolitico” come unica concessione agli Alleati. In città si sono concentrati gli uomini della Brigata Garibaldi. E il governatore alleato Clive Robinson ha in linea di massima avvallato le nomine del CLN.
La più importante delle quali è il consiglio di amministrazione del grande ospedale psichiatrico che, con oltre 4.500 pazienti e centinaia di sanitari, è il maggior datore di lavoro della città. Presidente è Mario Basile del Partito d’azione (anche direttore del carcere), membri sono Amedeo Meini (anche sindaco), Mario Giustarini e Aldo Tozzi (anche assessori comunali) e Alfredo Zoppi (anche presidente della bonifica)[13].
Arnaldo Dello Sbarba considera però l’ospedale psichiatrico una propria creatura. Per diversi anni aveva infatti presieduto la “Congregazione di carità”, ente giuridico dell’istituto, in un sodalizio sempre più stretto col geniale direttore Luigi Scabia, che aveva fatto del “Frenocomio di San Girolamo” un modello d’avanguardia della psichiatria europea[14]. Da allora Scabia era diventato l’appassionato sostenitore dell’ascesa politica di Arnaldo e Arnaldo lo strenuo difensore di Scabia dagli attacchi dei fascisti. Arnaldo considerava insomma gli amministratori nominati dal CLN come spine nel fianco. E si era messo in moto.
Il 13 novembre 1944, i partiti liberale, democristiano e demo-laburista volterrani inviano una lettera di fuoco al prefetto e al questore di Pisa. Attaccano violentemente il CLN volterrano, invocano “il ritorno alla normalità” e denunciano, nell’ordine: “arbìtri (incitamento alla rivolta, detenzione abusiva di armi, minacce ecc.), accentramento di cariche, illegalità della costituzione del CDA dell’Ospedale psichiatrico”[15].
Detto, fatto. Il 23 novembre il prefetto Vincenzo Peruzzo dispone lo scioglimento del CDA e nomina un commissario prefettizio “fino alla ricostituzione dell’ordinaria rappresentanza”[16] .
La reazione del CLN volterrano è immediata. Dietro l’azione – mette a verbale il 26 novembre – c’è un ristretto gruppo “risultato chiaramente far capo ad Arnaldo Dello Sbarba, che viene aspramente giudicato per la slealtà”. I commissariamenti – ricorda il CLN – li usavano i fascisti contro Scabia. Lo stesso sistema è ora invocato da “ben individuati gruppetti reazionari e fascistoidi” a colpi di ”anonima delazione e intrighi di corridoio”[17]. Il CLN di Volterra chiede l’immediato ritiro del commissario e un incontro urgente col Prefetto.
Ma prima che la delegazione guidata da Borgna e Meini riesca a farsi ricevere dal Prefetto, un’altra tegola “sbarbiana” cade sulla testa del CLN volterrano. Il 3 dicembre 1944 l’avvocato Arnaldo Frattini, membro comunista del CLN provinciale, porta da Pisa la notizia di “una probabile ammissione dell’avv. Arnaldo Dello Sbarba in seno al CLN provinciale” in rappresentanza del Partito demo-laburista. Per i volterrani è il colmo. In una seduta straordinaria in cui i democristiani sono “assenti perché non invitati”, vista la loro posizione sull’ospedale psichiatrico, comunisti, socialisti e azionisti redigono “una relazione sulla figura morale e politica del Dello Sbarba, stilata dai presenti in base a documentazioni potute raccogliere e firmata dal presidente Borgna“, da inviare ai CLN provinciale, regionale e nazionale, nonché agli organi periferici e centrali dei partiti della sinistra[18].
La relazione è durissima. “Il Dello Sbarba – accusa Borgna – che ama presentarsi come ex deputato antifascista, sin dalle origini del fascismo collaborò con questo, riuscendo ad esservi ammesso dopo il 1935”.
A prova della compromissione di Arnaldo, Borgna cita la sua candidatura nel 1921 come capolista del “Blocco nazionale” di Giolitti, che comprendeva anche i fascisti. “Dura ancora nella memoria del popolo di Volterra – scrive – il ricordo della triste giornata di violenze esperite dalle squadre del fascio volterrano il 7 Maggio 1921 dopo il comizio elettorale tenuto al teatro Persio Flacco dal Dello Sbarba, nel quale egli rivolse infiammate parole ai fascisti”.
Quella giornata fu un vero shock per la città. Quel giorno, scriverà un testimone oculare, l’alabastraio socialista Arnaldo Fratini, “Arnaldo Dello Sbarba scese l’ultimo gradino della sua carriera politica. Durante il corteo che si svolse per le vie della città, i fascisti al suo seguito distribuirono diversi pattoni a chi, al loro passaggio, non si toglieva il cappello. Giunti all’altezza della trattoria di Balosce, di fronte al Cinema Centrale, vi entrarono spaccando tutto e picchiando tutti coloro che vi si trovavano”[19].
Nella risposta a quello che con disprezzo chiamò “Libello Borgna”, Arnaldo minimizzerà il ruolo dei fascisti quel giorno. Ma la cronaca pubblicata dal «Corazziere», giornale monarchico e conservatore cittadino, conferma che tra gli oratori ufficiali in teatro ci fu anche “il fascista signor Davino Volterrani”, che il corteo si svolse “tra canti e inni patriottici” e che di seguito il PSI affisse un manifesto che diceva: “Chi vota per Arnaldo Dello Sbarba vota per il fascismo contro il socialismo”[20].
Questo per il passato. Sul presente, Borgna cita il commissariamento dell’ospedale psichiatrico, provocato da Dello Sbarba con “l’intensa opera disgregatrice e diffamatoria che ha svolto presso la Prefettura di Pisa dove purtroppo le sue parole sembrano ancora trovare credito”. La relazione si conclude con l’appello al CLN provinciale “di respingere la richiesta d’ammissione nel suo seno dell’avv. Arnaldo Dello Sbarba”.
Arnaldo viene avvertito della relazione Borgna prima a voce da Tito Cangini, poi per lettera da Mario Piccioli, rappresentante del PDL nel CLN pisano: “Ottenni il rinvio della discussione. È opportuno che Lei prepari una esauriente risposta”. La risposta non arriva subito. Prima arrivano, firmate dai segretari volterrani di DC, PLI e PDL, tre lettere di protesta per le “violente accuse contro l’avv. Arnaldo Dello Sbarba”. Le tre lettere sono opera di una stessa mano: tra le carte private di Arnaldo se ne trova la minuta scritta con la sua inconfondibile calligrafia[21].
Il 27 dicembre arriva finalmente l’autodifesa di Arnaldo Dello Sbarba: “È venuta l’ora di gridare basta!” scrive l’accusato. “Il libello Borgna non è che la continuazione di quella caccia all’uomo, di marca squisitamente fascista, di cui sono vittima da vent’anni”[22]. Nella sua abile autodifesa Arnaldo sfrutta il vantaggio che ha, su avversari che conoscono poco della sua vera vita, per dire mezze verità – e pure qualche non verità – senza tema di smentita.
La tessera fascista ad esempio non la nega, ma la minimizza: “La conferì Ettore Muti a tutti gli ex combattenti” e lui, che non l’aveva chiesta, l’accettò. Ma “anche con quella bella tessera le diffidenze contro di me non cessarono”. E soprattutto: “nessuno mi ha mai visto né in montura, né in adunate, né in collaborazioni dirette o indirette”[23].
Arnaldo elenca invece con precisione “le persecuzioni fasciste” che ha patito: la devastazione di casa e l’ufficio sul Lungarno a Pisa; l’assedio a sua madre a Volterra; il divieto di esercitare la professione nella città della Torre pendente; l’incendio di un suo rifugio a Pietrasanta; l’aggressione degli squadristi della “banda Buffarini” alla stazione di Pisa; l’esilio a Roma; la vigilanza di polizia subita dal 1925 al 1929; il mandato di cattura spiccato dal prefetto repubblichino Adami nell’ottobre 1943 e infine la latitanza nella campagna senese.
Tutto vero. Ma sulle cruciali elezioni politiche del 1924, che segnarono la rottura del fascismo pisano con l’ex ministro, Arnaldo è molto più reticente. Scrive che i fascisti intransigenti gli impedirono “di far parte di quella lista di minoranza che la legge elettorale consentiva per i NON ADERENTI AL FASCISMO” (il maiuscolo è suo). E qui mente.
Gli archivi documentano tutt’altra verità. Raccontano cioè i tentativi da lui fatti per oltre un anno di ottenere una candidatura non di minoranza, ma direttamente nel “Listone” di Mussolini, con l’appoggio dello stesso Duce e del suo braccio destro Cesare Rossi, che elogiava “il suo contributo di affiancatore del movimento fascista in varie sue fasi”[24]. L’adesione a una lista di minoranza Arnaldo Dello Sbarba la considerò solo per qualche ora, il giorno in cui la sua candidatura coi fascisti saltò. Tentazione fugace e subito accantonata. A sera assicurò a Mussolini il suo pubblico appello a votare comunque la lista fascista come “mio disinteressato aiuto alla forte battaglia che Tu combatti con pugno sicuro”[25].
Sugli anni dell’esilio romano di Arnaldo, il CLN e l’opinione pubblica pisana erano ancora meno informati. L’odio fascista per Dello Sbarba era infatti concentrato a Pisa. A Roma poteva invece frequentare i palazzi del potere e diventare un avvocato d’affari di successo, salvo fare attenzione a mantenersi “indifferente” verso il regime, come segnalavano nel 1927 le autorità romane di polizia che lo sorvegliavano[26].
A proposito d’affari, dalle ricerche svolte presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma sono emerse delle carte davvero sorprendenti. Nel 1926 Arnaldo Dello Sbarba entra in società addirittura con Marcello Piacentini, l’architetto di Mussolini, e Angelo Rossellini, grande impresario edile (e padre del futuro regista Roberto). I tre si uniscono nell’A.P.I.S. “Anonima Per le Industrie Stabili”, allo scopo di riedificare completamente l’area tra Piazza Barberini e Piazza S. Bernardo[27]. Per alcuni anni Arnaldo ha il suo studio di avvocato nella sede dell’A.P.I.S. in via S. Niccolò da Tolentino, in area Barberini. Piacentini – che presiede la società – si occupa di progettazione, Rossellini di costruzioni e Arnaldo di finanza, cioè di reperire i capitali necessari per realizzare le opere.
In questo Arnaldo ci sapeva fare, era versatile, efficiente, instancabile. Da ex Ministro al lavoro e alla previdenza sociale sapeva come attrarre gli investimenti dei grandi istituti di previdenza, delle banche pubbliche e para-pubbliche, delle assicurazioni sociali. Quello di Arnaldo era un ruolo chiave per Piacentini, diventato l’architetto prediletto dal Duce proprio per l’abilità con cui riusciva a portare a termine progetti smisurati.
Partiti i lavori nel 1926, Mussolini visitò il cantiere nel settembre del 1930 e – racconta Paolo Nicoloso nella sua biografia di Piacentini – ne rimase compiaciuto. Definì la nuova via Barberini “un’arteria di grande respiro”, ammirò “le linee architettoniche dei palazzi (…) e il nuovo cinematografo” che era stato da poco inaugurato e fu per l’epoca un’opera avveniristica[28].
Nel 1934 l’A.P.I.S. aveva già concluso la sua missione e Arnaldo ne era potuto uscire “con qualche cosa alla mano – scrisse al fratello Bruno – che vedrò come impiegare utilmente”[29].
Ma perfino a Pisa Arnaldo Dello Sbarba riuscì a operare nonostante l’esilio. San Giuliano Terme è un borgo termale appena fuori Pisa. Il 20 giugno del 1923, nello studio dell’avvocato Gino Sossi sul Lungarno Mediceo, venne fondata la società anonima “Regie Terme di San Giuliano” e firmato il contratto di gestione dei bagni per sessant’anni, un canone basso e l’impegno di forti investimenti. “Il perno della compagine societaria – scrive Mirella Scardozzi nella sua storia dei “Bagni di Pisa” – non era un imprenditore nel senso comune del termine, ma un personaggio politico di notevole rilievo locale e nazionale, l’avvocato Arnaldo Dello Sbarba”[30]. Come sappiamo, Sossi era cognato di Arnaldo e della società era socio anche il fratello Bruno.
Da Ministro alla previdenza, Arnaldo si era occupato intensamente di termalismo e per le “Regie Terme” il suo risiedere a Roma si rivelò vitale. Quando la crisi del 1929 farà crollare il turismo termale di lusso, sarà infatti grazie alle convenzioni con la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali che Arnaldo riuscirà a tappare i buchi nel bilancio. E quando neppure questo basterà, e le “Regie Terme”, a un passo dal fallimento, verranno accusate di inadempienza negli investimenti, sarà proprio all’Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale che Arnaldo riuscirà a vendere sia la società che gli stabilimenti – e non in una, ma in ben tre cessioni frazionate, l’ultima nel luglio 1939. Grazie a questo, scrive Mirella Scardozzi, “i 16 anni di vita della società non si rivelarono per i suoi azionisti così negativi come farebbero pensare i bilanci sempre in rosso”.
Ma torniamo al dicembre 1944 e al “libello Borgna”. Non fu la diatriba sul suo passato a far vincere Arnaldo Dello Sbarba, ma due semplici argomentazioni giuridiche della sua autodifesa. E cioè: primo, le regole istitutive dei CLN non prevedono “il diritto di sindacazione politica sulle persone delegate dai rispettivi partiti a rappresentarle”. E, secondo: il “Libello Borgna” è nullo, poiché approvato escludendo a priori una parte del CLN. Sulla questione il CLN provinciale vota infine il 29 dicembre 1944: “A maggioranza di voti si ammette l’on. Dello Sbarba in seno al CLN di Pisa”[31].
La decisione fa probabilmente parte di un unico pacchetto. Il giorno prima infatti era stato chiuso anche il conflitto sull’ospedale psichiatrico. Il prefetto Vincenzo Peruzzo era salito a Volterra e aveva negoziato col CLN un nuovo consiglio di amministrazione. Del vecchio erano rimasti in due, il presidente Mario Basile e Mario Giustarini. Tutti gli altri erano nuovi: l’ingegner Giovanni Salghetti Drioli, Emilio Vanni e un colonnello, Piero Ricci. La composizione era gradita al Prefetto, il commissario fu ritirato[32].
La questione politica invece restò aperta. Il CLN volterrano venne tartassato per mesi di domande dal CLN nazionale e dal governo Bonomi. Se la sua composizione fosse regolare, perché a Volterra PLI e PDL non fossero ammessi, quando e da chi fosse stato approvato il “Libello Borgna” e così via. I volterrani da accusatori erano diventati imputati[33].
La situazione precipita nell’aprile 1945. Il 10 il CLN di Volterra, a conclusione di una vasta raccolta di informazioni, vuole finalmente deliberare sull’epurazione degli ex fascisti. E comincia dall’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Volterra. I democristiani propongono di delegare il compito alla Cassa stessa, ma la sinistra fa muro: “non è logico che gli epurandi possano decidere sulla loro stessa epurazione!”. La lista viene approvata, contiene 14 nomi, su 6 la DC vota contro. Ci sono cognomi che contano: Ciapetti, Guidi, Lagorio, Inghirami, Ginori. C’è anche Arnaldo Dello Sbarba – quella è la sua “banca di casa”. È un azzardo.
Il giorno dopo Borgna e compagni vengono convocati d’urgenza dal Governatore alleato. Si tratta delle misure contro gli ex fascisti. La seduta è drammatica. Riferendosi ad arresti di fascisti in zona, il governatore dice che “non si può trattenere una persona verso la quale non vi siano denunce specifiche”. Borgna ribatte: “i maggiormente responsabili ed in special modo i sovvenzionatori ed i sostenitori del fascismo” hanno sempre agito nell’ombra. Coi criteri del Governatore “non potranno mai essere arrestati né colpiti“. Il Governatore non cede. Cede il CLN, riservandosi di raccogliere denunce più circonstanziate e intanto di spiegare alla popolazione “la ragione dei mancati arresti”[34].
Ma non basta. In base a due successive circolari del CLN provinciale, il CLN di Volterra prima è costretto ad accogliere il PLI, poi a fare marcia indietro sull’epurazione. Va delegata agli enti interessati: proprio quel che pochi giorni prima era stato giudicato “illogico”.
Alla fine – ed è il 24 aprile, proprio alla vigilia della Liberazione – Umberto Borgna si dimette dal CLN. Si dimettono anche Amedeo Meini, il sindaco, e Mario Basile, il presidente dell’ospedale. Formalmente perché l’ennesima circolare da Pisa vieta il cumulo delle cariche.
Ma la realtà è diversa. Umberto Borgna mette a verbale una sua emozionata dichiarazione. “Lascio il CLN con molto dolore – dice Borgna – non voglio né posso continuare la lotta sleale fatta di questioni personali, di piccole, grette ambizioni. Non sono uomo politico. Rimpiango il lungo e snervante periodo della lotta clandestina. Lo rimpiango per quello spirito di fraternità che tutti ci animava”. Ribadisce che per lui, azionista, i CLN sono “la base della futura politica italiana, la più pura espressione del popolo antifascista, del popolo italiano di domani”. Un popolo “che ha veramente sofferto e che è buono e deve essere aiutato, amato, sorretto nella dura lotta di ricostruzione materiale e morale”.
Quella di Borgna non è però una rinuncia: “Ho altre responsabilità cittadine – dichiara – alle quali debbo doverosamente portare tutto il mio massimo contributo”. Intende innanzitutto la giunta comunale, di cui è il vicesindaco. La scelta è lungimirante. Sarà infatti proprio attraverso le istituzioni cittadine che, negli anni a venire, potranno fruttificare le istanze antifasciste, con il partigiano comunista Mario Giustarini sindaco amatissimo di Volterra per ben 34 anni, dal 1946 al 1980[35].
Ma nell’aprile del 1945 nemmeno l’uscita di Borgna basta a calmare le acque attorno al CLN volterrano. Tra il maggio e il giugno 1945 Tito Cangini, presidente del tribunale di Pisa, accusa «Volterra Libera» di parlare di “magistratura reazionaria”. Cangini respinge “le ingiurie di questo fogliuccio volterrano” e annuncia querele contro “il professor Cassola” se non viene sconfessato. A luglio il CLN provinciale sconfessa Cassola e “deplora l’attacco di Volterra Libera contro la magistratura”[36].
La guerra a mezzo stampa contro «Volterra Libera» e il CLN riprende in agosto con l’uscita del «Il Porcellino», quindicinale ispirato, finanziato e in parte scritto da Arnaldo Dello Sbarba. Nelle carte private di Arnaldo si trovano lunghi manoscritti su presunte malversazioni del “trio Borgna-Meini-Salghetti”. Uno è indirizzato al prefetto Peruzzo. Non si sa se gliel’abbia spedito[37].
In parallelo l’ascesa di Arnaldo Dello Sbarba continua. Il 25 novembre 1945 viene designato a Roma nella “Commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato”, organo della “Consulta nazionale” che fa da parlamento provvisorio. Lì ritrova l’amico prefetto Adalberto Berruti, che per la commissione lavora.
Il 18 aprile 1946 Arnaldo passa da commissario a presidente regolarmente eletto della Cassa di Risparmio di Pisa. Lo rimarrà fino alla fine del 1951. Di qui alla sua morte (1958) diventerà anche presidente dell’ACI, della Croce Rossa, del Gioco del Ponte, degli Istituti riuniti di ricovero ed educazione di Pisa, della Domus Galileiana, del Credito Agrario[38].
Il 2 giugno 1946 viene proclamata la Repubblica. I CLN vengono sciolti, ma la loro esperienza si è logorata da tempo. In seguito al conflitto su epurazione e ruolo dei CLN, tra il dicembre 1944 e il giugno 1945 ha governato a Roma per sette mesi un “Bonomi ter” da cui socialisti e Partito d’azione sono rimasti polemicamente fuori. Sono gli stessi sette mesi in cui si è consumata la resa di conti tra Arnaldo Dello Sbarba e il CLN volterrano.
Siamo all’epilogo. Il 31 luglio 1946 il prefetto Adalberto Berruti lascia il Ministero degli interni. Due mesi dopo anche il prefetto Vincenzo Peruzzo lascia Pisa. Arnaldo gli dedica un pubblico saluto: “Fu il prefetto che fece concorde la nostra discordia“. Missione compiuta.
NOTE
[1] Per questo articolo sono stati consultati i seguenti archivi: Archivio della Biblioteca Guarnacci di Volterra, Fondo A. Dello Sbarba, (d’ora in poi BGV/FAdS); Archivio storico postunitario del comune di Volterra, Fascicolo CLN-Verbali delle adunanze (d’ora in poi ASCV-Postunitario); Archivio di Stato di Pisa, Fondo Comitato di Liberazione Nazionale (d’ora in poi ASPi/CLN); Archivio centrale dello Stato di Roma, Fondo Dello Sbarba Arnaldo (d’ora in poi ACS/FAdS); Ivi, Casellario Politico Centrale, b. 1695 Dello Sbarba Arnaldo, (d’ora in poi ACS/CPC); Archivi privati di famiglia (d’ora in poi AP/AdS). Ringrazio la forte squadra di amici di Volterra per l’infaticabile aiuto: Danilo Cucini, Gian Paolo Debidda e Giovanni Tamburini dell’ANPI; Silvia Trovato, archivista del comune e Elena Dello Sbarba, custode delle memorie familiari.
[2] ASPi/CLN, Verbale 31 agosto 1944.
[3] Cfr. C. Pavone, Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello stato, Torino, Bollati Boringhieri, 1995. In particolare i cap. 2 e 3. Sullo sfondo storico: C. Pavone, Una guerra civile, Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino, Bollati Borignhieri, 1991. Sulla continuità dello Stato e degli apparati militari: D. Conti, Gli uomini di Mussolini: prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Torino, Einaudi, 2017.
[4] ASPi/CLN, “È venuta l’ora di gridare basta!”, prot. 1000/2-A, 30 dicembre 1944.
[5] BGV/FAdS, Memoria di Adalberto Berruti per Arnaldo Dello Sbarba, 6 giugno 1948.
[6] BGV/FAdS, Cartolina di Adalberto Berruti, 22 agosto 1943.
[7] Cfr. L’ombra del potere. Biografie di capi di gabinetto e degli uffici legislativi, a cura di G. Tosatti, Società per gli studi di storia delle istituzioni, 2016, pp. 33-35.
[8] Per tutte le citazioni del prefetto Peruzzo cfr. Vincenzo Peruzzo, ricordi del primo prefetto di Pisa dopo la Liberazione, a cura di C. Forti, Pisa, Pacini, 2012.
[9] Cfr. C. Forti, Dopoguerra in provincia, microstorie pisane e lucchesi, 1944-1948, Milano, F. Angeli, 2007, pp. 100-112.
[10] Cfr. Cangini Tito, in Dizionario di Volterra, a cura di L. Lagorio, Pisa, Pacini, 1984, pp. 926-927.
[11] Cfr. C. Forti, Dopoguerra in provincia, microstorie pisane e lucchesi, 1944-1948, cit., pp. 72-79. Nel saggio sono riportati i seguenti dati: Il campo di Coltano passò all’amministrazione italiana il 28 agosto 1945. Ospitava 32.229 internati. Il 27 settembre 1945 cominciarono gli interrogatori, che si conclusero il 29 ottobre. Circa 30.000 internati furono subito liberati e 2.700 trattenuti, ma parecchi fuggirono o, trasferiti in un campo presso Arezzo, furono presto liberati. 313 furono prelevati dalle Questure competenti, 45 ufficiali dell’esercito furono trasferiti al Forte Boccea a Roma e 187 ufficiali di Marina al campo di Narni.
[12] Cfr. Il Tirreno, 25 maggio 1945.
[13] ASCV-Postunitario, CLN-Verbali delle adunanze, Adunanza del 14 luglio 1944, n. 7. Il “Libro dei verbali del CLN di Volterra, dal 9 luglio 1944 al 4 settembre 1945” è stato conservato da Luigi Riondino e donato all’Archivio del Comune di Volterra il 9 luglio 2024, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione della città.
[14] Cfr. V. Fiorino, Le officine della follia, Il frenocomio di Volterra, Pisa, ETS, 2011.
[15] BGV/FAdS, Lettera Dc, PLI e PDL del 13 novembre 1944.
[16] ASPi, Gabinetto del prefetto, Decreto 6973, div. 2/2, del 23 novembre 1944.
[17] ASCV-Postunitario, CLN-Verbali delle adunanze, Adunanza 26 novembre 1944, n. 17.
[18] ASPi/CLN, b. 1 f. 5, Attività e posizione politica dell’avv. Arnaldo Dello Sbarba, Memoriale del 4 dicembre 1944 del CLN volterrano al CPLN e p.c. al CTLN.
[19] AP/AdS, A. Fratini, Appunti per una storia del socialismo volterrano, esemplare originale dattiloscritto dell’autore, pp. 58-59.
[20] Cfr. «Il Corazziere», nn. 1° e 14 maggio 1921.
[21] BGV/FAdS, Lettere del 23 dicembre 1944 della Dc, del PLI e del PDL e minuta manoscritta non datata.
[22] ASPi/CLN, “È venuta l’ora di gridare basta!”, cit.
[23] In BGV/FAdS: Arnaldo Dello Sbarba torna sulla vicenda in una autobiografia in terza persona scritta nel 1948: “Venuto segretario del partito fascista Ettore Muti, il quale dichiarò che la rivoluzione fascista era finita e bisognava rientrare nella costituzionalità e nella legalità, fece appello all’associazione combattenti a collaborare con la di lui opera; molti amici della provincia di Pisa fecero premura all’onorevole Dello Sbarba, ex combattente iscritto, di esaminare se non fosse dovere civico e patriottico di non estraniarsi dall’assecondare il richiamo del Muti. Si recarono a Roma per avere un colloquio con Muti ed avutolo per due volte a distanza in una sala dell’hotel Moderno, Muti confermò le promesse dichiarando che se queste non si fossero verificate egli avrebbe lasciato la sua carica. Scongiurò i combattenti di non fare un secondo Aventino. Allora fu deciso di accogliere l’invito tanto quanto bastava per rendere possibile un’eventuale futura collaborazione per cui fu accettata la tessera. Ma rimasero nell’attesa. Questa tessera è rimasta lettera morta, l’onorevole Dello Sbarba e gli altri rimasero in disparte e in silenzio, delusi ed umiliati di essere stati così ingenui da credere non a Muti, il quale in realtà se ne andò, ma alla possibilità che il fascismo si trasformasse”.
[24] BGV/FAdS, Lettera di Cesare Rossi al senatore Ginori Conti del 9 dicembre 1923.
[25] BGV/FAdS, Lettera di Arnaldo Dello Sbarba a Benito Mussolini del 20 febbraio 1924. Sulle lotte interne al fascismo pisano e la tentata candidatura di Arnaldo Dello Sbarba nel “Listone” fascista del 1924, cfr. R. Dello Sbarba, Arnaldo Dello Sbarba: anatomia di una caduta, in «ToscanaNovecento», portale di storia contemporanea. https://www.toscananovecento.it/custom_type/arnaldo-dello-sbarba-anatomia-duna-caduta/?print=print
[26] Cfr ACS/CPC, Segnalazione del 7 luglio 1927 del Prefetto di Roma Paolo D’Ancona al Ministero dell’Interno, Direzione generale di P.S., Divisione affari generali e riservati: “Pregioimi comunicare che l’ex deputato Dello Sbarba avv. Arnaldo abitante in via Viminale 43 e con studio in via Pie’ di Marmo 18, da vari anni non risulta che esplichi alcuna attività politica e serba regolare condotta. Nei riguardi dell’attuale regime fascista dimostrasi indifferente”.
[27] Cfr. ACS, Guida Monaci, Guida commerciale, scientifica e artistica della città di Roma, aa. dal 1926 al 1946.
[28] Cfr. P. Nicoloso, Marcello Piacentini. Architettura e potere: una biografia, Udine, Gaspari, 2018, pp. 121-122.
[29] BGV/FAdS, Lettera di Arnaldo al fratello Bruno Dello Sbarba del 16 aprile 1933.
[30] Cfr. M. Scardozzi, Un paese intorno alle terme, da Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, 1742-1935, Pisa, ETS, 2014.
[31] ASPi/CLN, Verbale della seduta del 29 dicembre 1944.
[32] ASCV-Postunitario, CLN-Verbali delle adunanze, Adunanza 28 dicembre 1944, n. 20.
[33] ASPi/CLN, Corrispondenza tra CPLN, CCLN, CLN Volterra, Gabinetto governo Bonomi, Uffici centrali e periferici di PLI e PDL, tra il 1° gennaio e il 30 marzo 1945.
[34] ASCV-Postunitario, CLN-Verbali delle adunanze, Adunanza 11 aprile 1945, n. 21.
[35] ASCV-Postunitario, CLN-Verbali delle adunanze, Adunanza 24.04.45, n. 32. Su Mario Giustarini si v. M. Bacchiet, Giustarini Mario, in Dizionario biografico online delle comuniste e dei comunisti della provincia di Pisa, Biblioteca Franco Serantini, Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea. https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/16112-giustarini-mario?i=10
[36] ASPi/CLN, Corrispondenza tra CPLN e Tito Cangini dal 15 maggio 1945 al 29 luglio 1945.
[37] BGV/FAdS, diverse memorie stilate da Arnaldo Dello Sbarba tra il 1944 e il 1945, tra cui un intero “Blocco di appunti”.
[38] Cfr. E. Dello Sbarba e S. Trovato, Inventario dell’archivio di Arnaldo Dello Sbarba, «Rassegna volterrana», a. 90, 2013.