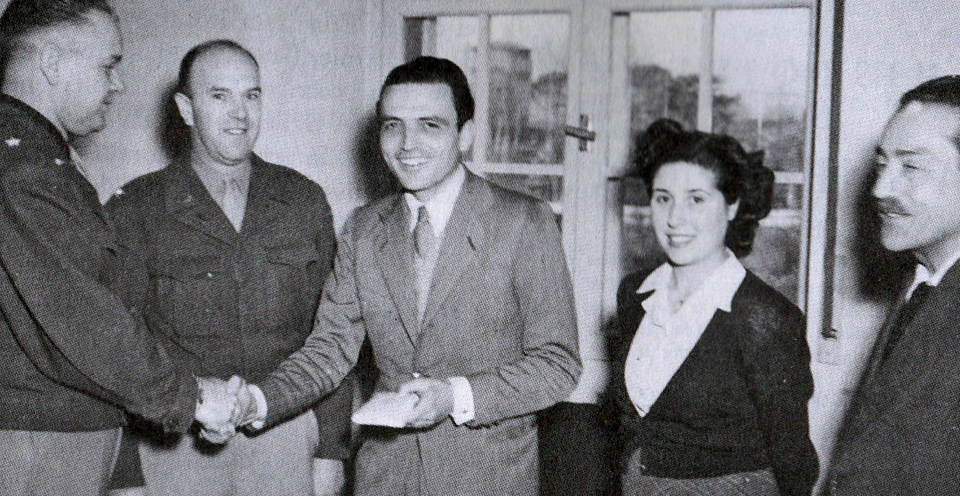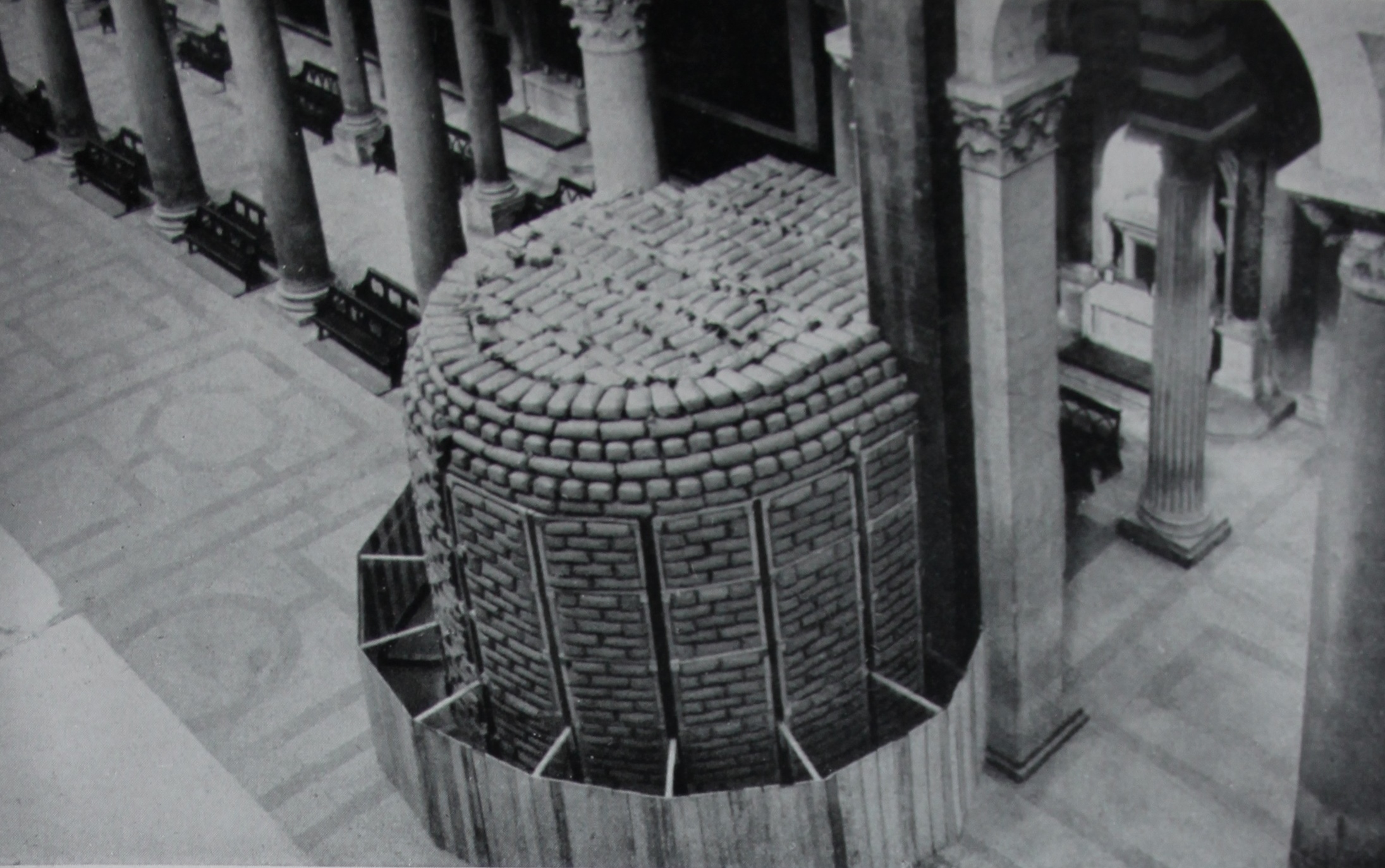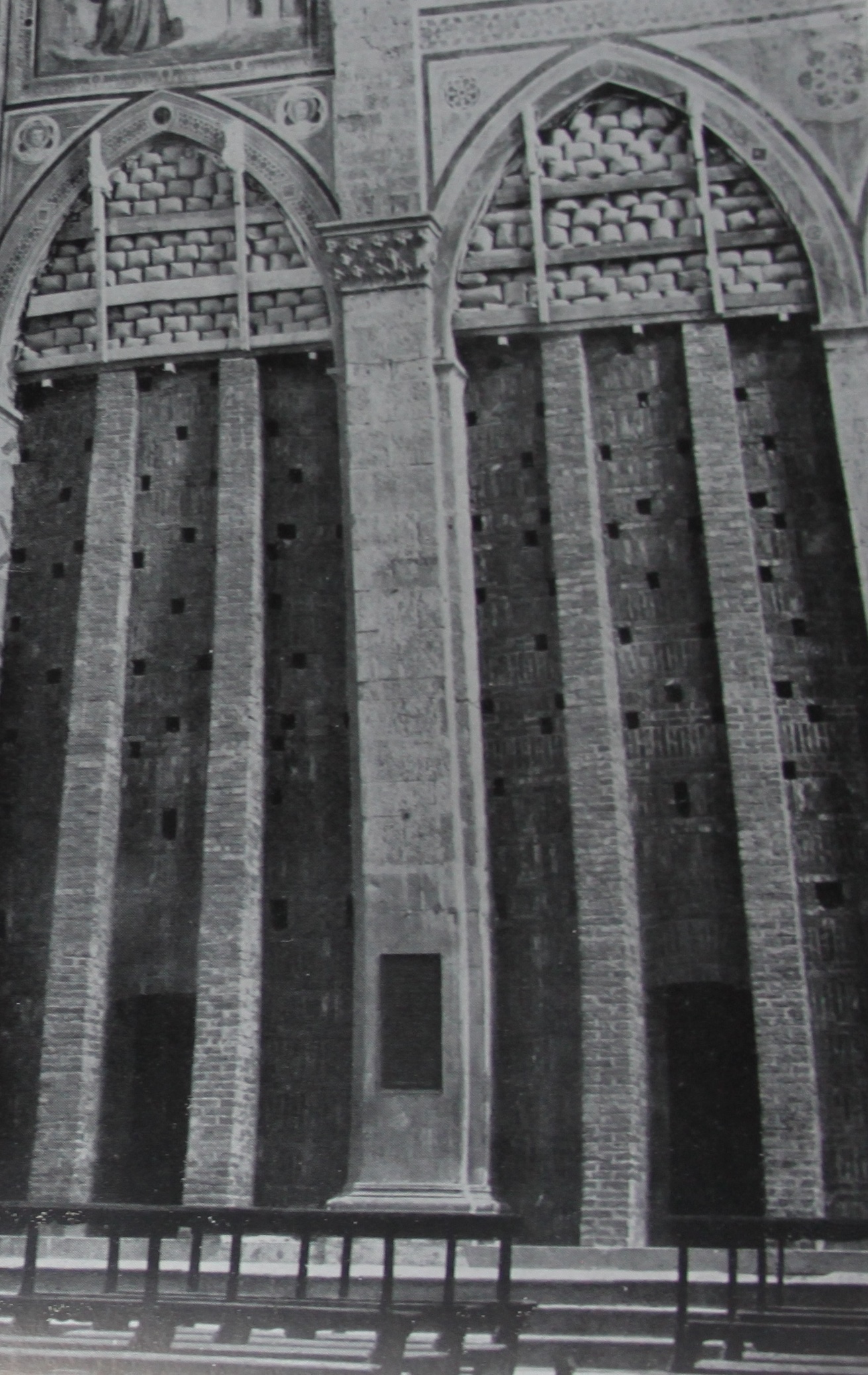Guidare la diplomazia in tempo di guerra

Il 5 novembre del 1914, a poco più di tre mesi dalla dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia, Sidney Sonnino (Pisa, 11 marzo 1847-Roma, 24 novembre 1922) prestava giuramento come nuovo Ministro degli Esteri nel secondo governo presieduto da Antonio Salandra. Il politico toscano, chiamato alla guida della politica estera italiana nel pieno della conflagrazione mondiale, vi sarebbe rimasto fino al giugno del 1919, divenendo pertanto il quarto ministro degli esteri dell’Italia liberale per durata di incarico, dopo Visconti Venosta, Tommaso Tittoni e Antonino di San Giuliano. In questi quattro anni e mezzo Sonnino svolse un ruolo centrale nell’entrata in guerra dell’Italia a fianco delle potenze dell‘Intesa e rappresentò nel 1919 assieme a Orlando gli interessi italiani alla Conferenza di Pace di Parigi.
Con Sonnino, Salandra, oltreché un amico personale e un antico alleato, aveva voluto chiamare alla guida della politica estera uno dei leader dell’Italia liberale di maggior esperienza che proprio con quella nomina coronava una lunga carriera pubblica iniziata giovanissimo nella diplomazia italiana quando, poco dopo la laurea conseguita a Pisa in giurisprudenza, aveva servito come volontario tra il 1867 e il 1871 presso le Legazioni italiane di Madrid, Vienna e Berlino.
Precoce studioso, secondo la migliore lezione di Pasquale Villari, della questione sociale e contadina nonché della rappresentanza parlamentare, Sonnino elaborò sin dalla gioventù un proprio pensiero politico che a un progetto di consolidamento delle istituzioni interne legava la necessità di condurre sul piano internazionale una politica estera che consentisse il raggiungimento di una completa sicurezza dei confini nazionali e al contempo permettesse il rilancio di un ruolo attivo dell’Italia nel contesto mediterraneo e del Vicino Oriente, anche tramite la ricerca di una politica di espansione coloniale considerata come mezzo utile al miglioramento delle condizioni dell’emigrazione italiana.
Convinto che molti di questi obiettivi si potessero conseguire sul piano diplomatico, Sonnino giudicò positivamente l’ingresso dell’Italia nel 1882 nella Triplice Alleanza con Austria-Ungheria e Germania, un blocco di potenze ritenuto in grado di assecondare gli interessi di espansione e sicurezza del governo di Roma, nonché fornire una soluzione pacifica al completamento dell’unificazione nazionale. In particolare, l’eventuale applicazione dell’articolo VII del trattato di alleanza, che prevedeva in caso di una espansione asburgica nei Balcani la concessione di ipotetici compensi territoriali all’Italia, poteva costituire, secondo Sonnino, lo strumento col quale ottenere pacificamente i territori irredenti del Trentino e della Venezia Giulia. Questa lettura pratico-strategica della alleanza basata più su un calcolo degli obiettivi esteri nazionali che su ragioni ideologiche (tanto che Sonnino la intese come «un connubio che non esclude il divorzio») assieme al principio di nazionalità guidarono tra Otto e Novecento le sue convinzioni sulla politica estera.
Chiamato nel novembre 1914 da Salandra al Ministero degli Esteri in seguito alla morte improvvisa di San Giuliano, Sonnino agì in continuità con la politica di quest’ultimo, sostituendo però un atteggiamento più dinamico all’incertezza e all’attendismo del San Giuliano. Anziché attendere dall’andamento della guerra il profilarsi di un vincitore per porvisi vicino, Sonnino, persuaso anche di una rapida vittoria austro-tedesca si convinse che, per evitare i pericoli di un isolamento internazionale del paese, fosse necessario rompere la neutralità dichiarata dal governo italiano il 2 agosto e scendere in guerra a fianco di Vienna verosimilmente entro la primavera del 1915, non prima però di aver concordato con quest’ultima, anche in cambio dell’intervento italiano, la natura delle compensazioni territoriali che in base all’art. VII sarebbero spettate all’Italia a seguito delle nuove conquiste balcaniche compiute dall’esercito asburgico.
Contrariamente a quanto spesso sostenuto, Sonnino rimase fino all’ultimo sostenitore della fedeltà alla Triplice e fu in realtà solo l’intransigenza del governo austroungarico nell’ignorare le precise richieste italiane di compensazione territoriale che spinsero il governo Salandra-Sonnino a troncare le trattative con Vienna e negoziare in segreto con le potenze dell’Intesa (Gran Bretagna, Francia e Russia) il Patto di Londra. L’accordo, firmato il 26 aprile 1915 e mantenuto segreto, fu un grande successo diplomatico di Sonnino perché dava soddisfazione agli obiettivi della politica estera italiana ricercati nei decenni precedenti. Oltre a garantire un equilibrio nel Mediterraneo centro-orientale e prevedere qualche allargamento delle colonie italiane, il patto stabiliva che in cambio dell’intervento l’Italia avrebbe così ottenuto, oltre al Trentino e al Sud Tirolo (con confine sul Brennero), il controllo della Venezia Giulia e dell’Istria (ad eccezione di Fiume), della Dalmazia settentrionale e della gran parte delle isole, di Valona e del suo retroterra.
Firmato segretamente l’accordo e denunciata la Triplice solo il 3 maggio, il 20 Sonnino presentò al Parlamento una raccolta di atti diplomatici che documentavano le fallite trattative tra Roma e Vienna e illustravano le ragioni della guerra (il cosiddetto Libro Verde). L’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria il 23 maggio 1915 mentre l’adesione all’Intesa fu resa pubblica solo il 30 novembre. Sonnino il 1° dicembre, in un discorso tenuto alla riapertura delle Camere, poté presentare le ragioni e gli obiettivi della guerra a fianco dell’Intesa. Il rapporto diplomatico con gli alleati si rilevò però subito complicato per via dell’atteggiamento sospettoso degli anglo-francesi che ritenevano l’Italia poco affidabile, imputandole di condurre una sorta di guerra separata con Vienna sulla base dei soli interessi nazionali (in effetti la dichiarazione di guerra alla Germania, richiesta all’Italia dal Patto di Londra, sarebbe giunta solo il 28 agosto 1916). Fu soprattutto Sonnino che con lento lavoro diplomatico poté ricucire in parte i rapporti, assicurare il rispetto dei patti da parte dell’Italia e divenire l‘uomo forte dell’Intesa a Roma: egli «è il solo che ha l’autorità all’interno ed inspira vera fiducia all’estero», scriveva nel 1916 sul suo diario Guglielmo Imperiali ambasciatore italiano a Londra. Tuttavia, l’andamento complessivo delle operazioni belliche sfuggito oramai a ogni previsione, il successivo intervento statunitense a fianco dell’Intesa nell’aprile del 1917 e lo scoppio della rivoluzione bolscevica in Russia, mutarono non solo la situazione politica interna ma soprattutto gli equilibri politici e diplomatici. La pubblicazione inattesa da parte della stampa sovietica dei contenuti del Patto di Londra costrinse Sonnino nel dicembre 1917 a difendere in parlamento le ragioni del segreto diplomatico e a respingere le richieste di dimissioni presentate dall’opposizione. Sul piano internazionale, negli ultimi anni del conflitto Sonnino continuò a lavorare soprattutto per creare il terreno favorevole affinché al futuro tavolo della pace potessero essere mantenuti gli accordi sanciti nel Patto di Londra.

Sonnino alla Camera nella seduta del 18 dicembre 1916 spiega le ragioni dell’inopportunità di una pace separata con Vienna (La Domenica del Corriere)
Il suo rifiuto, tra la fine del 1916 e gli inizi del 1917, di accettare le offerte di parte tedesca per fa siglare all’Italia una pace separata con Vienna era motivato proprio dal timore che con questa sarebbero andate in frantumi le acquisizioni promesse all’Italia col Patto. Tuttavia, al pari di molti altri leader europei, Sonnino non colse probabilmente fino in fondo che l’intervento statunitense in Europa e soprattutto la politica di pacificazione del Presidente Wilson avrebbero imposto una netta presa di distanza dalle logiche di potenza e dalle dinamiche della diplomazia segreta che in passato avevano retto le relazioni tra gli stati europei e che alcuni ritenevano di poter riproporre ancora dopo il 1918. Le future condizioni di pace indicate da Wilson nei celebri 14 punti smentivano queste aspettative e in particolare respingevano la legittimità delle rivendicazioni italiane riconosciute nel Patto di Londra, bollandole come imperialiste. Sonnino stesso, ricercando sempre con gli alleati un’applicazione integrale dei termini del Patto di Londra si dimostrò forse troppo intransigente, trascurando l’eventualità di adeguare la sua posizione ai nuovi equilibri internazionali mutati a seguito dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti.
Queste premesse, assieme all’allineamento franco-britannico sulle posizioni statunitensi, al termine della guerra avrebbero fortemente condizionato i lavori della Conferenza di Pace tenutasi a Parigi tra il 18 gennaio 1919 e il 21 gennaio 1920. La classe dirigente liberale italiana, nonostante avesse incassato il successo politico di Vittorio Veneto e della conseguente conquista italiana dei territori irredenti, vi si presentò delegittimata da una crisi di rappresentanza parlamentare e incalzata dall’opposizione socialista e cattolica. Sonnino, la cui presa sulla politica estera italiana era ora subordinata al protagonismo del nuovo presidente del consiglio Vittorio Emanuele Orlando, rappresentò meglio di altri il simbolo di questa fragilità nazionale. Ormai settantunenne e dopo circa quattro anni «di estrema tensione nervosa, senza un giorno di riposo», come ebbe a scrivere lui stesso, Sonnino non riuscì a far valere le sue doti diplomatiche né a sfruttare la sua profonda conoscenza delle lingue per avvantaggiare la posizione italiana: alla conferenza «Sonnino tace in tutte le lingue che sa ed Orlando parla in tutte le lingue che non sa» recitava un motto molto diffuso al tempo. Sonnino, dovette peraltro allinearsi alla impostazione diplomatica data da Orlando che anziché chiedere la semplice applicazione del Patto di Londra, come da lui suggerito, puntava anche a ottenere l’annessione di Fiume. L’opposizione statunitense alle rivendicazioni dell’Italia sulla Dalmazia (dopo che le erano stati invece riconosciuti i diritti sul Trentino e l’Istria occidentale) e la proposta di Wilson di fare di Fiume una città libera impedirono di raggiungere in sede di trattative un accordo e furono alla base nell’aprile 1919 dell’abbandono dalla conferenza della delegazione italiana e poi delle dimissioni del governo Orlando-Sonnino il 23 giugno successivo.
Lo statista toscano, da quel momento e negli anni seguenti fu spesso additato come il responsabile del fallimento della diplomazia italiana e della vittoria mutilata. Il giornale della federazione socialista fiorentina, “La Difesa”, nell’agosto 1919 lo chiamò ad esempio «l’inetto bocciato di Parigi», «unico e vero responsabile della rovina d’Italia per averla coinvolta e trascinata, contro volontà, nell’inumana carneficina». Per Giovanni Amendola, il metodo diplomatico di Sonnino tenuto a Parigi fu causa «di tutte le cecità e di tutte le rovine», mentre più tardi Togliatti vi avrebbe rintracciato «il vero responsabile del fallimento della diplomazia italiana». In realtà, se è vero che a Parigi la stella di Sonnino apparve assai opaca, va però detto che la macchina diplomatica da lui diretta nel corso della guerra si era rivelata efficiente e la sua politica estera coerente con il raggiungimento degli interessi nazionali.
Se per alcuni dei suoi detrattori la sua visione degli interessi italiani nell’Adriatico fu ritenuta troppo moderata o accondiscendente alle rivendicazioni degli altri Stati balcanici questo lo si dovette in parte al fatto che la sua politica estera non fu mai di tipo imperialista ma tenne anzi conto delle altre nazionalità oltre che della propria. La decisione pur dolorosa assunta all’inizio del 1915 assieme a Salandra di non includere tra i territori richiesti dall’Italia nel Patto di Londra la città di Fiume, fu presa anche perché si ritenne giusto che in caso di dissoluzione dell’Impero asburgico l’Ungheria o, in caso di indipendenza da questa, la Croazia potessero avere uno sbocco sul mare per le esigenze commerciali delle loro popolazioni. Più in generale, la defaillance della politica estera italiana al termine dei negoziati di Parigi, anziché addossarsi solo a Sonnino dipese più che altro dalla profondità della crisi interna alla classe dirigente liberale, dalle contraddizioni di un paese affetto da evidente arretratezza economica e sociale, nonché in sede diplomatica dall’intransigenza statunitense e dall’atteggiamento ostile di Francia e Gran Bretagna, oltreché dall’effettivo difetto negoziale della delegazione italiana. Il giudizio severo che toccò allo statista toscano fu perciò in buona parte esagerato. Guglielmo Imperiali, che pure dalla politica estera del toscano aveva spesso dissentito, scrisse sul suo diario dopo l’abbandono di Sonnino della conferenza di Pace: «non posso però non inchinarmi dinanzi all’onestà, rettitudine ed altissimo sentimento patriottico dell’uomo, di cui gli sforzi e l’importanza dei risultati comunque già ottenuti meritavano miglior sorte».
Articolo pubblicato nel novembre 2014.