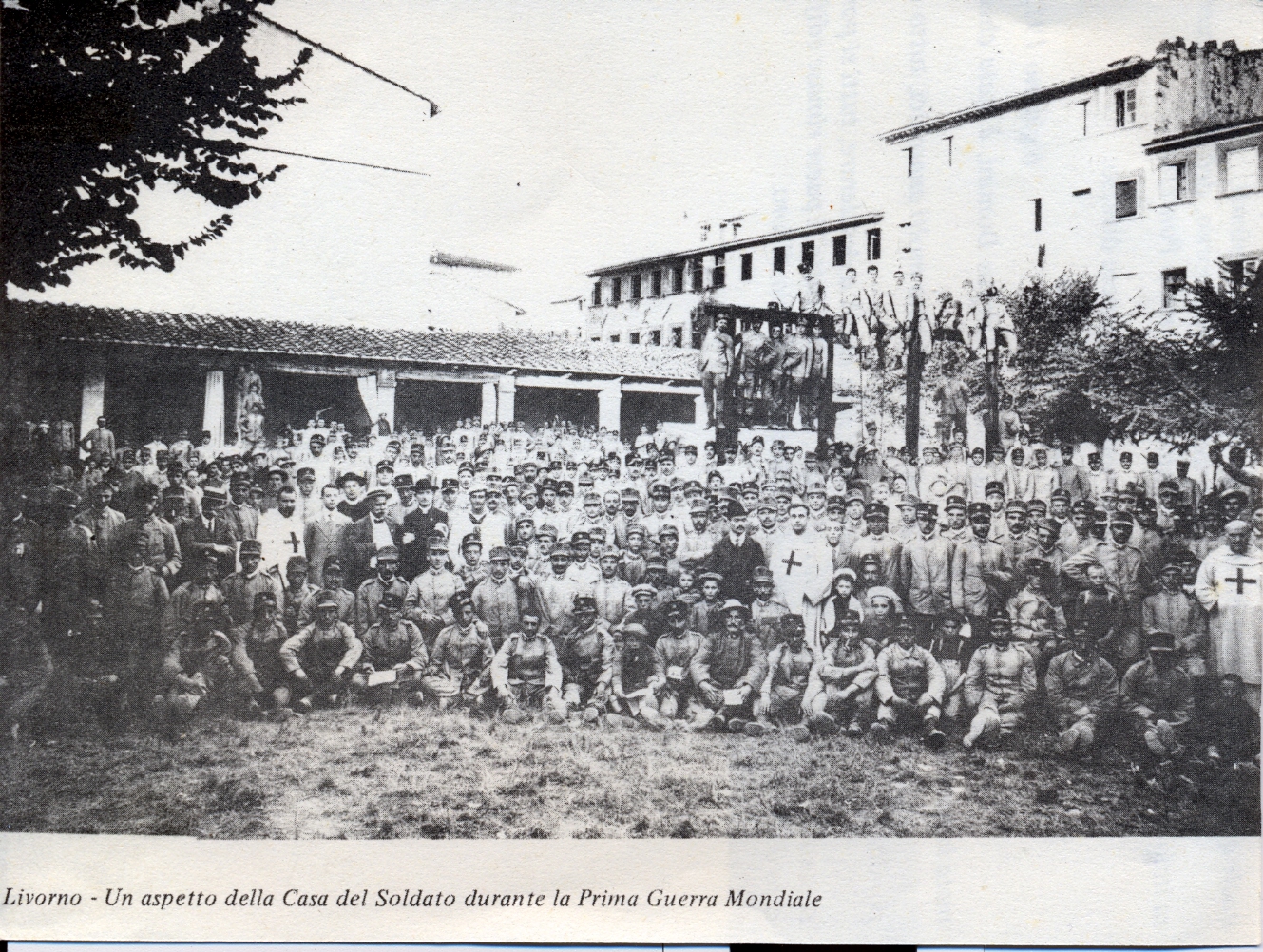Il Palio e la Liberazione di Siena

Se a Siena c’è un modo per rendere omaggio ad una persona o ad evento è dedicargli un Palio. Fra tutte le dediche, quella più ricorrente, dal 1945 fino a quest’anno, è stata la Liberazione della città dal nazifascismo, avvenuta il 3 luglio 1944 ad opera delle truppe del Corpo di spedizione francese. L’iconografia del drappellone, chiamato comunemente Palio, cioè allo stesso modo della corsa di cavalli di cui è il premio, ha subito notevoli cambiamenti nel corso dei secoli. Ha tuttavia mantenuto una costante. Poiché i Palii si svolgono in onore della Madonna di Provenzano (2 luglio) e della Madonna Assunta (16 agosto), l’immagine della Vergine non può mancare e deve essere raffigurata in alto.
Fatta questa premessa, superflua per i senesi, ma non per tutti gli altri, vediamo la rassegna dei Palii dedicati alla Liberazione.
Il 2 luglio del 1945 si tornò a far correre il Palio dopo un’ interruzione quinquennale causata dagli eventi bellici. Vinse la Lupa con Mughetto e Lorenzo Provvedi detto Renzino. Il drappellone non aveva una dedica, ma il pittore Bruno Marzi, probabilmente anche su consiglio del sindaco Carlo Ciampolini, nominato dal Cln e dalle autorità militari alleate, non poté sottrarsi ad un esplicito riferimento alla nuova stagione politica in cui cavalli e fantini tornavano a percorrere i tre giri di Piazza del Campo. Nella parte bassa del dipinto appare un drago, dalle unghie intrise di sangue e dal corpo cosparso di croci uncinate, che striscia fuori da una delle porte di Siena, trafitto a morte da una lancia con i colori francesi e statunitensi. Al di sopra, nel cielo del campanile del Duomo, sventolano le bandiere delle potenze vincitrici e il tricolore italiano. Da notare la mancanza di riferimenti al fascismo da poco abbattuto, così come alla Resistenza. Assenze che diverranno una costante nell’iconografia successiva, quasi che la dittatura, la Repubblica di Salò e la lotta partigiana contro di esse non fossero esistite.
Il 20 agosto dello stesso anno, sotto una pressione popolare che portarono alla dimissioni della giunta poi rientrate, venne organizzato un Palio straordinario per celebrare la pace. Vinse il Drago con Folco e Gioacchino Calabrò detto Rubacuori. Il pittore Dino Rofi riprese il tema delle bandiere dei vincitori a fare da sfondo e rappresentò una Nike classicheggiante che incede sicura sul globo terrestre recando in mano ramoscelli d’olivo. Come è noto ad ogni senese, mai dedica fu meno azzeccata dal punto di vista della storia paliesca. Alla fine della corsa i contradaioli del Bruco, inveleniti per non aver vinto, si impadronirono a forza di cazzotti del drappellone e lo fecero a pezzi. Poi, per riparazione, ne fecero dipingere una copia a loro spese, che finalmente venne consegnata al Drago.
Il 2 luglio del 1954 la realizzazione del drappellone fu affidata ad Enea Marroni. Vinse l’Onda con Gaudenzia e Giorgio Terzi detto Vittorino. Il pittore offrì una rappresentazione della Liberazione che qualcuno definì disneyana per la sua gioiosità un po’ fumettistica. Un sorridente vessillifero con la Balzana, stemma della città, si affaccia fra i merli del Palazzo Pubblico gettando di sotto la bandiera con la croce uncinata. In secondo piano il solito motivo delle bandiere delle potenze vincitrici, dispiegate dall’allegoria della Libertà che vola fra il Duomo, la basilica di S. Domenico e la Torre del Magia.
Il 2 luglio del 1964 il Palio della Liberazione lo vinse il Drago con Arianna e Giuseppe Vincenzio detto Peppinello. La realizzazione era stata affidata ad un tandem di artisti, Plinio Tammaro ed Ezio Pallai, i quali, forse memori delle critiche ricevute dal drappellone di dieci anni prima, scelsero un’interpretazione drammatica dell’evento. A simboleggiare il sangue e la sofferenza che aveva richiesto, una figura umana vista di spalle, collocata di fronte ad una porta cittadina e ad una barricata, alza le braccia verso l’immagine della Madonna, spezzando così la fitta rete metallica che la imprigiona.
Il 2 luglio del 1974, il pittore del drappellone, Enzo Bianciardi, decise di raffigurare alcuni momenti del Palio, dal corteo storico, alla corsa, all’esultanza dei contradaioli vittoriosi. Proprio quest’esultanza trascolora, in secondo piano, nella gioia dei senesi liberati dagli Alleati, come si comprende dalla data 1944 scritta su di loro. A vincere fu il Valdimontone con Pancho e Ettore Alessandri detto Bazzino.
Nel 1984 non ci fu dedica, probabilmente sotto l’influenza della cultura politica del Psi craxiano che guardava con un certo fastidio alle celebrazioni resistenziali, considerate vuote, ripetitive, lontane dallo spirito di innovazione politica e costituzionale di cui il partito si faceva interprete, e comunque troppo ad appannaggio degli alleati-concorrenti del Pci nel governo della città.
La dedica alla Liberazione tornò il 2 luglio 1994 nel palio vinto dalla Pantera con Uberto e con Massimo Coghe detto Massimino. Il pittore Leo Lionni scelse di nuovo, come tema centrale, la folla festante per la vittoria, assiepata intorno al cavallo vittorioso. La folla si confonde, sullo sfondo, con un’altra che manifesta gioiosamente per la fine della guerra, fra bandiere francesi e uno striscione rosso recante la data 1944.
Nel drappellone del 2 luglio del 2004, vinto dalla Giraffa con Donosu Tou (scosso) e Alberto Ricceri detto Salasso, il pittore Emanuele Luzzati realizzò invece una grande costruzione fantastica , una sorta di totem di animali tratti dagli stemmi delle Contrade e che culmina con l’immagine della Madonna circondata da teste di cavallo. In questo sogno di figure che rimandano al mondo fantastico dell’infanzia, l’unico riferimento alla Liberazione è affidato ad una scritta sull’aureola della Vergine.
Ed infine il Palio del 2 luglio 2014, vinto da Drago con Oppio e con Alberto Ricceri detto Salasso. La pittrice Rosalba Parrini ha rappresentato la Torre del Mangia, inserita da un lato fra teste di cavallo, colte nella concitazione dell’attesa fra i canapi, e dall’altro lato da un lungo nastro rosso che sostiene l’immagine della Madonna. Vicino alla Vergine una colomba, simbolo della riconquistata libertà, vola via da una gabbietta aperta. Il nastro rosso nasce in basso, da una Piazza del Campo in parte coperta dalla mappa della provincia di Siena. Sulla mappa, anch’essa di colore rosso, campeggiano alcune stelle gialle che indicano le zone in cui combatterono le formazioni partigiane. Dopo settanta anni, è il primo riferimento esplicito alla Resistenza e al suo ruolo nella Liberazione che si può leggere in un drappellone.
Articolo pubblicato nel giugno 2015.