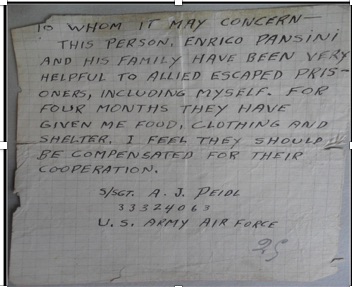Con questa intervista a Giuseppe Matulli, Presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze, si apre su Toscana Novecento la nuova rubrica dedicata alla Storia e alla Memoria della “caduta del Muro” (https://www.toscananovecento.it/custom_type/una-nuova-rubrica-di-toscananovecento/). Un percorso di approfondimento e riflessione pensato in occasione del trentesimo anniversario del crollo del Muro di Berlino che proseguirà nei prossimi mesi con la pubblicazione di altre interviste a personalità politiche, sindacali, culturali toscane che di quell’evento furono testimoni e, nei loro contesti di riferimento, a loro modo protagonisti.
[Avvertenza: nel trascrivere l’intervista si è cercato di mantenere il più possibile inalterato nei suoi aspetti formali ed espressivi il discorso parlato. Ove necessario, a scopo di chiarificazione si sono inseriti fra parentesi quadre brevi indicazioni e aggiunte al testo, rinviando invece ulteriori interventi di commento o spiegazione nelle note a piè di pagina. L’intervista è stata registrata il giorno 26 novembre 2019 presso l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze]
D. Presidente Matulli, può dirci intanto brevemente, lei che ruolo aveva nel 1989? Quali attività professionali e politiche svolgeva o aveva svolto sino ad allora?
R. Io mi sono occupato di politica fin da giovanissimo, militando nelle file della Democrazia Cristiana. Ero già stato vicesindaco del mio comune, Marradi, e consigliere regionale, eletto nel 1970 nella prima legislatura regionale. Fui poi eletto in Parlamento, nel 1987, dove sono rimasto fino al 1994. Dunque, nel 1989 ero parlamentare della DC[1].

Giuseppe Matulli al tempo della sua deputazione parlamentare per la DC nella X e XI Legislatura (fonte:Wikipedia)
D. Presidente, come ha vissuto gli eventi che hanno portato alla caduta del Muro, il 9 novembre 1989? Aveva la percezione che qualcosa di quella portata potesse accadere? O invece è stato qualcosa di inatteso? Che emozioni e riflessioni le ha suscitato quell’evento? E inoltre, che tipo di impatto quei fatti ebbero sul piano politico, rispetto al suo ruolo e al partito cui apparteneva, ma anche nel suo contesto territoriale di riferimento?
R. La caduta del muro…quell’evento in realtà ci prese di sorpresa. Cioè, si capiva benissimo in quel periodo che la situazione si andava trasformando…sotto gli effetti della Glasnost’ e della Perestrojka avviate da Michail Gorbačëv[2]…ma il tipo di evento, per la sua portata e significato, lasciò scioccati tutti…c’è un episodio a tal riguardo particolarmente rivelatorio, che mi ricordo…quando De Mita era Presidente del Consiglio e fece un viaggio in Russia[3] prima della caduta del muro, si ebbero alcuni cenni di tensione con il nostro ambasciatore a Mosca, Sergio Romano, perché – almeno così pare – questi non ravvisava concretamente il segno di una radicale trasformazione in corso…riteneva che si trattasse [in riferimento alle politiche di ristrutturazione di Gorbačëv] prevalentemente di propaganda, senza nulla di sostanziale sotto…e quando De Mita gli chiese da cosa traeva queste conclusioni gli rispose che era la storia della Russia che gli faceva capire queste cose qui…evidentemente non aveva capito granché…le cose poi avrebbero rivelato tutt’altro…ma ciò è significativo del fatto che allora c’era questo processo difficile da decifrare…quali sarebbero state le conseguenze…
…certo qualcosa di nuovo c’era rispetto…non dico a Brežnev, ma anche rispetto ad Andropov o al suo successore[4]…ma non si riusciva a capire come si sarebbe risolto…quindi, la caduta del muro fu una sorpresa…che fu una sorpresa allora poi lo si vede anche nelle ricostruzioni del tempo…si pensi alla famosa domanda che il giornalista dell’Ansa rivolse alle autorità di Berlino est: “se è possibile [attraversare la frontiera], ma allora da quando è possibile?”…la risposta data dalle autorità fu addirittura sorprendente: “ci risulterebbe fin da questo momento”[5]…fu lì che esplose tutto, di fronte alle autorità tedesche dell’Est che praticamente dichiaravano il muro non più esistente, comunque non più una frontiera…
Ma come la vivemmo noi, in Italia…come un fatto che, in parte, era la conseguenza logica di quello che stava avvenendo con la presidenza di Gorbačëv…ma era una conseguenza logica difficile da prevedere, perché se era logico il movimento che veniva fuori…era difficile prevedere che le cose andassero così…erano movimenti, come dire, misteriosi, in un mondo altrettanto misterioso in cui si era visto di tutto…si era visto la Primavera di Praga, poi si era visto l’invasione…eran tutti colpi di scena che non consentivano, o almeno a noi, non consentivano di fare una valutazione…e quindi…si rimase così…sicuramente però fu un fatto enorme.

12 novembre 1989. Achille Occhetto, segretario generale del PCI, intervenendo al rione Bolognina annuncia la “svolta” del partito che porterà poi nel febbraio 1991 al suo scioglimento (fonte: Wikipedia)
Naturalmente, cosa significava qui da noi, a livello locale, la caduta del muro…a livello locale, allora, il rapporto fra parlamentare e territorio era molto stretto, era difficilissimo passare un fine settimana senza avere un paio di incontri…ed era molto interessante andare a riflettere con la gente di questi avvenimenti, con tutte le incertezze…era sicuramente un fatto molto importante, talmente importante che poi qualche giorno dopo arrivò la Bolognina[6]….e ricordo che in Parlamento, una volta, mentre partecipavo ai lavori di una commissione, mentre si stava organizzando il calendario, dissi rivolgendomi a un collega: “voi del gruppo comunista…”. “Ma come” [mi sentii rispondere] “ma ci chiami ancora comunisti?!”…ma erano passati appena pochi giorni [dalla Bolognina]!!…[ilarità]…ecco c’era questa sensazione stranissima, ma non era una sensazione, che so io, che avesse dei connotati precisi…era una sensazione che tutto era cambiato, ma come fosse cambiato era assolutamente tutto da vedere…naturalmente, in periferia e in questi incontri, appunto…era molto interessante seguire i dibattiti, non solo per quanto mi riguarda nelle sezioni locali della DC, ma io ricordo di aver dibattuto molto con il segretario [regionale toscano del Partito Comunista Italiano], anche lui deputato, [Giulio] Quercini[7]…e gli dissi “d’accordo avete cambiato nome, ma avete aspettato che crollasse l’Unione Sovietica, o almeno che crollasse il muro”…sì, è vero…c’era questa sensazione di grande cambiamento…
Le conseguenze erano sicuramente rilevanti…io ricordo, come una mia impressione…non so se in occasione di una qualche ricorrenza della caduta del muro o di lì a poco nei primi anni Novanta…a me fece in qualche modo sorridere che la DC tirò fuori in quella particolare occasione un manifesto, facendo riferimento alla battaglia politica del 1948, un manifesto titolato “18 aprile 1948 dalla parte giusta” che era il modo più stupido di fare una cosa di questo genere[8]…che nel 1948 tu fossi stato dalla parte giusta lo dimostra ancora il fatto che ai primi anni Novanta eri ancora lì…ma non è che nei primi anni Novanta puoi avere vantaggio da una scelta fatta cinquant’anni prima…dà la sensazione di gente che pensava a una continuità che non ci poteva più essere…ma ecco, a parte questo, la percezione che non poteva più esserci la continuità, nel 1989, c’era…al punto tale che io qualche anno dopo partecipai a un seminario che fece a Berlino la Fondazione Adenauer sul processo di unificazione tedesca… qui siamo già successivamente al 1989, quando prese corpo il processo di unificazione tedesca….ma anche la partecipazione a questo seminario mi fece toccare con mano cose imprevedibili…
mi ricordo, a parte l’interesse di andare a vedere cosa accadeva là……ci portarono a vedere le vecchie zone della Germania dell’Est, Berlino Est…ma la cosa che mi fece più impressione, e che credo sia un fatto piuttosto significativo, è che…intanto la sensazione che si dice anche adesso, ma che non poteva essere che così…è stata un’unificazione o è stata un’annessione? Non poteva che essere un’annessione, perché la forza di quell’altra parte era crollata e quindi era inevitabile che succedesse questo…ma, tipico dei tedeschi – [perché] noi non saremmo mai riusciti a fare una cosa di questo genere – noi andammo a vedere l’esercito…l’unificazione dell’esercito era emblematica del sistema…tutti i corpi avevano il doppio comando…dall’inizio fu fatto così…un battaglione, una divisione eccetera era governato non da uno ma da due generali, uno di qua e uno di là [uno della Germania Ovest e uno della Germania Est]…due colonnelli…era tutto doppio, io rimasi allibito…è proprio la razionalità tedesca, per un certo periodo…non si fa la rivoluzione ma si fa l’unione, così si mettono tutti e due…vanno avanti alcuni mesi, dopodiché quelli della Germania dell’Est, ovviamente, vengono mandati in pensione, non è che vengono degradati o puniti…ecco…il fatto di vedere queste cose, in cui si vedevano due colonnelli che parlavano dell’unificazione delle forze armate era un fatto…che faceva un certo effetto.
Io per come la ricordo ora, almeno, fu proprio la sensazione di un enorme cambiamento, di questa vicenda incredibile dell’unificazione tedesca…anche un certo entusiasmo, il fatto che lo si considerava un fatto molto positivo…era la fine della guerra…la vera fine del dopoguerra…peraltro metteva in luce…la famosa battuta di Andreotti “ho tanta simpatia per la Germania che ne preferisco vedere due”[9]…che è una battuta…ma questo è un discorso che faccio ora naturalmente, e che non facevo allora…ma è una battuta significativa…a me viene in mente [per contrasto] Alcide De Gasperi…parlo di lui perché, per l’appunto, ho avuto recentemente la possibilità di studiarne aspetti di questo tipo[10]…quando De Gasperi è Presidente del Consiglio in Italia nel 1945…naturalmente il paese allora era del tutto isolato…lui approfitta immediatamente del fatto che i francesi, i quali erano e si consideravano – per certi aspetti anche meritoriamente nonostante il fatto che [nel 1940] fossero stati spazzati via immediatamente dai tedeschi – loro si consideravano gli unici vincitori continentali…e cosa succede, quando gli americani si organizzano con la cortina di ferro, si organizzano nel punto che loro ritenevano più delicato, cioè la barriera tedesca, e quindi…allora i francesi avevano tutto l’interesse per dire…guardate che la cortina di ferro arriva fino all’Italia…e quindi avere un fronte meridionale che fosse un po’ più importante…dunque dicevo, agevolato anche dal fatto che De Gasperi era persona stimata, peraltro era molto amico di Bidault[11] sul piano personale, e allora fecero subito…perché il primo uomo di stato che venne in Italia nel 1948 fu Bidault, il primo accordo internazionale che fece l’Italia fu l’unione doganale con la Francia, che non era cosa banale per rimettersi in moto…però…De Gasperi aveva anche questa caratteristica, un po’ perché era realista e sapeva che l’Italia non poteva andare a dettar legge in Europa…e quindi quando i francesi lo cercavano non gli pareva il vero…ma quando però i francesi gli dicono “si può fare tutto quel che si vuole [dell’Europa] ma i tedeschi vanno tenuti fuori”…e lui [De Gasperi] ha il coraggio di dire fin dall’inizio “finché i tedeschi non avranno riacquistato la sovranità piena il dopoguerra non sarà finito”…e il dopoguerra finiva di fatto, appunto, con l’unificazione tedesca…come dicevo prima, il dopoguerra finiva con il crollo del muro…e da lì in poi infatti cambia tutta la politica…

Il diario di Giuseppe Matulli dei suoi due viaggi compiuti a Praga nel marzo 1989 e nel gennaio 1990, prima e dopo la caduta del Muro di Berlino.
…quanto ci fosse la consapevolezza allora di questo cambio di paradigma, io dubito molto…devo dire a livello personale…dopo che il Partito Comunista Italiano era diventato PDS…[anche] la DC si trasformò…ritornò ad assumere il nome di Partito Popolare…ecco, quella era una finzione, perché le forze politiche rimanevano le stesse, ma si sentivano talmente inadeguate al loro tempo che cambiavano nome, però era una presa in giro…di se stessi, della storia, dell’opinione pubblica…perché rimanevano sempre quelli…io non partecipai, nonostante allora fossi sottosegretario alla pubblica istruzione, quando durante questo periodo ci fu la formazione del Partito Popolare Italiano, perché la cosa non mi convinceva per due motivi…il primo perché, nonostante il processo fosse guidato da un personaggio che godeva di stima universale quale Martinazzoli[12], il fatto di scegliere il 18 gennaio [1994] come data di fondazione, la stessa data in cui nel 1919 era stato fondato il Partito Popolare, era una cosa ridicola…il fatto poi che il partito era nato nel 1919 dall’appello agli “uomini liberi e forti” di Sturzo[13]….Martinazzoli aveva fatto un appello simile….cioè era uno scimmiottamento di una cosa avvenuta settant’anni prima che aveva del ridicolo, non aveva il senso della storia…naturalmente guardavano al passato…non aveva senso…e questo valeva anche per le trasformazioni del PCI…nelle sue varie metamorfosi…PDS, DS ecc. ecc…sia nell’uno che nell’altro caso, tutto fu fatto sulla base della caduta delle ragioni di contrapposizione fra due formazioni politiche che avevano cambiato nome…fu un processo tutto rivolto a guardare al passato, nel senso però di come rimediare al passato, senza però avere il coraggio di guardare al futuro…c’era quindi sempre questa sensazione che tutto era cambiato, ma che si faceva fatica a capire il cambiamento…

La delegazione italiana a Praga è ricevuta dal dissidente ceco Jiří Hájek (al centro). Matulli è il primo sulla sinistra (fonte: G. Matulli, Praga prima e dopo…p.8)
Fu più o meno in contemporanea a questo processo che feci l’esperienza di un viaggio oltrecortina, a Praga[14]… l’idea del viaggio fu di Agrusti[15] di approfittare della vacanza del Parlamento per il congresso del PCI[16], siamo nel marzo del 1989, per andare a Praga al processo di appello al drammaturgo Havel[17] e prendere contatto con gli esponenti del movimento di “Charta 77”[18]. Jiří Pelikán che era in Italia[19] e Gilberto Bonalumi[20], un nostro amico ci davano una mano molto preziosa nella preparazione. Andiamo là e…mi ricordo cosa ci disse Hájek[21] che ci ricevette a Praga…ancora non era crollato il muro di Berlino ma era successo quello che era successo anche in tutti gli altri paesi del blocco sovietico…e Hájek ci disse; “certo che avverrà anche qui…[Matulli legge un passo del suo diario]…”sui marciapiedi della via lungo la Moldava dove abitava Havel, Hájek ci dice di non essere pessimista, ma, aggiunge: nei tempi della storia non in quelli della cronaca”…e questo in risposta alle nostre domande che gli chiedevamo cosa stesse succedendo….era significativo…dopo quando lo ritrovammo per il nostro secondo viaggio a Praga [vedi nota a piè di pagina numero 14] e gli ricordammo “ma lei ci aveva detto così…” [alludendo alla previsione rivelatasi sbagliata di Hájek]…risultò chiaro che era perché nessuno, neppure Hájek poteva immaginare che lo Stato fosse praticamente un castello di carta e che bastasse dire “si vorrebbe” perché crollasse…quindi…io ho vissuto questa esperienza…
…tutte queste novità, sì, ma si viveva in un’atmosfera talmente diversa che non si riusciva a dire che cosa sarebbe successo…c’era questa grande sorpresa e questa grande difficoltà che ancora oggi stiamo pagando…della incapacità di capire cos’era successo…forse oggi si ha la sensazione che buona parte…anzi…addirittura…noi lo capimmo solo quando si stava per andar via da Praga, per tornare in Italia… persino Jiří Pelikán e il nostro ambasciatore a Praga [Giovanni Castellani Pastoris], che pure tenevano rapporti con Dubček[22] e con Hájek, avevano cioè rapporti col movimento di dissenso al regime…nemmeno loro lo capivano, solo alla fine…cioè che i dissenzienti, che noi nel nostro viaggio a Praga andavamo a trovare nascosti nelle loro case, facendo finta di niente e non dicendo nulla a nessuno [per timore del regime]…e invece noi ci dimostrammo fuori dal mondo, dei “deficienti”…perché loro avrebbero voluto che noi…tre parlamentari italiani, certo non chissà quali autorità, ma comunque…loro avrebbero voluto che noi che si arrivava nella Praga di allora (prima cioè della caduta del muro) avessimo fatto una conferenza stampa con loro…perché questo significava dare forza a loro, far vedere che non erano dimenticati…e invece noi…non avevamo capito assolutamente niente di quello che succedeva là…è una riflessione che ho fatto dopo naturalmente[23]. Al punto tale che poi, al ritorno in Italia, qualcuno che si occupava di politica estera ci aveva detto che questi dissidenti erano velleitari, tanto che si ventilava la possibilità di accordi col regime di Husák, perché questi dissidenti erano dei velleitari…li chiamavano poi infatti “i poeti”…dopodiché, dopo tornati in Italia, i “poeti” invece avevano fatto la rivoluzione e avevano vinto…in questa rivoluzione….che però loro non volevano, giustamente, che si chiamasse “di velluto”…lo sapevano loro che cosa essa aveva significato…sacrifici…in tal senso ci sono anche molti aneddoti che ci raccontarono alcuni intellettuali…ci sono episodi anche carini, simpatici per così dire…ce ne è uno in particolare favoloso…[Matulli si prodiga a ritrovare l’esempio che vuol raccontare nelle pagine del suo diario del viaggio]…c’erano intellettuali che venivano posti [dal regime] a fare lavori non intellettuali perché sennò potevano essere pericolosi…e sicché, c’è il racconto…ecco…[Matulli cerca di ritrovare nel proprio diario il punto in cui si rievocano i casi dei due dissidenti Voclav Benda e Martin Paulosh, entrambi laureati in scienze e filosofia, ma costretti dal regime comunista cecoslovacco a lavorare come fuochisti di una caldaia, non trovandolo cerca di rievocare a mente le parole di Paulosh]: “…per mandare avanti una caldaia eravamo in tre ed avevamo cinque lauree”[24]…è bellissima questa…

23 marzo 1989: Alexander Dubček (al centro) incontra la delegazione italiana. Matulli è alla sinistra di Dubček mentre alla destra vi sono Agrusti e Castagnetti (fonte: G. Matulli, Praga prima e dopo…p.31)
D. Presidente Matulli, so che lei ha fatto altri viaggi oltrecortina, in Polonia se non erro. Che ricordo ne ha, anche rispetto al ruolo che ebbe in quel contesto il cattolicesimo rispetto ai movimenti dissidenti?
R. Questo è un discorso a mio avviso molto difficile…perché, dunque io sono stato due volte in Polonia, la prima volta mi pare nel 1966 o 1967, poi dopo ci sono tornato qualche anno dopo…e in Polonia, intanto c’è un dato pacifico…la Polonia era un paese cattolico per un fatto nazionale…la religione era più importante della lingua, di tutto, perché si distingueva dagli ortodossi russi e dai protestanti tedeschi…un polacco non poteva che essere cattolico…questo dato identitario ha un’importanza enorme nella gestione del mondo comunista, perché il partito comunista anche nel periodo del potere stalinista non poteva fare a meno di tenere rapporti di un certo tipo con la Chiesa. La cosa singolare è che nella società polacca, e forse non solo nella società polacca, ma almeno lì il dato era evidente, c’erano divisioni…tre gruppi almeno di cattolici polacchi…io ne ricordo almeno due di posizioni più radicali…un gruppo che era praticamente collaborazionista col partito comunista e l’altro, che si chiamava Znac, “Il segno” in polacco…questo gruppo, associazione, pubblicava una rivista dal titolo Tygodnika Powszechnego, in italiano “Settimanale Universale” con sede a Cracovia…a Cracovia io incontrai il direttore Jerzy Turowicz[25] un intellettuale non da ridere, il quale, pur non avendo mai studiato l’italiano ma avendo studiato il francese e lo spagnolo parlava correttamente anche l’italiano…Turowicz, ci diceva che…la censura allora non scherzava…Turowicz…ecco purtroppo questa è una cosa che non si può più accertare…ma Turowicz era molto amico di Papa Wojtyla [Giovanni Paolo II] che allora era arcivescovo di Cracovia…ma Turowicz era un uomo di una laicità straordinaria, tanto è vero che durante il Concilio [Concilio Vaticano II, 1962-65] lui venne a Roma e io lo portai a Firenze, dove fece una conferenza…poi andò a parlare con La Pira [Giorgio La Pira] e quando lo riportai a Roma in macchina lui mi parlò dell’integralismo di La Pira, in termini…cioè, con molto rispetto perché La Pira è La Pira…ma La Pira aveva una visione che era più profetica che politica e quindi…poi La Pira lo dice addirittura nell’intervento alla Costituente, che lo Stato laico non ha nessun senso…e lui invece [Turowicz] era profondamente laico e quindi da questo punto di vista era abbastanza diverso anche da Wojtyla…

Giiovanni Paolo II durante il suo primo viaggio in Polonia nel 1979 (foto di Barbara Bartkowiak, via Wikipedia Commons – CC)
…io non lo so, l’ho sempre sentito dire…tutti celebrano il peso determinante del papato di Wojtyla [nella caduta del comunismo]…dunque, però io, lo dico molto sinceramente, confesso di non averlo capito questo tipo di meccanismo…certo capisco benissimo che uno va…poi va in Polonia…in Polonia succede quel che succede[26]…ma Solidarnoś[27] succede per effetto del Papa oppure succede per effetto della Storia che crea questo…questa specie di bolla per cui si può essere al massimo cattolici e comunisti, ma non si può essere comunisti…?…cioè…la posizione del comunista anticattolico [in Polonia] è una minoranza estrema, insomma…per cui non lo so…io vedo più il crollo della capacità di [tenuta dell’Unione Sovietica]…
…perché l’Unione Sovietica secondo me…c’è una continuità storica impressionante nella storia della Russia…recentemente ho letto uno studio sui Gulag…i Gulag non sono niente di nuovo, cioè sono quelli che c’erano ai tempi dello Zar…la politica estera, al di là di tutte le affermazioni della Russia come stato guida del comunismo internazionale eccetera…ma anche nella diatriba interna al comunismo sovietico tra Stalin e Trockij… Trockij voleva predicare il comunismo in tutti i paesi del mondo e Stalin fa la politica di potenza, fin da quel momento, e la fa…e tutti gli avvenimenti gli consentono di fare esattamente quello che avrebbe fatto lo Zar…ed è esattamente quello che sta facendo ora Putin…cioè c’è una continuità impressionante…ed è in questa continuità che fallisce…cioè fallisce…ha fatto anche troppo devo dire [Stalin]…ha fatto anche troppo a reggere fin quanto ha retto…però alla fine, gli si è disgregato in mano tutto quanto….quindi in conclusione io credo che sia molto più la inconsistenza delle politiche sovietiche [la ragione del crollo del muro]…anche perché, la Russia è un paese ricco e il comunismo era riuscito a impoverirlo…
…ma forse anche questo è un elemento di continuità…un paese ricco, lo Zar lo gestiva con una mano di ferro da far paura, violentissima…tutta la gestione precedente della storia russa è violentissima…e quindi, cosa faceva [Stalin]…faceva quello che avevano fatto gli altri prima di lui…quel che facevano prima, lui [Stalin] lo faceva in nome del popolo invece che in nome della nazione, dello Stato ecc.…dopodiché, vedere in questo quadro un paese [la Polonia] che emerge all’attenzione mondiale, perché, prima il Papa…e questo Papa che ha anche un suo successo…certo, che si tratta di un fatto psicologicamente, simbolicamente enorme…ma insomma, quando va in Polonia…è un fatto che sicuramente contribuisce, ma contribuisce in una situazione che era già pregiudicata…ma comunque, tornando a Turowicz, questo intellettuale molto avanzato…lui diceva molto chiaramente, il cattolicesimo polacco è stato rinforzato dal comunismo…ma comunque il cattolicesimo polacco è anzitutto un fatto identitario nazionale…lo si vede anche oggi, come si è saldato di nuovo al nazionalismo in quel paese…ma io credo che le ragioni del crollo [del comunismo] siano assai più complesse di quelle legate a questo solo aspetto religioso…
[…]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[1] Giuseppe Matulli (Marradi, 5 dicembre 1938), laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Firenze, ha svolto per lunghi anni attività amministrativa e politica, rivestendo importanti incarichi sia a livello locale che nazionale. Assessore e vicesindaco del proprio comune di nascita (Marradi) e Presidente della Comunità Montana dell’Alto Mugello, è stato consigliere regionale della Toscana dal 1970 sino al 1987. Sindaco di Marradi dal 1985 al 2002 è stato anche vicesindaco di Firenze dal 2002 al 2009. Esponente della Democrazia Cristiana, ne è stato segretario regionale per la Toscana dal 1983 al 1987. Eletto alla Camera dei Deputati nel 1987 per la X Legislatura e poi riconfermato sempre nelle file della DC alle successive elezioni del 1992, ha rivestito l’incarico di sottosegretario della Pubblica Istruzione nei governi Amato e Ciampi. Nel marzo 2019 è stato eletto Presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze.
[2] Glasnost’ (convenzionalmente, “trasparenza”) e Perestrojka (“ricostruzione”) indicano come noto l’insieme di riforme che caratterizzarono il nuovo corso politico di Mikhail Gorbačëv, ultimo segretario generale del Partito Comunista Sovietico, e che innescarono la catena di eventi che portò alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
[3] Ciriaco De Mita, politico, segretario nazionale della DC e Presidente del Consiglio dal 13 aprile 1988 al 22 luglio 1989. Nell’ottobre del 1988 De Mita, assieme al Ministro degli Esteri italiano Giulio Andreotti, si recò a Mosca in visita ufficiale a Michail Gorbačëv.
[4] Leonid Brežnev, Jurij Andropov e Konstantin Ustinovič Ĉernenko, in ordine i tre segretari generali del Partito Comunista Sovietico prima di Mikhail Gorbačëv.
[5] Matulli si riferisce qui alla famosa domanda che il giornalista italiano dell’ANSA Riccardo Ehrman pose il 9 novembre 1989 nel corso di una conferenza stampa a Berlino Est a Günter Schabowski, portavoce del governo della DDR circa l’entrata in vigore del nuovo regolamento di transito tra le due Germanie; regolamento dibattuto nei giorni precedenti dalle autorità tedesche orientali e nel quale erano contemplate graduali aperture nella legge che impediva l’espatrio ai cittadini della DDR. Al quesito di Ehrman, se cioè il regolamento valesse anche per il transito da Berlino Est a Berlino Ovest e se sì da quando, Schabowski rispose inavvertitamente “a quanto ne so, da subito”. La notizia, rilanciata da tutta la stampa, fu letta come il preavviso della decisione delle autorità della Germania dell’Est di aprire il confine tedesco e spinse un ingente numero di persone a radunarsi presso il muro
[6] Il 12 novembre 1989, il segretario del Partito Comunista Italiano Achille Occhetto durante la commemorazione del 45° anniversario della battaglia di Porta Lame tenutasi a Bologna nella sala comunale di via Pellegrino Tibaldi, nel rione della Bolognina del quartiere Navile, annunciò l’apertura (da cui, la “svolta della Bolognina”) del processo politico che porterà il 3 febbraio 1991 allo scioglimento del Partito.
[7] Giulio Quercini (Siena, 16 dicembre 1941), consigliere regionale dal 1980 al 1987, segretario federale toscano del Partito Comunista italiano e deputato alla X Legislatura.
[8] Matulli qui allude al cartello-manifesto che aprì il Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana del 18 aprile 1990 nel quale campeggiava accanto alla foto di De Gasperi e sopra lo scudo crociato la scritta: “18 APRILE 1948 18 APRILE 1990 DALLA PARTE GIUSTA”
[9] Matulli allude alla famosa frase pronunciata in occasione della riunificazione tedesca da Andreotti: “Amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due”
[10] Giuseppe Matulli, Alcide De Gasperi: quando la politica credeva nell’Europa e nella democrazia, Prefazione di Enrico Letta, Clichy, Firenze 2018.
[11] Georges Bidault, Presidente del Governo provvisorio della Repubblica francese dal giugno 1946 al dicembre 1946 e poi Presidente del Consiglio francese dall’ottobre 1949 al giugno 1950
[12] Mino Martinazzoli, l’ultimo segretario nazionale della Democrazia Cristiana e promotore della fondazione, il 18 gennaio 1994, del nuovo Partito Popolare Italiano di cui divenne Segretario generale.
[13] Si allude al manifesto (L’Appello ai liberi e forti) redatto nel 1919 dalla Commissione provvisoria guidata da Don Luigi Sturzo al momento della fondazione del Partito Popolare Italiano
[14] Tra il 19 e il 24 marzo 1989, Matulli, assieme ai colleghi parlamentari Luigi Castagnetti e Michelangelo Agrusti, compì un viaggio oltrecortina a Praga, dove ebbe la possibilità di entrare in contatto con alcuni dei principali dissidenti storici del regime comunista cecoslovacco, tra i quali Alexander Dubček, Václav Havel e Jiří Hájek. Successivamente, compì un secondo viaggio a Praga tra il 2 e il 5 gennaio 1990, dopo cioè la caduta del Muro di Berlino, incontrando nuovamente i dissidenti, protagonisti nel frattempo della “Rivoluzione di velluto” che tra il novembre e il dicembre 1989 aveva portato alla dissoluzione del regime comunista cecoslovacco. Di entrambi questi viaggi, Matulli pubblicò un breve diario, cfr. G. Matulli, Praga prima e dopo. Diario di un viaggio in due stagioni, Centro Toscano di Documentazione Politica, supplemento gratuito, A. IV, n. 3, marzo 1990.
[15] Michelangelo Agrusti, politico e parlamentare DC
[16] XVIII Congresso nazionale del PCI che si svolse a Roma tra il 12 e il 22 marzo 1989.
[17] Václav Havel, politico e drammaturgo ceco, dissidente e perseguitato politico sotto il governo comunista della Cecoslovacchia. Dopo la “Rivoluzione di velluto” fu tra il 1989 e il 1992 l’ultimo Presidente della Cecoslovacchia e nel 1993 primo Presidente della neocostituita Repubblica Ceca.
[18] Movimento di dissenso costituito in Cecoslovacchia nel 1977 da alcuni eminenti esponenti dell’intellettualità e della cultura, tra cui lo stesso Václav Havel, il diplomatico Jiří Hájek, il filosofo Jan Patočka, il drammaturgo e poeta Pavel Kohout
[19] Jiří Pelikán attivista cecoslovacco, tra i sostenitori e promotori della “Primavera di Praga”, dopo la repressione sovietica del governo di Dubček trovò riparo in Italia.
[20] Gilberto Bonalumi, giornalista e parlamentare DC
[21] Jiří Hájek, diplomatico ceco e ministro degli Esteri di Dubček durante la Primavera di Praga, denuciò all’ONU l’invasione sovietica del paese e per questo fu arrestato e incarcerato. Tra i fondatori del movimento di dissenso “Charta 77”, Hájek nel marzo 1989 ricevette la delegazione italiana di cui faceva parte Matulli, facendo loro da interprete. Come appuntò nel suo diario lo stesso Matulli, Hájek, professore di storia contemporanea e di diritto internazionale “parla correttamente russo, francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo”, cfr. B. Matulli, Praga prima e dopo, cit., p. 7.
[22] Alexander Dubček, segretario del Partito Comunista cecoslovacco e artefice all’inizio del 1968 del tentativo di riforma e di liberalizzazione del sistema politico cecoslovacco (“Primavera di Praga”) poi brutalmente represso nell’agosto successivo dall’intervento delle forze armate sovietiche.
[23] Ma già nel suo diario Matulli aveva però annotato la delusione del dissidente Voclav Benda, raggiunto nel suo piccolo appartamento praghese, che gli aveva confessato: “sentiamo l’Italia lontana, la più lontana fra tutti i paesi europei. Vi siamo grati per questa visita ma l’incontro sarebbe stato più significativo se si fosse svolto nella ufficialità dell’ambasciata (come ha fatto Mitterand)”, cfr. G. Matulli, Praga prima e dopo, cit., p. 20.
[24] “Attorno alla stessa caldaia eravamo tre ed avevamo cinque lauree”, si può leggere in effetti nel diario di Matulli, cfr. Id., Praga prima e dopo, cit., p. 20. Rafforza il concetto anche un’ulteriore annotazione dell’incontro col dissidente Benda al quale – ricorda Matulli – “attualmente gli è impedito anche il lavoro manuale, per cui dice, sorridente e ironico, che la sua attuale professione è quella di “donna di casa”, ibidem.
[25] (1912-1999) Giornalista cattolico polacco, editore di numerose testate polacche, in particolare diresse dal 1945 sino alla sua morte nel 1999 il settimanale di cultura cattolica Tygodnika Powszechnego. Il periodico era stato sospeso nel 1953 per non aver voluto pubblicare il necrologio di Stalin, riprendendo le pubblicazioni a partire dal 1956.
[26] Matulli allude al primo viaggio in Polonia compiuto nel giugno 1979 da Giovanni Paolo II, il cui successo parve assestare un colpo durissimo al governo comunista polacco.
[27] Il sindacato autonomo nato nel settembre 1980 in seguito agli scioperi dei lavoratori dei cantieri navali di Danzica e guidato dal futuro Premio Nobel per la Pace Lech Wałsa, artefice del processo di dissoluzione del regime comunista in Polonia.

 La nuova “casa della cultura e della memoria” che ospita la Biblioteca nasce con l’intento di raccontare, conservare e condividere la memoria e la storia del Novecento con particolare attenzione alle vicende del territorio della provincia di Pisa in relazione ai territori contigui. Si è consapevoli, infatti, che la storia della provincia di Pisa è parte integrante di un vasto territorio, con caratteristiche storiche peculiari, che è racchiuso nell’area della Toscana Nord-Occidentale, una zona da sempre caratterizzata da flussi migratori in entrata e in uscita che l’hanno proiettata nella più vasta area del bacino del Mediterraneo e dei paesi che vi si affacciano – in particolare quelli, ma non solamente, di lingue neolatine come la Francia e la Spagna.
La nuova “casa della cultura e della memoria” che ospita la Biblioteca nasce con l’intento di raccontare, conservare e condividere la memoria e la storia del Novecento con particolare attenzione alle vicende del territorio della provincia di Pisa in relazione ai territori contigui. Si è consapevoli, infatti, che la storia della provincia di Pisa è parte integrante di un vasto territorio, con caratteristiche storiche peculiari, che è racchiuso nell’area della Toscana Nord-Occidentale, una zona da sempre caratterizzata da flussi migratori in entrata e in uscita che l’hanno proiettata nella più vasta area del bacino del Mediterraneo e dei paesi che vi si affacciano – in particolare quelli, ma non solamente, di lingue neolatine come la Francia e la Spagna.