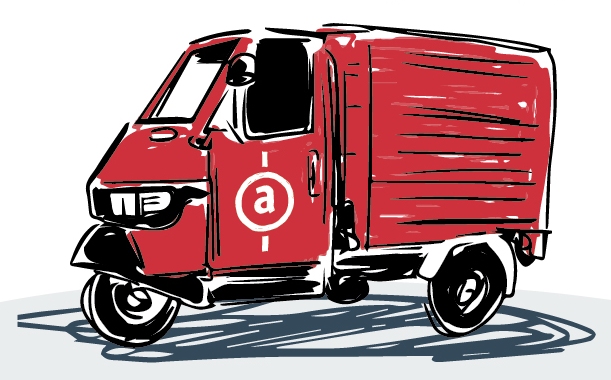12 giugno 1944: la strage di San Leopoldo

La strage di San Leopoldo, località prossima a Marina di Grosseto, è parte dei tragici eventi che accompagnarono la ritirata delle truppe germaniche lungo il litorale tirrenico, dopo la liberazione di Roma. Furono rastrellamenti, rappresaglie e azioni determinate a liberare le vie di comunicazione utili per la ritirata e colpire le formazioni partigiane. L’opera di repressione nella zona costiera fu di competenza del LXXV Corpo d’Armata tedesco. I fatti di Marina di Grosseto furono preceduti dalla strage di Roccalbegna, l’11 giugno, da rastrellamenti nella zona di Castiglione della Pescaia e nella frazione di Buriano, dove i tedeschi intendevano far terra bruciata intorno alla banda “Gruppo Tirli” del “Raggruppamento Monte Amiata”.
La mattina del 12 giugno 1944 un graduato e due militari tedeschi, incaricati di minare e far saltare il ponte sulla Fiumara di San Leopoldo, si recarono presso il casello del genio civile, dove viveva la famiglia del responsabile Fortunato Falzini. Sul posto si trovava anche una famiglia di sfollati, quella dei Lari, mentre a poca distanza vi era il podere dei Botarelli. I tedeschi gli ordinarono l’allontanamento dalla zona, malgrado un regolare permesso di residenza per il controllo del livello delle acque che gli era stato concesso da un ufficiale tedesco. Difficile capire come la situazione degenerò. Secondo la ricostruzione del prefetto di Grosseto Amato Mati del 14 giugno 1945, i tedeschi aprirono il fuoco e uccisero Falzini e Giuseppe e Livio Botarelli, padre e figlio. Al rumore degli spari, altri tentarono la fuga lungo l’argine ma furono ugualmente colpiti: Olga e Giancarlo Lari, madre e figlio, uccisi sul posto, Roma Madioni, deceduta qualche giorno dopo per le ferite. Sopravvisse un altro ferito, Armando Lari, che aveva cercato scampo all’interno di una botola. Nel complesso furono sei le vittime civili. Ma non è questa l’unica versione che ci consegnano le carte. La relazione stilata dal sindaco di Grosseto Lio Lenzi il 22 luglio 1944 descrive un rastrellamento di reparti di SS, arrivate lì per minare il ponte sulla chiusa e poi la visita nella casa di Botarelli, dove l’avrebbero ucciso dopo aver mangiato e bevuto.
Le altre cinque vittime sarebbero state uccise da una bomba a mano, gettata nella cisterna sotterranea dove avrebbero cercato rifugio, terrorizzate dalla morte di Botarelli. I morti furono seppelliti nell’argine del fossato di San Giovanni, mentre i feriti furono curati sul posto da un milite della CRI, a Grosseto prima di esser trasferiti. Al di là dell’esatta ricostruzione dei fatti, la presenza di civili sul posto fu probabilmente interpretata dai militari come trasgressione all’ordine di sfollamento della zona per ragioni strategiche. Dall’ottobre 1943, su dirette disposizioni di Hitler, era stata infatti disposta l’evacuazione della popolazione costiera per una profondità di 5 Km nel tratto Livorno-Napoli, per motivi strategico-militari. I civili dovevano lasciare il posto alle forze tedesche, perché fosse approntata la linea di difesa costiera utile a fronteggiare l’eventuale sbarco degli Alleati.
Nel caso di San Leopoldo, nell’unica ricostruzione storica finora pubblicata (Fulvetti, 2009), l’elemento scatenante la violenza potrebbe essere stato l’eccessivo numero di persone riparate presso il casello. Rimase e rimane tuttora ignota l’identità dei militari tedeschi autori della strage. Tra i familiari delle vittime, subito dopo la Liberazione, cominciarono a circolare accuse di complicità nei confronti di alcuni fascisti locali: otto persone, sospettate di aver sollecitato l’eccidio, ma prosciolte in istruttoria per l’impossibilità di avvalorare tali sospetti con elementi concreti.

Particolare della lapide in memoria delle vittime, collocata nei pressi del pattinodromo di Marina di Grosseto
Se solo da alcuni anni questo frammento di storia è riemerso ed entrato nella memoria collettiva ufficiale, mentre era solo patrimonio di ricordi di singoli, testimoni diretti o indiretti, è certo a causa dell’assenza del percorso della giustizia, esito processuale dell’istruttoria. Quanto alla storiografia, poco o nulla era stato scritto nell’ambito degli importanti studi sulle stragi nazifasciste in Toscana, che ci sono stati consegnati dal gruppo di specialisti dell’Università di Pisa e da quanti furono coinvolti dalla Regione Toscana nell’attuazione di una legge (“Per salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana”). Uno straordinario vuoto di fonti scritte ha ostacolato le insistenti ricerche, promosse dall’Istituto storico grossetano e sollecitate anche dal Comune di Grosseto. A lungo nulla è emerso dalle carte del Comitato di Liberazione nazionale, nulla dalla corposa documentazione presente nell’Archivio di Stato su fascismo, guerra e Resistenza. Solo fascicoli personali dei sospettati, frutto della prima istruttoria del CLN grossetano, hanno fatto una prima luce sull’accaduto, lasciando però insoddisfatto il desiderio di giungere a una cronaca certa e a una definitiva interpretazione delle responsabilità, dirette e indirette.
Rimane indiscutibile il quadro interpretativo generale: la strategia deliberatamente attuata in applicazione delle direttive dei Comandi tedeschi ha lasciato una scia di sangue anche a San Leopoldo, alla vigilia della Liberazione della città di Grosseto, avvenuta tre giorni dopo, quando ormai le autorità civili e militari fasciste l’avevano abbandonata.
Il progetto nazionale di Atlante delle stragi nazifasciste, ormai in fase conclusiva, rivela qui un sovrappiù di utilità. Si aggiungerà alla restituzione di memoria che si è tradotta da qualche anno in un cippo e nel 71° anniversario della strage, in un pannello che trasformerà finalmente la Chiusa di San Leopoldo in un luogo da inserire tra gli itinerari della memoria.
Articolo pubblicato nel giugno del 2015.