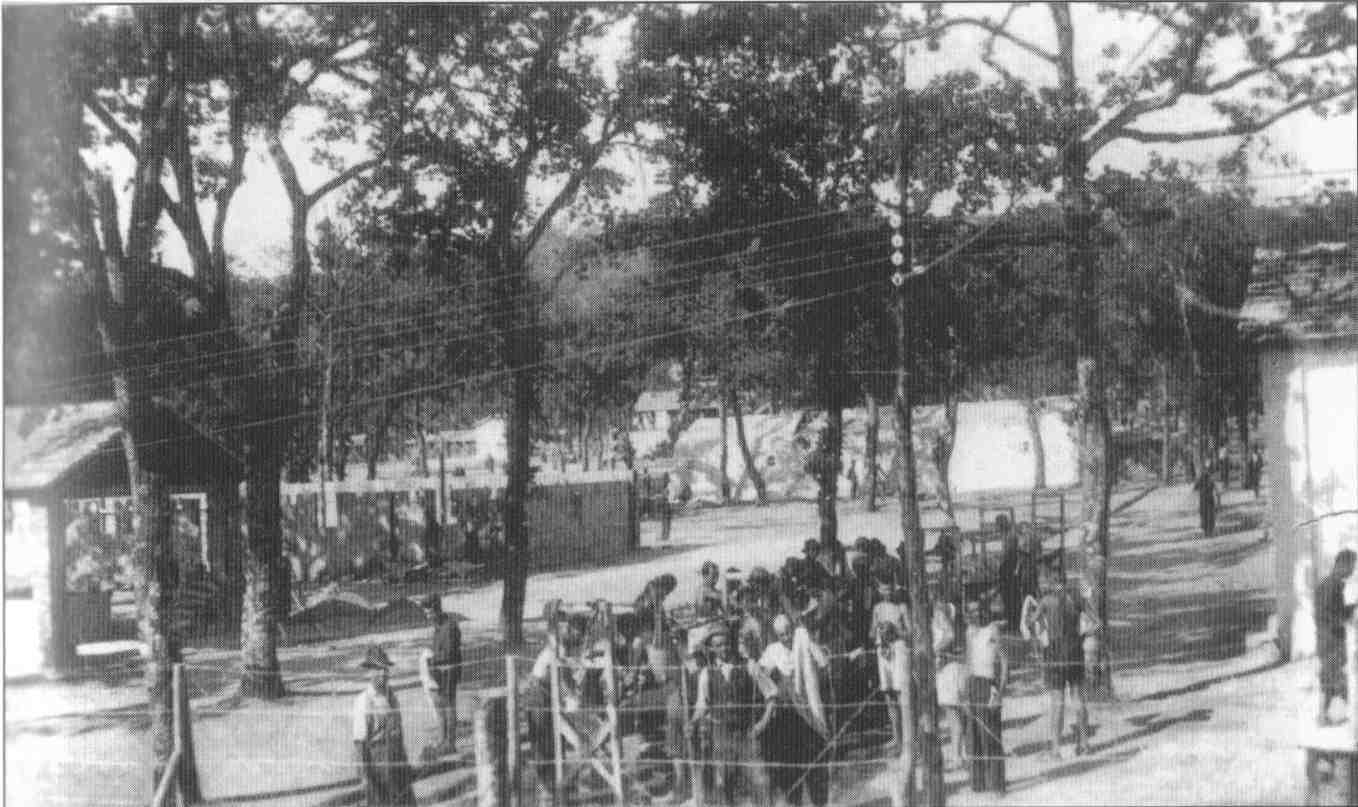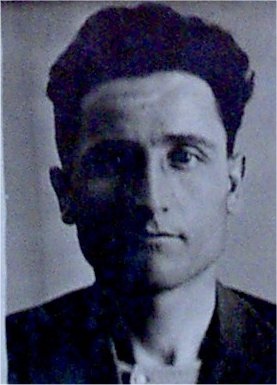Grosseto e la sua provincia sono stati governati per tutto il secondo dopoguerra dal PCI; un governo egemonico, protagonista della modernizzazione e autore delle più importanti scelte politiche, economiche e sociali che ancora oggi caratterizzano questa provincia. Sin dalle prime consultazioni elettorali post-Liberazioe il PCI risultò partito di maggioranza relativa nel capoluogo e in molti comuni della provincia di Grosseto. Amministrò con giunte di coalizione, mantenendo un’alleanza con il Partito Socialista che, al di là di brevi parentesi di cui si dirà più avanti, non venne rotta dall’inaugurazione dei governi nazionali e in qualche caso locali di centro-sinistra. Caso che ha una sua singolarità, l’ inaugurazione del sostegno a una giunta a guida repubblicana già nei primi anni ‘70. Tema rilevante è il rapporto con la Democrazia Cristiana, partito egemone a livello nazionale, soggetto localmente rilevante in certi momenti storici, soprattutto nella fase di attuazione della Riforma Fondiaria.
Osservando la società grossetana tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 è facile notare una fitta trama di associazioni e di gruppi fortemente connotati da una più antica tradizione repubblicana, garibaldina, anarchica che mostra chiaramente un carattere identitario ribelle e sovversivo.
In questo contesto si svilupparono facilmente le idee socialiste e soprattutto quelle comuniste. Nel 1921 quando la frazione comunista decise la scissione dal Partito Socialista Italiano anche a Grosseto vennero immediatamente fondate numerose sezioni comuniste. Una sentita tradizione sovversiva della zona rendeva ancora forte l’attaccamento ideologico delle masse operaie e contadine locali al partito socialista; i comunisti non erano invece riusciti né a fare proselitismo né a strutturare il partito e nelle elezioni politiche del maggio 1921 i socialisti risultarono il primo partito in provincia; i comunisti non riuscirono a eleggere nessun deputato. Da lì a poco, sotto la spinta delle violenze fasciste, le sezioni comuniste si svuotarono velocemente e i pochi militanti rimasti si organizzarono in partito clandestino.
Dunque, da cosa deriva il consenso dei comunisti nel secondo dopoguerra?
È sicuramente fondamentale il periodo clandestino durante il regime, in cui il partito assume un ruolo dominante nella compagine antifascista. I comunisti grossetani, infatti continuarono sotto il fascismo la propria attività politica, tanto che un protagonista dell’epoca, Aristeo Banchi, detto Ganna, così descriveva la fortuna che i comunisti raccolgono in quegli anni:
“Il fatto che molti comunisti fossero arrestati e continuamente perseguitati nelle forme più diverse, attirò l’attenzione e la simpatia di molti, per lo più giovani, di tendenze politiche diverse e appartenenti alla media borghesia cittadina: studenti, impiegati, artigiani e commercianti. Il comportamento di questi uomini, tenaci, entusiasti della loro attività antifascista, onesti nel lavoro e nella vita, li fece riflettere e cominciarono ad interessarsi della loro attività e vollero conoscere questo Partito Comunista, che era riuscito, a differenza degli altri partiti che erano spariti, a dare speranza per periodi migliori” (Aristeo Banchi, Si va pel mondo).
Ma il consenso verso i comunisti si accrebbe senza dubbio durante i difficili anni della Resistenza, quando il Partito comunista ebbe un ruolo predominante nella guerra partigiana; è in quei pochi mesi che vanno dall’8 settembre 1943 alla Liberazione nel giugno del 1944 che il Partito Comunista iniziò a costruire la propria egemonia nella provincia di Grosseto.
Una volta liberata, la provincia visse un periodo di grande fermento sociale ed economico con le numerose proteste dei contadini che chiedevano la terra e quelle dei minatori che volevano migliorare le proprie condizioni di lavoro ed economiche. È in questo contesto che il partito comunista locale riesce a legarsi con le masse popolari del territorio creando una solida e indissolubile base elettorale e di consenso per il futuro. Per i comunisti grossetani le lotte ebbero una duplice importanza, poiché, da una parte, furono il luogo dove si formò politicamente ed umanamente la classe dirigente che dopo pochi anni prenderà in mano il partito, e dall’altra, le lotte rappresentarono un’opportunità di crescita di consenso. Grazie ad un attento e duro lavoro di propaganda i comunisti grossetani riuscirono a mettersi alla guida di quelle battaglie; era grazie al lavoro di massa, come si diceva all’epoca, che il PCI riuscì a guidare le proteste e a condurle, attraverso le parole d’ordine che il partito stesso decideva, verso il voto comunista.
È necessario sottolineare che le lotte sociali in quei primi anni della Repubblica rappresentarono per un partito di massa come il PCI la vera e propria ragione d’essere: grazie a queste il PCI aumentava la propria forza e il proprio radicamento sociale. Ma non bisogna dimenticare che il PCI a Grosseto era anche un partito di governo che, fin dalla Liberazione, iniziò ad amministrare la quasi totalità degli enti locali. Non potendo prescindere dalle masse popolari e dalle proteste, questi due aspetti costringevano il PCI ad avere un duplice e parallelo modus operandi: da una parte, dovendo governare localmente il territorio, era obbligato a mantenere basso lo scontro sociale verso gli enti locali ma dall’altra parte, continuava a dirigere i movimenti di protesta e il conflitto sociale convogliando il malcontento contro il governo nazionale democristiano. La vera sfida che il PCI dovette affrontare nelle province come Grosseto, dove aveva un ruolo di governo, era quella di riuscire ad avere il monopolio della critica sociale subordinata alla propria idea politica.
Ma la costruzione del consenso comunista nel grossetano doveva passare anche da una capillare organizzazione territoriale e da una forte militanza.
Il PCI, fin dal primo congresso di Lione, aveva scelto una forma di organizzazione non verticistica ma basata su un forte rapporto con il territorio attraverso le federazioni, le sezioni e le cellule. Quest’ultime rappresentavano una vera e propria novità del movimento operaio italiano ed avevano lo scopo di propagare e diffondere le idee del partito sul territorio; con le cellule il partito poteva riuscire a conquistare e a coinvolgere le masse popolari. Il segretario della Federazione comunista Grossetana Guglielmo Nencini, nel Comitato Federale del 28 ottobre 1944 (uno dei primi dopo la liberazione di Grosseto) così riassumeva l’importanza dell’organizzazione cellulare del partito:
“La cellula è il tipo di organizzazione che più di ogni altro permette una intensa vita di partito, una più facile e continua opera di chiarificazione ideologica ed è quella che permette una maggiore tutela del partito contro ogni frazionismo o scissionismo. Ma non basta: la cellula è lo strumento più perfetto e potente di penetrazione politica nella massa popolare, è l’organismo che meglio di ogni altro permette al partito di orientare, guidare le classi popolari e quindi di stringerle attorno alla classe operaia in un blocco unitario veramente inscindibile” (Fondo Nencini, Isgrec).
Fin dalla Liberazione, nella provincia di Grosseto furono aperte numerose sezioni comuniste tanto che il PCI ben presto ottenne una enorme e capillare diffusione territoriale. Ogni paese, ogni città, aveva una sezione; soltanto a Grosseto fino alla prima metà degli anni ’80 si contavano ben 5 sezioni cittadine e altre 15 sparse per tutto il territorio comunale; mentre in provincia si contavano all’incirca altre 135 sezioni per un totale di circa 155 in tutta la Federazione. La nascita, e spesso la costruzione, delle sezioni comuniste era possibile grazie alle sottoscrizioni dei militanti che raccoglievano denaro o che spesso mettevano a disposizione del partito le proprie competenze o il proprio lavoro per la costruzione materiale delle sedi.  La vecchia sede della Federazione provinciale di Grosseto venne realizzata grazie alla sottoscrizione e al lavoro volontario dei militanti comunisti; una volta ultimata, venne inaugurata nel 1957 da Palmiro Togliatti. Stessa cosa avvenne per la Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano che venne inaugurata nel 1973 da Pietro Ingrao.
La vecchia sede della Federazione provinciale di Grosseto venne realizzata grazie alla sottoscrizione e al lavoro volontario dei militanti comunisti; una volta ultimata, venne inaugurata nel 1957 da Palmiro Togliatti. Stessa cosa avvenne per la Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano che venne inaugurata nel 1973 da Pietro Ingrao.
Ovviamente l’organizzazione e la diffusione sul territorio non poteva reggere senza la militanza di migliaia di grossetani che accrebbero e favorirono l’egemonia comunista in provincia. I militanti comunisti, nei loro luoghi di lavoro e nei loro paesi di residenza donavano volontariamente e con passione il proprio tempo libero al partito, per migliorarne l’organizzazione, per le campagne elettorali e per le Feste de l’Unità.
La rigida morale comunista del primo dopoguerra obbligava i militanti ad una vita sobria e completamente donata alla causa comunista. Questi avevano il dovere, come si legge nell’articolo 9 dello Statuto del PCI del 1951, oltre a “partecipare regolarmente alle riunioni e a svolgere attività di partito secondo le direttive dell’organizzazione”, ad avere rapporti di lealtà e fratellanza con gli altri militanti; vigilare sulle buone sorti del partito e mantenere una “vita privata onesta, esemplare”. Il militante comunista, quindi, doveva dare l’esempio morale anche nella propria vita privata e aveva l’obbligo di “esercitare la critica e l’autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella del partito” attraverso anche una continuo miglioramento della propria “conoscenza della linea politica e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione”.
Purtroppo non è possibile descrivere uno scenario organico per quanto riguarda le iscrizioni dei militanti poiché mancano molti dati nell’archivio della Federazione comunista, conservato presso l’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea; tuttavia è possibile affermare che il numero degli iscritti in provincia di Grosseto rispecchiava le medie delle altre province toscane.
L’egemonia comunista non aveva bisogno solo di una forte base sociale su cui fondare la propria organizzazione, ma necessitava anche di rapporti stabili con le altre forze politiche locali. Infatti, senza una solida politica delle alleanze, il partito non avrebbe potuto mantenere la propria posizione.

Manifestazione comunista a ribolla (anni ’50)
Osservando i risultati elettorali del PCI nelle varie elezioni amministrative, si notano due tendenze distinte. La prima mostra, dagli anni ’50 fino alle elezioni regionali del 1970, un sostanziale consolidamento del consenso elettorale del PCI, a scapito chiaramente sia delle opposizioni (DC, Psdi, Pli, Pri), che del principale alleato di sinistra ovvero il PSI. La seconda tendenza, che riguarda il periodo dal 70 fino alle fine del 90, mostra invece una lenta e parziale erosione del consenso elettorale comunista a favore degli alleati socialisti. Questa perdita di voti però non si traduce in una diminuzione di consenso e l’egemonia comunista rimane ben salda; piuttosto la lieve crisi elettorale va imputata alla crescente fortuna politica che il PSI vive in quegli anni.
Il PCI, quindi, costruì il proprio potere locale sull’alleanza strategica con il PSI, creando una sostanziale continuità di governo e dando alle istituzioni locali una forte stabilità politica. Questa alleanza non solo aveva radici ideologiche, ma si basava su un preciso accordo elettorale politico e programmatico che tra le altre cose prevedeva una ferrea e rigida distribuzione, sia delle cariche politiche elettive, che delle cariche di nomina politica nei vari enti locali e collaterali. Nella distribuzione di questi vari incarichi il PCI, forte del suo peso elettorale, faceva valere la propria egemonia ed aveva la meglio sugli alleati socialisti, creando così non pochi malcontenti. Leggendo i verbali dei Comitati federali comunisti di quegli anni è facile trovare numerose notizie a riguardo ma bisogna tenere ben presente che le nomine politiche all’interno degli Enti Locali erano una pratica diffusa, considerata normale ed erano soprattutto permesse dalla legge.
Spesso però le alleanze politiche locali venivano influenzate dalla politica nazionale, come nel caso dell’unificazione socialista del 1966 che portò all’allontanamento del PSI dalle giunte locali. Nel 1967, i socialisti uscirono dalla Giunta provinciale e i comunisti dettero vita ad monocolore con il Presidente Palandri; stessa dinamica avvenne nelle altre amministrazioni locali compreso il Comune di Grosseto. Nel comunicato stampa che i comunisti grossetani diffusero in quell’occasione si legge della grande preoccupazione comunista nel constatare che
“la gravità di questa decisione che avviene con motivi estranei ai problemi e agli impegni programmatici di quelle assemblee elettive nelle quali, da 20 anni e con un sensibile lavoro unitario, la collaborazione tra PCI e PSI ha consentito il conseguimento di estesi successi nell’interesse della città e delle masse popolari” (Archivio PCI-PDS, Isgrec).
Per i comunisti grossetani la crisi dell’alleanza con il PSI era palesemente influenzata dalla politica nazionale ma metteva in serio pericolo la stabilità stessa dei governi locali:
“il disimpegno del PSI-PSDI unificati non è altro che il primo passo di una politica che obbiettivamente può portare le amministrazioni pubbliche grossetane a serie difficoltà, con la conseguenza immediata di sacrificare e ritardare soluzioni urgenti ed inderogabili e con il pericolo di aprire la via a gestioni commissariali in ossequio agli obbiettivi e alla volontà della DC di cancellare la posizione di potere delle forze di sinistra” (Archivio PCI-PDS, Isgrec).
Il PCI, nonostante l’unificazione socialista e la crisi che ne scaturì, rimase al governo con le proprie forze e quando nel 1970 la riunificazione naufragò, i socialisti grossetani rientrarono in tutte le amministrazioni locali e la crisi poté dirsi conclusa. Se il rapporto con i socialisti fu continuo e costruttivo, ben diverso fu il rapporto politico con le altre formazioni democratiche locali.

X Congresso Provinciale del PCI (1972)
Con il Partito repubblicano italiano, ad esempio, non ci fu mai una vera e propria alleanza politica-elettorale, nonostante il dialogo portato avanti dai comunisti dagli anni ’70 e che vide l’entrata dei repubblicani nell’amministrazione Valentini del Comune di Grosseto negli anni ’80.
Nonostante questo, il massimo punto di avvicinamento politico tra PCI e PRI, sia a livello politico, ma soprattutto mediatico, si ebbe nel 1974, durante le elezioni amministrative del Comune di Monte Argentario, quando Susanna Agnelli, eletta consigliera comunale per il PRI, ottenne l’astensione dei comunisti per varare la propria giunta. Quella di Monte Argentario, con l’astensione comunista a favore dell’amministrazione Agnelli, fu la prima esperienza di maggioranza alternativa all’alleanza social-comunista.
La crisi a livello nazionale che si andò a creare tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 tra il PCI e il PSI ebbe degli echi anche in provincia. Nel 1976 Aldo Tonini, Segretario provinciale del PSI, nel suo discorso durante il XXXI Congresso Provinciale descriveva i rapporti tra il PSI e il PCI “sempre tranquilli e senza problemi” pur tuttavia sottolineando un malcontento:
“in virtù della politica del compromesso storico che il PCI persegue ad ogni livello, nella ricerca costante di un rapporto privilegiato con la DC si verificano contrasti e tensioni all’interno della maggioranza di sinistra. In tempi anche recenti autorevoli esponenti comunisti locali hanno affermato che le difficoltà che di volta in volta sorgono nei rapporti tra PSI e PCI all’interno delle maggioranze sono dovute alla riottosità dei socialisti di fronte ad ogni ipotesi di allargamento delle maggioranze stesse e persino alla chiusura ed agli ostacoli verso ogni tentativo di realizzare un rapporto nuovo con le minoranze” (Archivio PCI-PDS, Isgrec).
Quando poi, sulla scia dei successi elettorali nazionali, il PSI migliorò i propri risultati elettorali locali, la crisi tra i due alleati si fece ancora più palese soprattutto perché il PSI iniziò a chiedere sempre più peso e potere politico. A riguardo può essere utile la posizione democristiana che, dopo anni di isolamento, negli anni ’80 iniziò a cercare di scalzare il potere comunista, proponendo un accordo con i socialisti. Hubert Corsi, durante il Congresso provinciale della Democrazia Cristiana del 22 febbraio 1981, nel suo discorso da Segretario provinciale lamentava l’atteggiamento frontista e la chiusura politica del PCI, affermando che il PCI “è stato abile a cedere certe posizioni [al PSI], talora anche contro la logica elettorale, pur di coinvolgerlo in un’alleanza di carattere generale” in modo da soddisfare “le crescenti aspettative di potere” ottenendo in cambio “certezze e potere”; il PSI di contro, nella lettura democristiana “è stato abile a cercare di trarre dalle difficoltà del tradizionale alleato, il maggiore vantaggio; assicurandosi posizioni di forza superiore alla propria forza elettorale”.
Tra minacce di maggioranze alternative e miraggi pentapartitici, la crisi tra PCI e PSI si rese ancora più palese quando nel 1988 problemi di natura giudiziaria coinvolsero membri socialisti della giunta comunale.
In quella situazione però furono chiari almeno due aspetti: da una parte le opposizioni e i socialisti non avevano una forza tale per rappresentare una vera alternativa al governo comunista; dall’altra invece, ancora una volta, risultò evidente, a Grosseto e in provincia, come il PCI fosse l’unica forza egemonica.
Articolo pubblicato nell’ottobre del 2015.