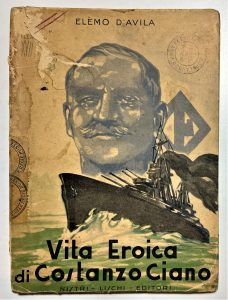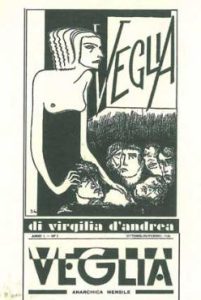Giuseppe Piccinetti, un socialista “di carattere ardito”.

Nel centenario della sua drammatica uccisione, la popolare figura di Giuseppe Piccinetti appare di assoluto rilievo nella storia del socialismo livornese, anche se del tutto trascurata dalla storiografia locale[1].
Nato a Livorno il 12 febbraio 1876, figlio di Silvestro ed Eufemia Terzetti, la sua vita e la sua militanza risultano strettamente legate al quartiere di S. Jacopo, abitato soprattutto da operai e qualche pescatore, a ridosso del lungomare, dove all’epoca vi erano concentrate alcune vetrerie e una fonderia.
Dal fascicolo del Casellario Politico Centrale a lui intestato – da non confondersi con l’omonimo militante comunista, suo nipote[2] – è possibile desumere varie informazioni biografiche[3].
 Dopo aver frequentato le prime classi elementari, iniziò a lavorare da muratore, venendo poi assunto come cantoniere comunale (stradino). «Anarchico di nascita, ma socialista fin da gioventù», assunse ruoli politici e sindacali di primo piano.
Dopo aver frequentato le prime classi elementari, iniziò a lavorare da muratore, venendo poi assunto come cantoniere comunale (stradino). «Anarchico di nascita, ma socialista fin da gioventù», assunse ruoli politici e sindacali di primo piano.
Nell’aprile del 1906 venne eletto, con il maggior numero dei voti (892, due più di Russardo Capocchi, segretario della FIOM), nella giunta esecutiva della Camera del Lavoro nonché nominato segretario della Camera stessa. Nel maggio seguente anno, «unico renitente al crumiraggio», fu punito con una sanzione disciplinare dall’Amministrazione municipale per essersi rifiutato di sostituire i netturbini comunali in sciopero[4]. Nel 1909, risultò confermato nella giunta camerale con 1040 voti, così come nel giugno 1919.
Inoltre, dal 1904 al 1910, fece parte del consiglio della Cooperativa di Consumo “Avanti” con sede presso la Vetreria Operaia Federale, in piazza delle Isole (dal 1903 p.za Brin), in S. Jacopo.
Già nel gennaio 1914, «accusato di reato ideologico, come impiegato comunale e dirigente sindacale», era stato oggetto di una denuncia per aver sostenuto lo sciopero dei dazieri, venendo difeso da un comitato d’agitazione, promosso dai socialisti in sua solidarietà («Corriere di Livorno», 30 gennaio 1914); ma risale all’ottobre seguente
la sua “schedatura” da parte degli organi di polizia, quale socialista, abitante in via dell’Eremo 1, coniugato con Maria Lubrano (1883-1967) e, dal 1906, padre di Bruno (futuro militante comunista[5]).
Nello stilarne il “profilo biografico”, vennero annotati i suoi “precedenti” giudiziari, per lo più legati a reati inerenti la stampa, in quanto oltre che collaboratore fu per diversi anni gerente responsabile de «La Parola dei Socialisti», il giornale della sezione livornese, fondato nel 1901.
Sempre secondo la polizia, inoltre, era in relazione con i socialisti livornesi Francesco Ulivelli, Umberto Cei, Riccardo Pierotti, Guido Tognetti, Italo Della Croce e, ovviamente, Giuseppe Emanuele Modigliani.
«Nel 1909, la sera del 12 ottobre fu Giuseppe Piccinetti che in sede di Consiglio dei Delegati delle Leghe adunate alla Camera del Lavoro chiese ed ottenne l’immediata proclamazione dello sciopero generale di protesta per l’assassinio di Francisco Ferrer. Si formarono le squadre e il Piccinetti fu tra i migliori organizzatori. La notizia dello sciopero venne subito portata dal Piccinetti stesso in Consiglio Comunale, adunato in sessione ordinaria e Modigliani Consigliere di minoranza dell’Amministrazione Malenchini prese la parola e commemorò in un religioso silenzio il fondatore della Scuola Moderna Francisco Ferrer. Il movimento riuscì in pieno e fiera fu la protesta della Livorno anticlericale».
Durante la Settimana rossa, il 10 giugno 1914, Piccinetti cercò «di fare opera pacificatrice, quando elementi facinorosi tentano con forza di invadere la Camera del Lavoro, devastandola, perché non soddisfatti dell’ordine di cessazione dello sciopero dato dalla Confederazione Generale del Lavoro».
Nonostante che nell’opinione questurina fosse ritenuto «di mediocre intelligenza» e «alcuna coltura», ebbe a dimostrarsi un efficace oratore, tenendo numerosi comizi e conferenze socialiste, partecipando anche al comizio anticlericale del 22 maggio 1913[6] e all’inaugurazione del Circolo di studi sociali l’8 dicembre dello stesso anno, assieme all’anarchico Virgilio Mazzoni di Pisa.
Ma fu soprattutto, fra il novembre 1914 e il maggio del 1915, che si mise in evidenza tenendo almeno una decina di conferenze contro la guerra, quasi tutte presso la sezione socialista di S. Jacopo, in p.za Benedetto Brin 2 (dal 1948 p.za G. E. Modigliani)[7].
Dalla relazione prefettizia riguardante la riunione svoltasi il pomeriggio del 9 maggio 1915, alla presenza di 150 persone, si apprende che Piccinetti, segretario della sezione, aveva aperto l’incontro, «annunziando che lo scopo della riunione era di discutere sulle eventualità molto prossime dell’intervento dell’Italia alla guerra Europea, che i socialisti non sono riusciti a scongiurare»; poi il socialista «si dilungò a dimostrare come l’intervento sia voluto più che altro dai capitalisti borghesi, che hanno interesse, e quindi premono sul governo come tentano di premere sulle masse per trascinarlo al macello. Disse che non spetta a loro difendere la sorella latina e che il proletariato risentirebbe gravissimo danno, se si lasciasse affascinare dagli interventisti al momento della mobilitazione. Concluse: “abbasso la guerra borghese – abbasso gli interventisti di ogni partito”»[8].
Pochi giorni dopo, con l’Italia ormai prossima ad entrare nel conflitto, il 14 maggio Piccinetti fu tra gli “antinterventisti” fermati per gli incidenti avvenuti in piazza Vittorio Emanuele[9] e l’indomani guidò in piazza Mazzini un’ultima manifestazione non autorizzata, subito sciolta dalle forze dell’ordine, di un centinaio di anarchici e socialisti[10]. In tale occasione Piccinetti venne indicato dalla polizia come socialista rivoluzionario ed arrestato, assieme ad altri sette antinterventisti, nonché incriminato per un grande cartello con «scritte sediziose» subito sequestrato.
A seguito della dichiarazione di guerra, venne subito richiamato alle armi e, dopo un primo ricovero presso l’Ospedale militare, fu inviato al fronte sul Piave, a Cavazuccherina (Ve), inquadrato quale caporale nel 199° Battaglione di Milizia territoriale, previa segnalazione alle autorità militari per vigilanza in quanto pericoloso antimilitarista.
Dopo un nuovo ricovero ospedaliero – per malattia venerea – di tre mesi in Sardegna, nel dicembre 1917 fu rinviato in zona di guerra, sempre a Cavazuccherina, venendo quasi subito denunciato al Tribunale militare di Venezia che lo condannò soltanto ad un anno e sette mesi di carcere militare (da scontare alla fine della guerra) e Lire 1000 di multa per «vilipendio dell’Esercito», grazie alla difesa assicurata dall’avvocato G. E. Modigliani, ma fu degradato ed assegnato ad una Compagnia di disciplina[11].
Tornato a Livorno a seguito dell’armistizio, Piccinetti continuò il suo impegno contro il militarismo e già il 29 dicembre 1918, quando «Mussolini venne a Livorno per un comizio al Politeama Livornese. Dopo il comizio inaugurò alla sede della Banca Commerciale una lapide e cogli applausi volarono anche i fischi. Piccinetti, presente alla cerimonia, coraggiosamente domandò la parola, ma un nugolo di poliziotti lo circondò e glielo impedì, facendolo immediatamente allontanare»[12].
Poche settimane dopo, il 2 febbraio 1919, Piccinetti potè invece intervenire in contraddittorio alla conferenza “Ai combattenti”
tenuta dal tenente vicentino Michelangelo Zimolo (di lì a poco promotore del movimento fascista e in seguito gerarca di regime) sempre al Politeama, obbiettando che «la guerra ha ribadito le catene» tanto da essere interrotto dal funzionario di PS presente, a cui fecero seguito l’accompagnamento in Questura e relativa ammonizione.
Il 12 marzo seguente, secondo rapporto di polizia, Piccinetti avrebbe costituito a S. Jacopo il Circolo ricreativo socialista “Carlo Liebknecht” e, nel giugno successivo, venne ancora eletto nella giunta esecutiva della Camera del Lavoro. Nello stesso periodo, faceva parte anche del direttivo della sezione livornese della Lega proletaria MIROV (Mutilati Invalidi Reduci Orfani Vedove di guerra) e ne fu anche segretario[13].
 Con tale ruolo nella Lega proletaria degli ex-combattenti di sinistra contribuì alla formazione delle strutture di difesa proletaria. La costituzione delle Guardie rosse fece infatti seguito alla decisione di organizzare una quarantina di aderenti alla Lega proletaria, scelti fra i circa duemila iscritti, per sostenere gli scioperi e difendere le agitazioni proletarie, così come era stato concordato dal socialista Piccinetti e dall’anarchico Augusto Consani che rappresentavano le rispettive componenti all’interno della Lega stessa[14].
Con tale ruolo nella Lega proletaria degli ex-combattenti di sinistra contribuì alla formazione delle strutture di difesa proletaria. La costituzione delle Guardie rosse fece infatti seguito alla decisione di organizzare una quarantina di aderenti alla Lega proletaria, scelti fra i circa duemila iscritti, per sostenere gli scioperi e difendere le agitazioni proletarie, così come era stato concordato dal socialista Piccinetti e dall’anarchico Augusto Consani che rappresentavano le rispettive componenti all’interno della Lega stessa[14].
Piccinetti partecipò quindi ai lavori del cruciale XVII Congresso socialista come componente di commissione, confermando la propria adesione al Partito socialista.
Per contrastare lo squadrismo fascista, nell’estate dello stesso anno, dopo la costituzione anche a Livorno degli Arditi del popolo, Piccinetti nel suo quartiere «ne fu l’animatore. Lo vedemmo sempre in testa indrappellato per le vie di S. Jacopo con la borraccia e il tascapane a tracolla contro le invadenti orde fasciste […] pronto a tutto»; infatti, le cronache confermano che nel rione operò una combattiva struttura ardito-popolare.
Il 27 ottobre 1925, attorno alle 13.30, in via del Camposanto (l’attuale via F. Pera), mentre Piccinetti si avviava al lavoro leggendo l’«Avanti!», gli furono esplose cinque rivoltellate, delle quali due andate a segno.
Ricoverato all’Ospedale civile in condizioni disperate, l’indomani fu operato da una equipe medica che gli estrasse un proiettile conficcato nella regione lombo sacrale – evidentemente sparato alle spalle – ma cessò di vivere nella stessa giornata, assistito da familiari e compagni, dopo aver confermato la fedeltà ai propri ideali. Il 28 ottobre ricorreva il terzo anniversario della Marcia su Roma e sulla stampa locale la sua uccisione fu derubricata come un delitto compiuto da un collega di lavoro – tale Ivo Spagnoli – ritenuto squilibrato di mente («Il Telegrafo», 29 e 30 ottobre 1925). Sconcertante la conclusione delle autorità di polizia secondo cui era deceduto: «non per motivi politici, ma perché fanatico seguace delle idee socialiste, e fu uno dei maggiori esponenti del partito in questa città». Tra i socialisti rimase infatti il dubbio che le ragioni dell’omicidio non fossero soltanto private (questioni di lavoro o gelosia, secondo le insinuazioni giornalistiche) e «profondo fu lo sdegno particolarmente contro i sicari più che per la persona scelta per il delitto».
Dopo il funerale con rito civile e la cremazione, i suoi resti furono accolti presso il Tempio cinerario del Cimitero della Cigna, ma vennero poi traslati nella tomba della moglie, deceduta nel 1967, presso lo stesso Cimitero (Blocco 1, gruppo 11).
Dopo la Liberazione, l’8 luglio 1945, era stato commemorato da socialisti e comunisti presso la Sezione socialista di S. Jacopo («Il Tirreno», 8 luglio 1945) che però sarebbe stata intitolata a R. Capocchi – F. Turati, e su «La Parola dei Socialisti» del 3 novembre 1946 fu ricordato con un articolo scritto da Gino Mannucci, suo compagno dai tempi dell’opposizione alla guerra[15].
NOTE
1 Basti dire che nel fondamentale testo di Nicola Badaloni e Franca Pieroni Bortolotti, Movimento operaio e lotta politica a Livorno 1900-1926 (Roma, Editori Riuniti, 1977); Piccinetti appare citato soltanto per la sua morte violenta. La figura e il ruolo di Piccinetti emergono invece nel saggio collettaneo Le voci del lavoro. 90 anni di organizzazione e di lotta della Camera del Lavoro di Livorno, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990.
2 Giuseppe Vito Egisto Piccinetti, di Antonio e Corinna Celati, nato a Livorno il 2 settembre 1902, trapanista meccanico presso il Cantiere navale Orlando, abitante in via S. Jacopo Acquaviva 38. Nel 1935 fu denunciato al Tribunale Speciale per associazione comunista e poi condannato ad un anno di carcere, scontato in attesa di giudizio (Sentenza n. 23 del 1936). Si veda Mario Tredici, L’inchiesta, la spia, il compromesso. Livorno 1935: processo ai comunisti, Livorno, Media Print, 2020, passim.
3 Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, Busta 3941.
4 «Prima di tutto io ritenni, e ritengo ancora, di non essere obbligato ad assumere, sia pure in via straordinaria, il servizio di nettezza urbana […] al secondo ordine di ragioni […] ho rifiutato perché era mio diritto rifiutare, e mi sono valso di questo diritto per una manifestazione di solidarietà operaia» (Lettera di Piccinetti al Sindaco del 18 maggio 1906, Archivio storico del Comune di Livorno).
5 Bruno Piccinetti nato a Livorno il 28 agosto 1906, occupato come cameriere e scalpellino, abitante in via dell’Eremo 2, fu arrestato nel novembre 1926 per organizzazione comunista a Venezia mentre prestava servizio militare in Marina, poi prosciolto dal Tribunale Speciale ma confinato a Ponza e Lipari per 3 anni, dove venne ripetutamente condannato per agitazioni collettive. Liberato nel gennaio 1932, subì un nuovo arresto, assieme al cugino Giuseppe, sempre per organizzazione comunista, nel gennaio 1935 e condannato dal Tribunale Speciale a 3 anni di reclusione a Civitavecchia. Liberato per amnistia nel marzo 1937, era ancora vigilato nel 1941 (CPC). Cfr. M. Tredici, L’inchiesta, la spia, il compromesso…, cit., passim.
6 Il comizio, promosso dal circolo “F. Ferrer”, si svolse in p.za B. Brin, in contrapposizione con la processione del Corpus Domini, e vi intervennero come oratori, oltre a Piccinetti, l’anarchico Virgilio Mazzoni e l’on. socialista G. E. Modigliani («Gazzetta livornese», 23-24 maggio 1913).
7 Si rimanda a Marco Rossi, Livorno antimilitarista. Cronache dell’opposizione alla guerra (1911-19119), Ghezzano, BFS, 2025.
Comunicazione del Prefetto di Livorno al Ministero dell’Interno del 10 maggio 1915 (Archivio Centrale di Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali Riservati, B. 101, F. 219, Sf. 1 “Livorno. Comizi e conferenze varie pro e contro la guerra”).
8 Complessivamente, vennero eseguiti 38 fermi di polizia. Secondo il rapporto del Prefetto, «fu dato ordine di arrestare, senz’altro, quelli già noti come pericolosi per l’ordine pubblico»: ben nove erano facchini ed almeno sei risultavano anarchici schedati (Armando Campolmi, Alfredo Cozzi, Gino Moretti, Natale Moretti, Oreste Piazzi e il diciassettenne Maceo Del Guerra).
9 Nella piazza si stava radunando un centinaio di dimostranti, per lo più anarchici e socialisti rivoluzionari, appoggiati da «un gran numero di donne», con alcuni cartelli quando l’assembramento fu sciolto con la forza; furono arrestate 8 persone che, secondo l’autorità di polizia, avevano reagito con una violenta sassaiola. Tra i fermati, rilasciati l’indomani, vi erano gli anarchici Ezio Guantini e Dino Bartolini, i socialisti Giovanni Cerri, Giulio Lucarelli ed ancora Giuseppe Piccinetti quale principale organizzatore. («Gazzetta livornese», 16-17, maggio 1915).
11 La circostanza è ricordata da Giuseppe Funaro nell’articolo Vita livornese di G. E. Modigliani, pubblicato su «La Rivista di Livorno», n. 5, sett.- ott.. 1952 (poi in «CN – Comune Notizie», n. 82 gen – mar. 2013).
12 Alla manifestazione, promossa dalla Associazioni patriottiche e tenutasi presso il Politeama, il discorso di Mussolini fu improntato all’antisocialismo e all’antibolscevismo, contrapposti alla «aristocrazia delle trincee» e di nuovo questi intervenne al momento dello scoprimento della lapide posta sulla facciata esterna della Banca Commerciale in p.za Cavour (il testo completo del discorso di Mussolini e la cronaca della commemorazione si trovano sulla «Gazzetta livornese» del 30-31 dicembre 1918).
13 La sezione livornese della Lega MIROV aveva sede presso la Camera del Lavoro, in via Vittorio Emanuele (ora via Grande), nei pressi di piazza Colonnella, e vi erano associati ex combattenti socialisti, repubblicani di sinistra e anarchici. Nel 1922, oltre a Piccinetti, del consiglio facevano parte Corrado Pagliai (segretario); il repubblicano Ezio Pini (cassiere); Virgilio, Angelo, Volpi; Guglielmo Bartolini; Werner Carlo Marquardt; Angelo Pagani; Dante Quaglierini; Antonio Ramacciotti ed Armando Tellini, mentre Giuseppe Barontini, Omero Catarsi e Sante Mattei erano incaricati per la Commissione per l’ammissione dei soci («La Parola dei Socialisti», 5 gennaio 1922; «Avanti!», 8 febbraio 1922). Cfr. Gianni Isola, Guerra al regno della guerra! Storia della Lega proletaria mutilati, invalidi, reduci, orfani e vedove di guerra (1918-1924), Firenze Lettere, 1990.
14 Successivamente, le Guardie rosse si sarebbero attivate nel settembre 1920 durante l’Occupazione delle fabbriche, poi nel gennaio del 1921 assicurando la protezione antifascista del XVII Congresso nazionale del Partito socialista e, sei mesi dopo, sarebbero in gran parte confluite negli Arditi del popolo.
15 Gino Mannucci, nato nel 1895, tipografo, era stato un attivo militante della Federazione giovanile socialista e suoi interventi risultano segnalati in vari rapporti della Questura che lo riteneva un socialista rivoluzionario. Il 23 dicembre 1914, in occasione di una riunione presso il Circolo repubblicano “Italo Possenti” in via Provinciale pisana, intervenne, in contraddittorio, sostenendo le ragioni della neutralità e l’11 aprile 1915 fu arrestato per aver distribuito volantini riproducenti le vignette antibelliciste di Scalarini pubblicate sull’«Avanti!». Nell’importante riunione della Federazione socialista livornese del 15 settembre 1917, appoggiò la mozione maggioritaria presentata da Russardo Capocchi, a favore dello sciopero generale rivoluzionario; mentre, il 23 febbraio 1918, parlò alla riunione di una trentina di giovani socialisti di S. Jacopo, ospitata presso il Circolo socialista d’Ardenza, «sull’attuale momento politico e la rivoluzione russa».