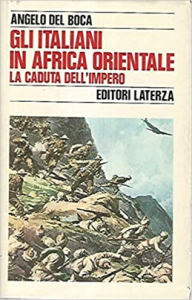Prefazione
Strano destino quello del patrimonio culturale, ovvero di quell’insieme di beni che, per il loro valore culturale e memoriale rivestono un interesse pubblico. Definizione apparentemente netta e precisa ma in realtà contingente, suscettibile delle modifiche che tempi e sensibilità diverse possono suggerire. Chi stabilisce l’interesse pubblico dei beni che vengono poi definiti come patrimonio culturale? Chi decide che cosa è patrimonio culturale o no? Sembra, quest’ultima, una domanda banale; ma è una sensazione pronta a dissolversi in chi si ricordi del Medioevo, con il Colosseo adibito a luogo di pascolo, o chi, semplicemente, ricordi la Napoli degli anni Ottanta dove Piazza del Plebiscito era considerata un grande parcheggio. Sono solo due esempi di un elenco potenzialmente lunghissimo. Ma valgono a ricordare una cosa: che siamo noi a definire chi è e che cos’è patrimonio culturale, perché in quel bene rintracciamo i nostri valori e la nostra identità.
All’interno di questa definizione possiamo senza dubbio far rientrare la toponomastica, soprattutto quando in essa parte della popolazione rintraccia i suoi elementi identitari. Il pensiero corre dunque alla recente polemica che ha investito il Liceo Amedeo Duca di Savoia di Pistoia, balzato alle cronache di molti quotidiani in quanto il Collegio Docenti ha proposto un dibattito intorno alla possibilità di cambiarne la denominazione. Innumerevoli le sdegnate polemiche, generate dal fatto che nel nome del Liceo si intravvedeva parte dell’identità della città, e da un sentire comune che identificava in Amedeo Duca d’Aosta, Viceré d’Etiopia sotto il regime fascista, morto nel 1942 prigioniero degli inglesi, una persona non collusa con il Regime.
Dal Liceo al personaggio: il punto dell’analisi storica di Amedeo duca d’Aosta
La questione ha poi travalicato il contesto locale. Ambienti monarchici, giornali conservatori, esponenti di destra e gruppi reducistici sono intervenuti in difesa del duca, agitando lo spettro della “cancel culture” e derubricando i tentativi di problematizzare il personaggio a contraffazioni della storia. Si sono trincerati dietro a una rappresentazione apologetica di vecchia data, fondata su alcuni topoi (l’eroe dell’Amba Alagi, lo sconfitto a cui il nemico tributò gli onori, il “buon colonialista”, ecc.), che ignora quanto emerso negli studi soffermatisi, anche solo en passant, sulla figura . L’incrocio di questi testi, integrato con un affondo sulle fonti a stampa, aiuta a restituire le vicissitudini del principe sabaudo a una dimensione storica.
Il racconto consolidato vuole che Amedeo d’Aosta, nato del 1898, rimase lontano dalla scena politica, almeno fino alla metà degli anni ’30. In effetti, dopo aver partecipato come volontario al primo conflitto mondiale, nell’immediato dopoguerra alternò brevi periodi in Italia, per proseguire gli studi e la carriera militare, a lunghi viaggi in Africa, prima in Somalia, poi in Congo. La data di conclusione del secondo soggiorno è, però, dibattuta: per una versione, più diffusa, il gennaio 1923, per un’altra il settembre 1922, quando si sarebbe riunito al suo reggimento a Palermo. Una questione solo in apparenza di poco conto. Infatti, nella seconda ricostruzione – accettata al tempo, evidenzia Gianni Oliva – il principe, a fine ottobre, avrebbe raggiunto Roma per presenziare, in camicia nera, al corteo squadrista dinanzi al Quirinale. Questo implicherebbe una sua adesione al fascismo, antecedente all’instaurarsi del regime. Del resto, ciò sarebbe in linea con le posizioni assunte dal ramo cadetto della famiglia regnante, di cui era erede. Il duca Emanuele Filiberto, padre di Amedeo e celebrato generale della Grande Guerra, fu precoce sostenitore di Mussolini e, secondo voci del tempo mai confermate, fu dietro ai preparativi per la marcia su Roma, pronto persino a sostituirsi al re e cugino Vittorio Emanuele III, se questi si fosse opposto ai fascisti (A. Merlotti, Savoia Aosta, Emanuele Filiberto di, duca d’Aosta, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 91, 2018).
I Savoia-Aosta persero peso politico negli anni ’20, ma il regime continuò a servirsene a scopo propagandistico, specie del giovane principe. Con il suo stile di vita, incarnava il modello dell’uomo nuovo fascista: atletico, anticonformista, avventuroso, amante dei motori, appassionato dell’Africa e protagonista delle imprese coloniali. Tra il 1925 e il 1931, infatti, prese parte, per lunghi periodi, alla riconquista della Libia, una delle pagine più buie del colonialismo italiano. Tra le dune libiche, il suo mito si consolidò: la pubblicistica, che lo ribattezzò il “principe sahariano”, dedicò ampi reportage alle sue azioni alla testa dei “meharisti”, le truppe indigene montate sui dromedari, e ai suoi voli nel deserto. Dell’esperienza in Libia, un passaggio poco indagato, perdura un ritratto romanzesco, senza cenni al suo coinvolgimento nell’attività repressiva. Eppure, non ebbe incarichi secondari: fu collaboratore, tra l’altro, del generale Rodolfo Graziani e partecipò all’offensiva contro l’Oasi di Cufra (gennaio 1931), su cui l’attenzione dovrebbe concentrarsi. Stando alla memorialistica e alla stampa coeva, il principe compii bombardamenti aerei contro il centro senusso e partecipò all’inseguimento, dai cieli, dei ribelli in rotta, tra cui vi erano anche donne e bambini. Per la rivista «Time» (Italia: Valanghe; Senussi, 9 febbraio 1931), in un articolo scritto quando i rapporti italo-americani erano ancora buoni, Amedeo si distinse nel bersagliare, con bombe e mitragliatrici, i fuggiaschi.
Rientrato in Italia e divenuto capo del casato, visse a Trieste, dedicandosi al volo e presenziando a iniziative pubbliche. Il duca partecipava alla vita del regime, ma non aveva incarichi di peso. L’occasione giunse sul finire del 1937: Mussolini gli offrì la carica di Viceré d’Etiopia. Avrebbe sostituito Graziani, che, nonostante i metodi brutali, non era riuscito a reprimere la resistenza etiope. Il duce si affidava a una figura prestigiosa,ma impreparata: Amedeo si era laureato con una tesi in diritto coloniale, ma non aveva mai ricoperto cariche politiche di grande responsabilità. Così, forse, il dittatore e gli apparati di regime contavano di avere tra le mani una personalità controllabile.
Nel primo periodo del suo mandato, in effetti, il duca incontrò difficoltà ad imporre la sua politica paternalistica e di conciliazione. Il generale Ugo Cavallero, comandante delle truppe e detentore in sostanza del potere militare, gestì la “pacificazione” in continuità con la condotta di Graziani: in questa fase avvenne la strage di Zeret (9-11 aprile 1939). Sembra che il duca preferisse non ricorrere a tali metodi, perché vanificavano i suoi piani, ma accettò – o, meglio, subì – la strategia del suo sottoposto. Dopotutto, quando il duce, spronato dagli iniziali successi, diede ordine di perseverare con questo approccio, il principe assicurò che la direttiva sarebbe stata eseguita con la massima energia .
Solo dopo la rimozione del generale (primavera 1939), il Viceré ebbe più margini, ma gli ostacoli furono diversi. Le trattative con i capi ribelli diedero risultati limitati, così le azioni repressive proseguirono, pur cercando di salvaguardare i civili. I tentativi di coinvolgere i notabili indigeni nell’amministrazione si scontrarono con l’opposizione del regime a forme di “dominio indiretto”. Non discusse, poi, le misure che contraddicevano le sue politiche. Nel suo mandato trovò applicazione la legislazione razziale e segregazionista, promulgata a partire dal 1937, che, normando la subalternità dei nativi, esacerbava le divisioni tra dominatori e dominati.
Di lì a poco, la crisi internazionale rese prioritaria l’organizzazione dei piani di guerra. L’Africa orientale italiana versava in una situazione disperata, accerchiata da colonie britanniche, difficilmente rifornibile (la Royal Navy dominava i mari) e difesa da un contingente, per metà composto di coloniali, logoro e male attrezzato. I territori del Corno d’Africa erano destinati ad essere perduti. Assalito da dubbi e scettico sull’intervento, si adeguò anche a questa scelta e assunse il comando delle forze regie nella zona. Dopo l’occupazione del Somaliland nell’estate 1940, la situazione iniziò a precipitare. La ribellione prendeva vigore, supportata da Londra, e aumentavano le avvisaglie della controffensiva britannica. Gli fu proposto di chiedere un armistizio separato, ma il principe rifiutò sdegnosamente: avrebbe significato tradire il sovrano, la patria e Mussolini, perdendo l’onore per sé e il casato. Per quanto descritto come una personalità autonoma, le vicende citate restituiscono altresì lo spaccato di una figura inquadrata nel regime, a cui fu fedele nei passaggi più controversi. Il suo atteggiamento dipendeva da un coacervo di fattori (la formazione militare, l’educazione patriottica, la tradizione familiare), che forse includeva anche un’adesione tutt’altro che formale al fascismo e fondata, in buona misura sulla devozione, per il duce, come traspare dai resoconti dei colloqui privati con la moglie del sovrintendente generale britannico in Kenya, Katharine Fannin (Alessandro Pes, British Eyes on the Fascist Empire: il viaggio di Katherine Fannin nell’Africa orientale italiana, in Id. (a cura di), Mare Nostrum. Il colonialismo fascista tra realtà e rappresentazione, Cagliari, Aipsa Edizioni, 2012, p. 26).
Nei primi mesi del 1941, le truppe regie furono travolte dalla controffensiva degli anglo-indiani, a cui si unirono le formazioni irregolari etiopi: il 6 aprile Addis Abeba veniva liberata. I comandi regi si trincerarono in vari ridotti. Il duca d’Aosta, alla testa di una forza piuttosto disomogenea di 7.000 uomini, ripiegò sul massiccio dell’Amba Alagi. Lì si si consumò la battaglia che costituisce la pietra angolare del suo mito. Prima che la narrazione epica divenisse dominante, alti ufficiali criticarono la scelta. Il gruppo montuoso era solo in apparenza inespugnabile e non aveva le risorse idriche necessarie al fabbisogno di migliaia di uomini. Vi erano, poi, alternative migliori, come unirsi ai 40.000 uomini del generale Nasi, nel Gondar (dove avrebbe resistito fino a novembre. A condizionare le mosse del duca furono, forse, l’inesperienza nel comandare grandi corpi ed errori di valutazione (in cui caddero anche generali navigati), oltre che una concezione premoderna della leadership, fondata sull’ostentazione delle virtù guerriere, ma slegata dalla pianificazione e dal calcolo. La scelta ricadde sulla montagna tigrina anche per assicurarsi, nel disastro, una fine memorabile ed eroica, emulando le gesta del maggiore Pietro Toselli, che nel dicembre 1895 vi cadde assieme ai suoi soldati, entrando però nel pantheon degli eroi della nazione.
Il 17 aprile, il Viceré si ritirò sul ridotto. Dopo l’iniziale speranza di poter prolungare la resistenza, il quadro si aggravò rapidamente. Furono presi contatti con i comandi britannici, frenati dalla ritrosia del principe a capitolare: temeva di infangare il suo onore. Neppure l’autorizzazione di Mussolini lo smosse. Tempo perduto, che comportò lo spargimento di altro sangue. Il duca, alla fine, acconsentì alla resa: a persuaderlo fu, forse, il timore che l’assalto finale sarebbe stato condotto dagli irregolari etiopi, di cui si temevano le rappresaglie. Il 19 maggio, il contingente regio lasciò il ridotto, transitando davanti al picchetto d’onore anglo-indiano. Tale aspetto è stato più volte evocato, nel recente dibattito, per provare la statura del personaggio. Nondimeno, in proposito sono necessarie opportune contestualizzazioni. Gli onori militari furono una delle condizioni poste dal Viceré per arrendersi, che i comandi britannici gli accordarono (Rovighi). Dopotutto, tale prassi, seppur di grande valore simbolico, non aveva costi strategici, ma anzi consentiva di risparmiare risorse e permetteva di avere un controllo più saldo sui prigionieri nelle convulse fasi successive alla cattura. Insomma, senza negare che le truppe regie si batterono bene, l’atto dei comandi britannici non può essere reputato spontaneo e disinteressato. Oltracciò, la cerimonia dell’onore delle armi avvenuta sull’Amba Alagi non fu un unicum nella seconda guerra mondiale. Durante l’invasione della Francia, i tedeschi garantirono simili onori ad alcune guarnigioni arresesi, così i britannici, proprio nel teatro africano, omaggiarono più gli italiani sconfitti.
La propaganda fascista sfruttò tale aspetto per enfatizzare la resistenza offerta dal distaccamento e indorare la notizia della disfatta, che preannunciava l’imminente, ma si credeva temporanea, perdita dell’Impero. “L’insuccesso glorioso” dell’Amba Alagi divenne oggetto di un racconto epico, di cui il Viceré ne era l’eroe. La sconfitta andava ricordata sia per celebrare la virtù dei protagonisti sia per alimentare la revanche nazionale. Il motto “ritorneremo” campeggiava nell’immagini del duca, risuonava nelle canzoni. Di lì a breve, questa retorica avrebbe attinto nuova linfa dalla fine prematura del Viceré in prigionia, il 3 marzo 1942, a causa del tifo e della malaria. Il regime sfruttò la notizia per demonizzare i britannici e fece del duca un eroe-martire da vendicare. La sua figura fu celebrata nei pamphlet, nelle iniziative pubblica e intitolandogli strade e edifici pubblici, come lo stesso Liceo scientifico di Pistoia.
Nel secondo dopoguerra, non soltanto i settori monarchici, gli eredi del fascismo e gli ambienti militari custodirono la memoria di Amedeo d’Aosta. Le stesse istituzioni repubblicane, che non avevano del tutto rinunciato alle aspirazioni coloniali, continuarono a celebrarlo. Nell’aeroporto di Gorizia, nel 1962, il presidente della Repubblica Antonio Segni inaugurò il Monumento all’Aviatore, un complesso ospitante una statua in travertino alta 5 metri del duca sabaudo, in uniforme da pilota e con il volto simbolicamente rivolto verso l’Africa, attorniata da dieci cippi commemoranti le sue imprese militari (dal Sabotino, nella Grande Guerra, a Cufra, in Libia, fino all’Amba Alagi). La sua figura fu poi ricordata in film, documentari e reportage delle riviste patinate dedicati allo scontro sulla montagna etiope: in essi, il Viceré spiccava positivamente come emblema del “colonialista buono”, una rappresentazione che ben si accordava col mito del “bravo italiano”. Nonostante, le iniziative pubbliche per ricordarlo si siano rarefatte e le iniziative per ricordarle siano diventate sempre più esclusiva di ambienti di nicchia, la rappresentazione romantica e malinconica, dai tratti quasi agiografici, del duca sopravvive. Sotto la coltre di un mito, «nel complesso […] falso, o falsificabile», come ha scritto Nicola Labanca, vi è una vicenda tutt’altro che lineare, con passaggi oscuri e controversi, che un’indagine storica puntuale dovrebbe farsi carico di ricostruire.
Chiara Martinelli è assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze, dove insegna “Storia dell’educazione” e “Storia ed evoluzione dei servizi per la prima infanzia”. E’ membro del direttivo dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia; collabora con i comitati di redazione di “Rivista di storia dell’educazione” e di “Farestoria”. La sua ricerca si concentra sulla storia delle istituzioni scolastiche in età contemporanea. Tra le sue opere, ricordiamo “Fare i lavoratori? Le scuole industriali e artistico–industriali italiane in età liberale” (Roma, 2019).