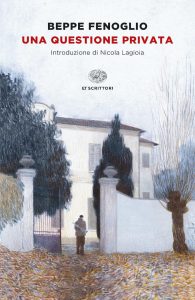Come affermato in precedenza, Giovanni Martelli viene arrestato a Livorno l’11 giugno 1932, ha solo diciannove anni e definisce negli anni quell’evento come «un duro colpo».[1] Allo stesso modo, il 1932 rappresenta un anno difficile per la riorganizzazione della Federazione comunista livornese, in quanto molti militanti adulti e di spicco vengono arrestati.
Dapprima, Martelli viene fermato e perquisito da un poliziotto dell’OVRA, successivamente gli viene trovato un biglietto che testimonia la sua attività nell’organizzazione del Soccorso rosso.[2] Viene interrogato alla Questura Centrale dal Commissario dell’OVRA Parlagreco, il quale deduce che non solo egli militava nel PCd’I, ma che addirittura apparteneva alla Federazione insieme ad altri esponenti che erano già stati arrestati nei giorni precedenti. Martelli è costretto a riconoscere ed a identificare gli altri compagni di partito, come Leonardo Leonardi, Roberto Vivaldi e Giovanni Tardini. Martelli affermò che non conosceva nessuno, se non qualche individuo adulto dell’organizzazione comunista. Resistere però non è sempre facile e si può comprendere dalle parole usate nell’Autobiografia, in cui egli stesso racconta:
«[…] Pur insistendo a negare […], essi mi fecero uscire e dopo poco fui di nuovo chiamato e così mi trovai di fronte al Vivaldi, il quale – disgraziato – era in uno stato da fare pietà.
Mi domandarono: lo conosci?
No, risposi, non l’ho mai visto.
Essi allora si rivolsero al Vivaldi il quale mi disse: è inutile Martellino, non negare, sanno tutto, essi sanno e conoscono tutto del nostro movimento e quindi non vale la pena insistere, del resto hanno confessato tutti.
Per la verità rimasi molto colpito, non riuscivo a comprendere come esso avesse capitolato così; tuttavia, continuai a negare […]»[3]
Successivamente, viene sottoposto a una perizia calligrafica per vedere se davvero fosse stato lui l’autore del biglietto sul Soccorso rosso. Il biglietto conteneva un prestito in denaro da fare ad alcuni esponenti del Partito ed era stato realizzato da un altro militante, Iedo Tampucci. Martelli non rivelerà mai il nome dell’autore e il contenuto del biglietto.
Durante l’interrogatorio scopre che la denuncia era stata avanzata dal dirigente della Federazione, Roberto Vivaldi. Vivaldi era stato costretto a denunciare proprio perché, come si legge nell’Autobiografia, l’OVRA aveva scoperto l’organizzazione comunista. Effettivamente, molte cose erano cambiate all’interno della Federazione durante l’arresto di questi esponenti: l’organizzazione sembrava essersi sfasciata e sembrava aver smarrito le linee guida necessarie per ricostituirla. L’unica speranza era quella di riedificare il movimento con una nuova linfa, ma i militanti rimasti si rifiutavano di prendere parte a questo processo in quanto temevano l’intervento della polizia fascista.
Nel luglio 1932 Martelli viene mandato in prigione presso il carcere S. Leopoldo e denunciato al Tribunale speciale con l’imputazione prevista dall’articolo 270 del Codice Penale. Viene poi trasferito al carcere dei Domenicani e liberato nell’ottobre dello stesso anno in occasione dell’amnistia per il decennale dalla Marcia su Roma. Quell’arresto fu uno dei più grandi realizzati dall’OVRA, non solo per il numero di arrestati, ma anche perché raggiunse i compagni che stavano espatriando. Con la scarcerazione poco sarebbe cambiato nella vita di Martelli, perché sa che la condizione di vita in clandestinità e la lotta al fascismo sarebbero continuate. Lui stesso racconta:
«[…] La libertà era certo bella per tutti noi tuttavia, quasi spontaneamente, una parte di noi giovani decise di dare continuazione alla propria attività clandestina. Dico una parte perché, sia nel campo giovanile come in quello degli adulti non pochi si ritirarono a vita cosiddetta privata. Non ce ne facemmo motivo di scandalo. Pertanto ci rimettemmo a lavoro […] con una maggiore attenzione […]».[4]
Nel 1933 prende parte alla rifondazione del movimento comunista, un’iniziativa profondamente sostenuta dai giovani livornesi come Renzo Tamberi, Garibaldo Benifei, Otello Frangioni, Marte Corsi, Angiolo Giacomelli. In quel breve periodo, Martelli realizza dei volantini di propaganda e contribuisce alle attività della stampa clandestina.
A nove mesi dalla scarcerazione, il 1° agosto 1933 viene fatto salire su un’automobile in cui lo attendevano tre fascisti. Martelli è tranquillo perché sa che i materiali eversivi del PCd’I sono rimasti a casa sua e viene accompagnato nella sede rionale fascista di Barriera Garibaldi, un luogo tristemente noto per esser teatro di interrogatori e di torture che i fascisti infliggevano agli oppositori politici. Successivamente, viene bendato e portato in una stanza dove ad attenderlo c’è il tenente Gagliano. Il motivo della cattura è il seguente: Gagliano ha scoperto chi è l’autore dei volantini sovversivi, vuole sapere con chi collabora e dove sono custoditi. Il tenente gli mostra i volantini che effettivamente erano stati realizzati da lui e Tamberi, ma Martelli continua a negare tutto.
Gagliano lo invita a spogliarsi ed esamina le sue mani con una lente di ingrandimento. A quel punto, dei giannizzeri iniziano a picchiare violentemente Martelli soprattutto sulle mani, considerate il vero «corpo del reato».[5] Però, la polizia fascista non si limita a interrogare Martelli e decide di indagare su Tamberi. A seguito di diverse indagini compiute nelle settimane precedenti, la polizia fascista aveva scoperto che Martelli e Tamberi collaboravano insieme alla realizzazione dei volantini eversivi.
Quando si consultano delle autobiografie, ciò che sorprende sono sia le emozioni che possono produrre anni dopo sullo stesso lettore, che i minimi dettagli che vengono raccontati. L’Autobiografia di Martelli è un vero e proprio racconto dettagliato di tutte le vicende e le torture subite durante il Ventennio fascista, ma forse non è la minuziosità del racconto a sorprendere un qualsiasi lettore, quanto il pathos che trasmette quando narra le torture subite dagli amici e dai compagni di Partito, i giorni in carcere, la difficoltà a comunicare e a mantenersi in contatto con loro. Durante quell’interrogatorio, Martelli non vedrà mai arrivare Tamberi e crede che l’amico possa aver fatto dei nomi di altri militanti, che possa aver tradito tutti e che sia ceduto davanti alle violenze fasciste. In realtà, Tamberi non verrà interrogato nella sede rionale fascista di Barriera Garibaldi, ma direttamente a casa sua.
Martelli non sa che fare, continua a dire che non era a conoscenza di niente, ma a che scopo? Col passare delle ore e con l’aumento delle percosse subite ha anche egli paura di non farcela, di non saper resistere e di non sapere per quanto potrà mentire. La coercizione fascista era in grado di permeare la psiche di molti giovani e antifascisti che erano stati catturati. Martelli vede l’interrogatorio come una sfida in cui non vuole cedere, anche perché non ha un’altra scelta: deve resistere alla violenza per tutelare non solo l’organizzazione, ma anche i suoi compagni di Partito.
Il militante livornese seppe resistere a quelle brutalità, ma non per questo va raffigurato (e non avrebbe mai voluto definirsi) come “eroe”, piuttosto seppe assolvere le mansioni perché credeva fervidamente a un sistema valoriale basato su libertà e resilienza, così come altri compagni di Partito che cedettero alle violenze. Il raccontare determinati dettagli sulle attività o sulle organizzazioni considerate come eversive, non era sinonimo di “codardia”: non era facile resistere alle violenze e alle percosse che i fascisti infliggevano alle persone col fine di estorcere con mezzi disumani la verità.
L’interrogatorio durò sette ore e l’arrestato venne ripetutamente percosso dal maresciallo Niccoletti, verrà interrogato alla Questura di San Leopoldo e lì vi rimarrà in prigione per diverse settimane. A tre giorni dall’arresto alcuni suoi compagni della stessa organizzazione vengono arrestati e scoprirà che la denuncia era partita dal militante Sirio Vincensini. Vincensini aveva confessato da chi aveva avuto il manifesto originale, ovvero da Garibaldo Benifei che a sua volta aveva fatto il nome di altri militanti. Lo stesso Martelli racconta:
«[…] il Vincensini (un altro militante) informò il fascio che tanto io come il Tamberi quella sera eravamo a stampare, però non sapendo il luogo indusse i fascisti ad attendermi. Preso me, essi pensavano di cavarmi di bocca sia il luogo ove eravamo stati a stampare, come il nome Tamberi, questo per salvare il delatore […]».[6]
Insieme agli altri militanti livornesi, egli promise che avrebbe evitato di compromettere la posizione degli altri compagni, altrimenti il processo sarebbe andato avanti all’infinito.
Il 9 dicembre del 1933 Martelli viene condannato a due anni e cinque mesi di reclusione da scontare alla Casa di pena di Civitavecchia. Il periodo di detenzione non è così duro, a detta di Martelli stesso, perché le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva erano buone, aveva diritto due ore di aria invece che una, e poteva prendere parte a laboratori di scrittura e di traduzione. Questa esperienza costituisce un punto di svolta nella sua formazione politica nella quale potrà sperimentare delle nuove forme di mobilitazione politica ed attività pratiche che non aveva mai testato a Livorno. All’interno della cella stipula delle relazioni con esponenti di spicco come Giovanni Parodi e Pietro Carsano, i quali gli trasmettono i principi fondamentali del comunismo e lo avviano a un vero e proprio percorso di formazione sul comunismo.[7] A Civitavecchia, Martelli studia dalla mattina alla sera ed è sottoposto a una disciplina ferrea, perché «il Partito pretendeva che i giovani fossero preparati nel migliore dei modi».[8] L’obiettivo prefissato dal PCd’I era quello di insegnare varie discipline concernenti il materialismo storico, l’economia politica, la letteratura.
Il capo della cella era Giovanni Parodi, ma vi erano comunque altre celle separate dove vi erano esponenti illustri del Partito. Tra una cella e l’altra avvenivano degli scambi di informazioni grazie alla complicità di alcune guardie carcerarie, le quali si rendevano disponibili allo scambio di «farfalle», ovvero biglietti scritti su cui venivano annotati gli argomenti di discussione da trattare nelle ore di aria.[9]
Nel settembre del 1934 viene scarcerato grazie ad un indulto concesso straordinariamente in seguito alla nascita della prima figlia di Re Maggio, il luogotenente dell’epoca della Casa di pena di Civitavecchia. Martelli sa bene che niente sarebbe stato più come prima, perché non vuole più essere il semplice ragazzo che diffonde volantini eversivi ed ha capito che per rovesciare il regime è necessario agire diversamente.
Nel febbraio del 1935 il padre muore e deve far fronte a una difficile situazione economico-finanziaria che travolge tutta la famiglia, tenta più volte di poter far rientro ma senza successo. Dapprima viene mandato al settantacinquesimo di Fanteria di Siracusa, un reggimento di disciplina composto dai criminali più disparati (ladri, stupratori, pochi antifascisti e qualche renitente alla leva) e poi viene assegnato alla scuola di Allievi Ufficiali.[10] In quel breve periodo cerca più volte di tornare a Livorno dai suoi cari, ma senza successo. Nei suoi tentativi di rientrare a casa viene ostacolato perché non aveva completato i corsi premilitari in età adolescenziale che soltanto gli avrebbero permesso di tornare nella città di residenza. Il 5 marzo dello stesso anno viene inserito nel corpo di spedizione in partenza per l’Africa Orientale, per l’Abissinia. Secondo il figlio, Walter Martelli, la sua esperienza nella Guerra in Africa Orientale non fu completamente negativa per il padre, in quanto non prese parte a delle iniziative militari e riuscì a stabilire delle buone relazioni con gli abitanti del luogo.[11] Martelli ha raccontato ai suoi figli di aver diffuso nei villaggi dei consigli medici e delle nozioni generali per migliorare le condizioni igienico-sanitarie.
Al suo rientro a Livorno, avvenuto nel 1936, molte cose erano cambiate. Alla fine del 1936 venne assunto presso i Cantieri Orlando, un’esperienza positiva che l’autore definì come una «grande conquista».[12] Lo stabilimento racchiudeva la storia del movimento operaio antifascista livornese e, per queste ragioni, riuscì a mettersi nuovamente in contatto con i compagni antifascisti che aveva conosciuto durante la clandestinità. La rete dei rapporti tra i militanti comunisti venne prima stabilita all’interno del cantiere e poi estesa al di fuori, ed era retta proprio dallo stesso Martelli.
A livello nazionale, il PCd’I abbandonò il precedente carattere settario che negli anni precedenti aveva portato il movimento ad isolarsi rispetto alle iniziative di altri partiti antifascisti. Tra il 1934 e il 1938 venne creato un Fronte popolare, in cui erano riunite tutte le forze politiche in aperta opposizione al regime. Questa fu anche la fase in cui i due partiti operai – il Partito Socialista e il Partito Comunista – ripristinarono delle forme di dialogo e di collaborazione dopo anni di scissione, culminate con la stesura di un patto di unità di azione nel 1934.
A livello locale, la Federazione livornese si ricostituì con esponenti di spicco e di varia provenienza come militanti storici, intellettuali, teorici, professori, figure pubbliche e notorie della comunità labronica. Un lieve passo avanti che venne messo di nuovo a dura prova da un’ondata di arresti senza precedenti.[13] Grazie alla rete di relazioni che Martelli aveva edificato ai Cantieri Orlando col militante comunista Mario Galli, l’organizzazione potè stabilire delle relazioni con intellettuali del calibro di Vittorio Marchi, Antonio Maccaroni, Aldo Balducci, Giorgio Stoppa. Le riunioni del nuovo partito si tenevano presso la casa dell’intellettuale Umberto Comi ed affrontavano temi svariati, come il rapporto tra il fascismo e la guerra, la Germania nazista, l’utilizzo della cultura e degli ideali comunisti come unica soluzione davanti alla violenza.[14] Mentre, Martelli e altri esponenti di partito che avevano vissuto direttamente sulla loro pelle la condizione proletaria, si facevano portavoce di altre tematiche, come i problemi della fabbrica e dello sfruttamento dei lavoratori.
Martelli non condivideva la nuova struttura della Federazione perché «nonostante i nuovi componenti si dichiarassero comunisti erano ben lungi dall’esserlo».[15] Secondo il militante di adozione livornese, gli ideali che quest’ultimi condividevano erano ideali social-liberali e poco affini ai principi marxisti-leninisti. Inoltre, a suo giudizio, esisteva una profonda differenza tra chi studiava il marxismo dalla cattedra e chi conosceva il marxismo perché apparteneva alla classe operaia.
Nel 1939 non gli viene riconosciuto più l’esonero dalla leva, riconosciutogli nel 1935 in quanto orfano di padre e unico capofamiglia, ed è per questo motivo che lascia il suo impiego ai Cantieri Orlando. L’ingegnere Bechi, all’epoca direttore dei Cantieri Orlando, si oppone al suo trasferimento inviando una lettera alla Questura di Livorno, ma senza successo. Inizia quindi a lavorare per un’azienda che produceva bombe a mano a Fiume, nota come Motofides. Durante quel periodo lavora alla realizzazione dell’Incrociatore San Giorgio, prende parte ad azioni di insubordinazione dalla catena di montaggio e viene licenziato nel 1942, perché considerato politicamente pericoloso.
Nel 1943 viene mandato a Torino alla Caserma Marmora ma, in seguito ai bombardamenti, viene mandato a Massa Marittima, una città in provincia di Grosseto. In quel piccolo centro rafforza il proprio legame con altri militanti comunisti locali e lì vi rimane fino alla ratificazione dell’Armistizio di Cassibile. Grazie all’aiuto di un militante locale, riesce a scappare dalla città grossetana e a raggiungere la famiglia sfollata ai Bagni di Casciana, dove si trovava anche sua moglie insieme alla sua famiglia. Si unisce alle formazioni partigiane locali nate dopo l’8 settembre e fa parte del Partito del Comitato militare ed ha come compito quello di organizzare i vari nuclei di partigiani della zona prima dell’arrivo del fronte di liberazione.[16]
NOTE
[1] Martelli G., Autobiografia, cit., p. 2.
[2] Il Soccorso rosso, noto anche come “Soccorso rosso internazionale per i combattenti della rivoluzione” in sigla MOPR, è stata un’organizzazione internazionale legata all’Internazionale Comunista con il compito di fornire supporto ai prigionieri comunisti e alle loro famiglie. Il Soccorso rosso è rimasto attivo tra gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale e condusse campagne di solidarietà sociale, di supporto materiale e umanitario, a sostegno dei prigionieri comunisti.
[3] Martelli G., Autobiografia, cit., p. 2.
[4] Tredici M., L’inchiesta, la spia, il compromesso. Livorno 1935: processo ai comunisti. Livorno: Media Print, 2020, p. 346.
[5] Come compare sul dizionario Treccani, originariamente il giannizzero era un soldato di un corpo scelto di truppe a piedi dell’impero Ottomano, spesso adibito alla guardia del corpo del sultano. Nel periodo fascista si indicavano invece tutte quelle persone al servizio di qualche personaggio illustre della milizia fascista. Ma lo stesso termine può anche esser usato in senso dispregiativo per indicare uno scagnozzo o tirapiedi, forse questo è il significato a cui fa riferimento Martelli nella sua Autobiografia. La citazione compare in: Martelli G., Autobiografia, cit., p. 4.
[6] Martelli G., Autobiografia, cit., p. 6.
[7] Giovanni Parodi (1889-1962) nasce in una famiglia operaia e diventa ben presto militante del PCd’I, viene arrestato nel 1927 dal Tribunale Speciale Fascista e gode dell’amnistia nel 1937. Fugge in Francia nel 1940 e viene arrestato l’anno successivo. Fortunatamente riesce ad evadere e a continuare il lavoro politico clandestino, nel dopoguerra fu membro del Comitato centrale del Partito Comunista Italiano e Segretario generale della Federazione Italiana Operai Metallurgici (in sigla, FIOM).
Giovanni Carsano (1891-1965): inizialmente operaio torinese, aderisce al PCd’I e partecipa al biennio rosso. Come Parodi viene arrestato nel 1927 e rilasciato dopo dieci anni, viene mandato al confino nel 1943 dove rimane fino alla liberazione. Dopo la guerra lavora presso i sindacati dei pensionati e presso l’Unione internazionale dei sindacati dell’Alimentazione.
[8] Tredici M., L’inchiesta, la spia, il compromesso, cit., p. 349.
[9] Ibidem.
[10] Tredici M., L’inchiesta, la spia, il compromesso, cit., p. 350.
[11] Intervista dell’autrice a Walter Martelli, svoltasi il 2 aprile 2024 presso l’abitazione di quest’ultimo a Livorno.
[12] Tredici M., L’inchiesta, la spia, il compromesso, cit., p. 350.
[13] Tra gli esponenti di spicco vengono arrestati Garibaldo Benifei e Aramis Guelfi.
Aramis Guelfi (1905-1977): inizialmente maestro d’ascia, viene condannato nel 1939 dal Tribunale speciale a scontare quattro anni di reclusione. Viene liberato anch’egli con l’Armistizio dell’8 settembre, ma continua a combattere nella zona di Volterra. Diventa esponente di spicco del Partito Comunista livornese, per poi aderire nel 1963 al Partito Socialista Democratico.
[14] Umberto Comi era vicedirettore del giornale fascista “Sentinella Fascista” e spesso scriveva articoli non proprio conformi all’ideologia fascista, ma erano spesso difficili da decifrare nei loro contenuti e, proprio per la sua adesione al Partito, si crearono delle divisioni all’interno del movimento.
[15] Martelli G., Autobiografia, cit., p. 9.
[16] L’area sottoposta al controllo di Giovanni Martelli è relativamente grande e comprendeva molte piccole città della provincia di Pisa, come: Lari, Cascina, Crespina, Terricciola, Chianni, Peccioli.
Articolo pubblicato nel maggio 2024.