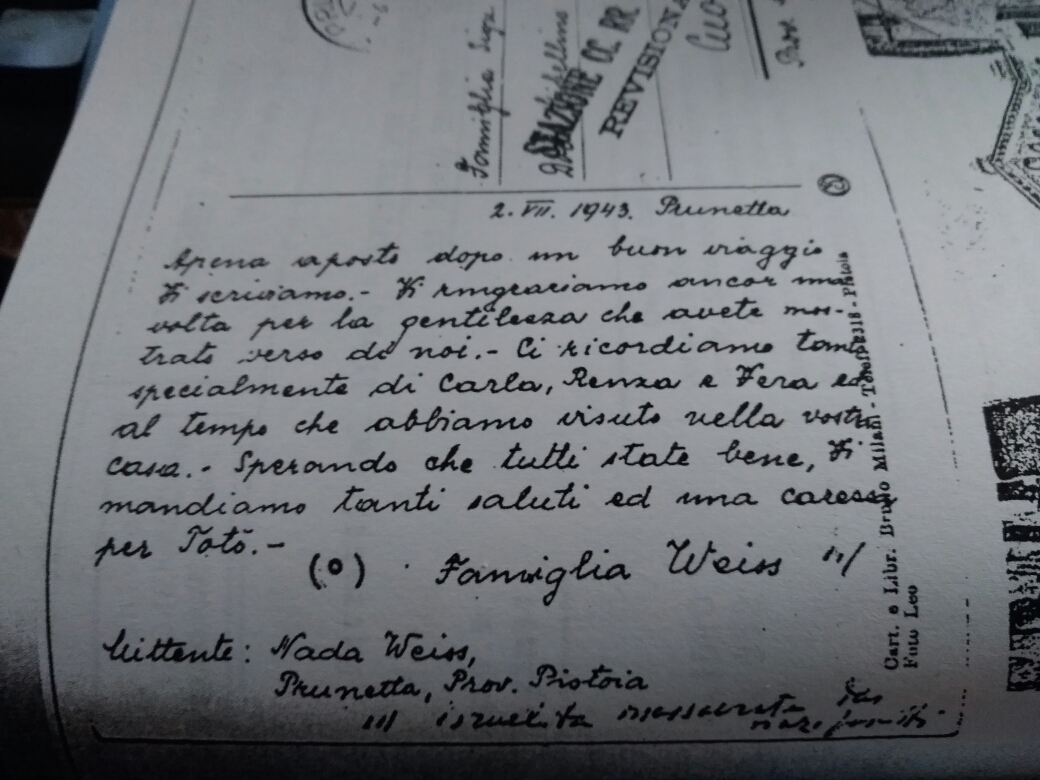San Francesco “made in Pistoia”

Chi volesse conoscere la storia di San Francesco d’Assisi attraverso dei film non ha che l’imbarazzo della scelta: “Francesco giullare di Dio” di Rossellini e “Fratello Sole, sorella Luna” di Zeffirelli sono sicuramente fra i più famosi. L’ultima trasposizione cinematografica risale al 2016, si intitola “Il sogno di Francesco” ed ha come protagonista il giovane Elio Germano.
Pochi sanno che ancora prima prima che il celebre regista pistoiese Bolognini calcasse le scene, provò a raccontare la vita del santo in un film muto anche il suo concittadino Mario Corsi.
Questi, che in gioventù era stato anche autore di alcune raccolte di poesie, una volta tornato parzialmente invalido dalla prima guerra mondiale, era stato attirato dalla nascente industria cinematografica. Come lo stesso Corsi ricordava: “…Anch’io mi sentii attratto, come parecchi altri scrittori e giornalisti dal cinematografo e per due anni scrissi scenari su scenari, alcuni dei quali ebbero una certa fortuna“.
Sull’onda dei primi successi il giovane pistoiese venne chiamato dal commediografo Ugo Folena e dall’avvocato e critico musicale Eugenio Sacerdoti per realizzare un film sul santo d’Assisi che, era chiaro sin dall’inizio, per ottenere il bene placet della Chiesa doveva essere “storicamente e religiosamente inattaccabile“.
Felice per la proposta Corsi si mise immediatamente al lavoro consultando in poche settimane l’intera bibliografia francescana ed in modo particolare i Fioretti e gli scritti di frà Leone e frà Celoro. Comprese subito che le difficoltà incontrate sarebbero state enormi. Anni dopo Corsi sosteneva infatti che: “Solo allora compresi a quale impresa ardita e pericolosa m’ero impegnato e mi tornarono allora in mente le parole dette qualche anno prima da Ferdinando Martini, in una conferenza, a proposito della Francesca da Rimini di D’Annunzio: “A cercare di elevarsi fino a così alte figurazioni, come quella cantata nel sommo Poeta, c’è da correre il rischio di ruzzolare molto in basso“.
Superata la paura iniziale il giovane cineasta si diede da fare per illustrare la vita del Santo attraverso alcuni episodi storici (Il bacio del lebbroso, Sulle orme del poverello d’Assisi, Il tempo, Le stigmate) capaci di rappresentare anche il suo progressivo distacco dalle cose del mondo.
Gli interpreti principali del film furono individuati nell’attore drammatico Uberto Palmarini (san Francesco), Silvia Malinverni (Chiara degli Scifi), Rina Calabria, nel ruolo di sua sorella Agnese, la ballerina Lucienne Myosa, nella parte di una cortigiana che si pente, Bruno Emanuel Palmi, in quella di Frate Elia. Accanto agli attori professionisti apparvero nel film come comparse dei frati francescani. Le riprese furono effettuate fra Assisi, Gubbio, Perugia e il lago Trasimeno.
“Per almeno un mese“, raccontava lo stesso regista, “Assisi e Gubbio offrirono il più bizzarro degli spettacoli, tra la viva e chiassosa curiosità degli abitanti e ancor più dei forestieri, che si stropicciavano sbalorditi gli occhi nel veder passare per le strade e le piazze ed entrare ed uscire dai templi inaspettati personaggi in costumi pittoreschi del 1200, e suore e fraticelli al braccio di soldatacci di ventura…”. I “veri” francescani e le suore di santa Chiara aiutarono la troupe fornendo anche alcuni paramenti sacri per le riprese. Le suore di clausura, visto che faceva molto caldo, fecero distribuire agli attori delle bevande fresche e dei biscotti.
Una volta ultimata l’opera fu presentata il 7 giugno 1918 in prima visione all’Augusteo di Roma come “restituzione francescana in quattro canti di M. Corsi con poema sacro per orchestra e cori (dal vivo nda) di Luigi Mancinelli“. L’elemento caratteristico della realizzazione fu senza dubbio il ruolo giocato dalla musica. Per la prima volta questa entrava in un film come elemento integrativo. Mentre nel primo grande film religioso realizzato in Italia, “Christus”, la musica si era aggiunta alla parte cinematografica, accompagnandola come un commento, nel Frate Sole divenne parte essenziale dello spettacolo. Il film, scrisse in un lungo articolo il critico Gasco, “segna indubbiamente una data nell’evoluzione del poema musicale cinematografico, al quale arriderà forse un avvenire mirifico“.
La proiezione fu un vero e proprio evento ed ebbe come spettatori Principi di casa Savoia, ministri del Regno, prelati della Santa Sede, intellettuali. Il regista annotava con fierezza: “Ricordo che dopo la proiezione i Cardinali e gli altri eminenti Monsignori vollero esprimere il loro vivo compiacimento al maestro Mancinelli, a Ugo Falena e a me, e dissero che dal cinematografo la Chiesa poteva aspettarsi, come l’Arte, grandi nobilissime cose”.
A coronare il successo di Frate Sole arrivò poco dopo il riconoscimento ufficiale del Vaticano, con una rappresentazione del film nell’aula magna del Palazzo della Cancelleria, davanti ad una decina di Cardinali e a molti Arcivescovi, Prelati e dignitari della Corte pontificia.
Il successo del film e della musica furono, anche al di fuori dell’ambito religioso, grandissimi. La stampa italiana, che ancora non si occupava di film se non come pubblicità a pagamento, fece uno strappo alla regola e dedicò a Frate Sole colonne intere, firmate dai maggiori critici.
In “La Cine-Gazetta” del maggio 1918 così si scriveva dell’opera: “La Tespi-film, la giovane e celebrata casa romana, e per essa Eugenio Sacerdoti (…), mettendo in scena ‘Frate Sole’, grandiosa vicenda francescana, non soltanto ha inteso di portare il suo prezioso contributo alla propaganda degli studi francescani che tanto interessano l’intellettualità internazionale, ma ha voluto dimostrare a quali altezze possa assurgere la cinematografia considerata espressione di arte (…). Ispirandosi a questi concetti di assoluta nobiltà, (…) Mario Corsi, ideando e tratteggiando il suo scenario, ha compiuto un vero e proprio poema drammatico. Infatti, se ‘Frate Sole’, per le sue linee generali, semplici e gradiose, per obiettiva e serena ricostruzione della figura del ‘poverello d’Assisi’, per la rievocazione dei momenti più salienti della sua vita, per aver saputo quei momenti inquadrare con occhio accorto e vivace nell’ambiente tumultuoso del Duecento, vivifica una schietta e suggestiva restituzione francescana, s’eleva a vera dignità di poesia per aver saputo costringere, nel relativo breve spazio di tempo di uno spettacolo, senza diminuirlo, anzi rendendolo chiaro e tangibile, il senso divino dell’idea francescana (..)” .
Frate Sole a distanza di diversi decenni dalla sua ultima rappresentazione è riapparso oggi sul grande schermo grazie al restauro compiuto dalla Fondazione Cineteca Italiana. Nel mese di febbraio è stato rappresentato a Foligno, nell’ambito del progetto “Visioni e musica per San Francesco” realizzato dagli Amici della Musica di Foligno, con l’esecuzione delle musiche al piano da parte del maestro Scolastra e come coro le 120 voci del Corale Frate Sole diretto dal maestro Aldo Cicconofri. Un film, a distanza di più di cento anni dalla sua realizzazione ancora godibile, che meriterebbe di essere riproposto nella città che ha dato i natali al regista.