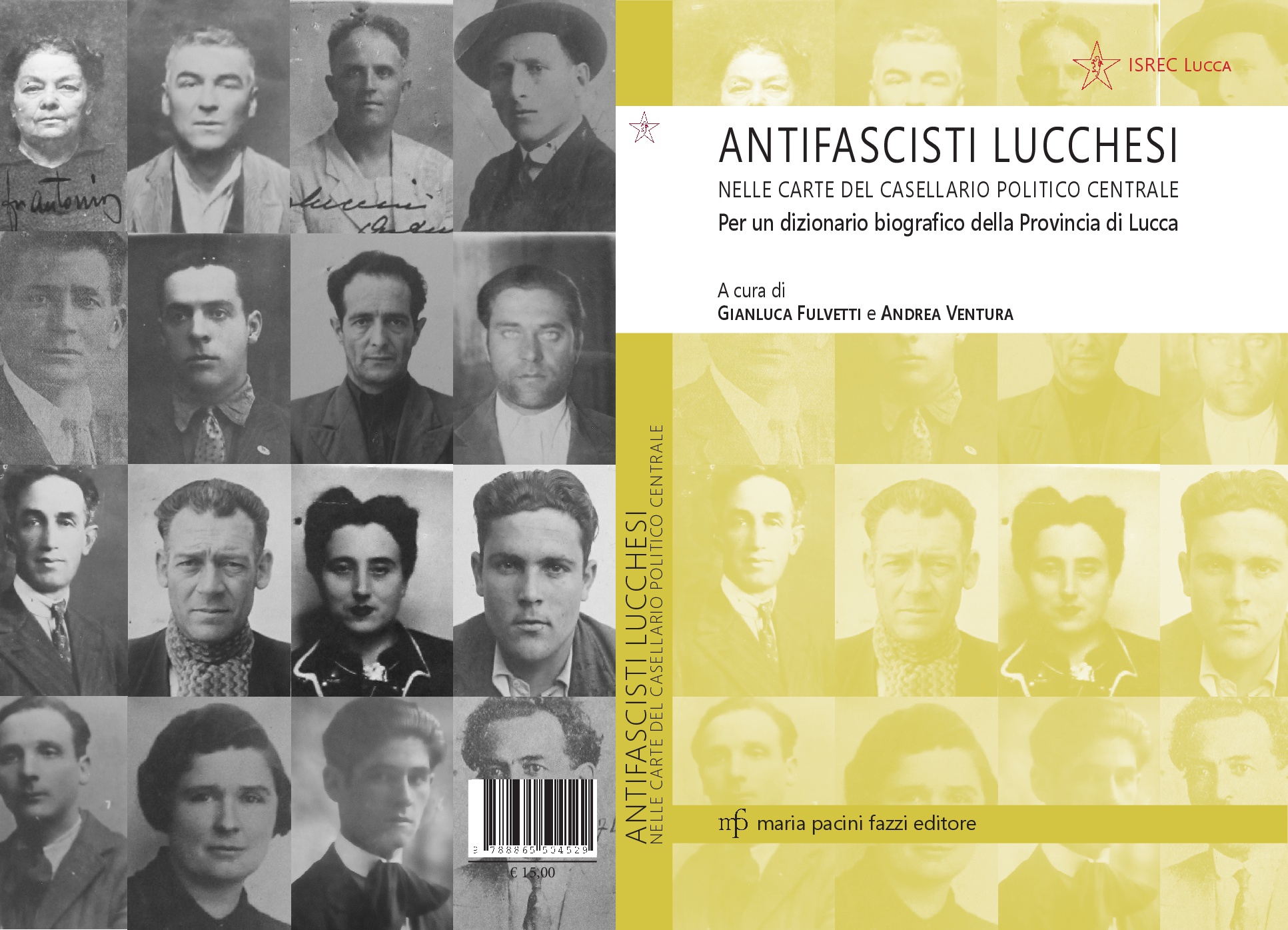Mohicani all’ombra delle mura: la Democrazia proletaria lucchese dal “Manifesto” all’89

A partire dalla fine degli anni ’60, a sinistra del Pci – anche sull’onda delle esperienze movimentiste del ’68 – nascono numerose formazioni politiche di ispirazione marxista, da Lotta continua a Potere operaio passando per il Manifesto (nato proprio da una corrente interna del Partito comunista), il PdUP e Avanguardia operaia: decine di sigle e un tratto in comune ben preciso, la critica al Partito comunista – colpevole agli occhi di alcuni militanti e simpatizzanti più giovani, molti dei quali provenienti da ambienti universitari, di aver abbandonato qualsiasi strategia rivoluzionaria1 – e di conseguenza all’Unione sovietica e ai regimi del blocco socialista in Europa orientale, accusati di essere paesi capitalisti mascherati da “falso socialismo”2 e scalzati nell’immaginario collettivo dai miti di Che Guevara e della Cina maoista.
Fra tante formazioni, una in particolare spicca per l’originalità dei contenuti e della proposta politica (che nel corso degli anni si configurerà sempre più come una sintesi di pacifismo, ambientalismo, marxismo libertario e cattolicesimo progressista), un partito – o meglio un cartello elettorale, almeno nei suoi primissimi anni di attività a partire dalla fondazione nel 1975 – che riunisce vari soggetti dell’area della sinistra rivoluzionaria (PdUP, AO, Movimento lavoratori per il socialismo e altri gruppi minori): è Democrazia proletaria, “uno strano gruppo di protocristiani” (così l’avrebbe definita nel 1987 l’attore Paolo Villaggio, allora candidato nelle liste di Dp3) che nel corso dei suoi circa sedici anni di vita fino alla confluenza in Rifondazione comunista avrebbe costituito la principale forza politica a sinistra del Pci.
Anche a Lucca – “città bianca” per eccellenza nella rossa Toscana – la tribù dei “mohicani”4 demoproletari riesce a piantare le proprie tende: una “piccola comunità” – così la descrive Eugenio Baronti – “di militanti superattivi, preparati, colti; alti livelli di scolarizzazione, elevata qualità del dibattito e del confronto politico”, quasi il partito di una élite intellettuale – nonostante l’obiettivo prefissato della costruzione di un partito di massa5. Fra loro c’è Gian Paolo Marcucci, allora giovane studente e militante della sinistra marxista, già vicino al locale circolo del Manifesto, assieme al quale abbiamo ripercorso alcune delle tappe più significative della storia di Dp a Lucca.
Quando ti sei avvicinato a Democrazia proletaria? Avevi già militato in precedenza in altri partiti o movimenti?
Sì, a 17 anni , nel 1971, proprio in concomitanza con l’uscita dell’omonimo quotidiano, mi avvicinai al circolo locale de Il Manifesto. Iniziai praticamente con la diffusione del giornale davanti alla scuola – Istituto magistrale – che frequentavo a Lucca. In seguito, dopo il mancato successo elettorale del 1972 iniziò il progetto di unificazione con i compagni dello Psiup che avevano deciso di non confluire nel Pci o nel Psi e che insieme ai compagni del Movimento politico dei lavoratori (cattolici di sinistra) avevano dato vita al PdUP. Se nel gruppo lucchese del Manifesto vi erano prevalentemente studenti e insegnanti, nel Pdup vi era una discreta presenza operaia di quadri di fabbrica.
Nel 1975, si arrivò all’unificazione e nacque il Partito di unità proletaria per il comunismo, fra i cui esponenti maggiori erano Lucio Magri, Vittorio Foa e Rossana Rossanda. Nel frattempo si era aperto un dialogo con altre formazioni della sinistra extraparlamentare, come Avanguardia operaia e il Movimento studentesco di Mario Capanna, che ebbero come primo risultato la presentazione alle elezioni amministrative del 1975 di liste denominate “Democrazia proletaria” in alcune regioni. In Lombardia , dove il successo fu più marcato fu eletto consigliere Capanna. In Toscana fu presentata la lista Pdup per il comunismo ma intanto, a livello locale, iniziarono gli incontri con AO e con la Lega dei comunisti, altra organizzazione con un certo radicamento in regione.
Nel 1976, in occasione delle elezioni politiche anticipate, dopo travagliati tira e molla si arrivò ad un cartello elettorale (da non confondere con il futuro partito) ribattezzato “Democrazia proletaria”, che raggruppava le tre forze più consistenti alla sinistra del Pci: Pdup, AO e Lotta continua. C’era l’auspicio da un lato del sorpasso della Dc da parte del Pci e di una tenuta del Partito socialista, dall’altro di un buon successo delle forze della nuova sinistra, riuscendo a superare il 50% del consenso elettorale in modo da rendere possibile la formazione di un governo di sinistra, nonostante la politica indirizzata al compromesso storico dei comunisti.
Perché proprio Dp e non il Pci, allora la principale forza politica a sinistra? Cosa differenziava Democrazia proletaria dal Partito comunista “ufficiale”?
C’era la convinzione della “rivoluzione dietro l’angolo”, considerati gli eventi che in parte si intrecciavano sul piano nazionale e internazionale: la resistenza del popolo vietnamita, Cuba e i fermenti in America latina, le lotte di liberazione anticoloniali in Africa, le ribellioni studentesche e le lotte operaie in tutta Europa – sia a est che ad ovest – e per ultimo la caduta del fascismo in Portogallo ad opera dei militari democratici; parafrasando Dylan, i tempi stavano cambiando. E così avveniva anche in Italia dove il Partito comunista sicuramente dava un fondamentale contributo dall’opposizione con la sua forza istituzionale, supportando di fatto anche i socialisti nel contraltare governativo rispetto alla Dc, all’attuarsi delle riforme in questo periodo. Non convinceva però, soprattutto alla luce della strategia della tensione – portata avanti da gangli importanti della Dc unitamente a servizi segreti ed estrema destra per bloccare le conquiste del movimento operaio e studentesco – la proposta del compromesso storico. Fra l’altro in quegli anni era emersa una piccola ma significativa area militante di cattolici di sinistra che respingeva il collateralismo con la Dc come partito dei cattolici.
Per questi motivi, nonostante i risultati elettorali del 1976 fossero stati al di sotto della aspettative per le sinistre, l’ipotesi su cui intendeva muoversi il Partito comunista non mi convinceva, tanto più quanto all’allontanamento da Mosca non corrispondeva una posizione di autonomia e non allineamento, bensì si accettava la protezione dell”ombrello della Nato”. Quando poi nel corso dell’estate del ’76 fu varato il governo monocolore democristiano di Andreotti con l’astensione del Pci, fu chiara la direzione che stava prendendo quest’ultimo e che avrebbe poi indebolito le lotte sindacali e ridato ossigeno alla Dc in difficoltà. Fu per questo che, pur nel subbuglio creato dalla delusione elettorale che portò a scissioni e abbandoni della politica, e nonostante a livello nazionale come a Lucca la componente Manifesto conservasse il marchio Pdup per il comunismo, personalmente aderii al processo di formazione di Democrazia proletaria che tenne il suo primo congresso due anni dopo, nel 1978, in un clima fortemente deteriorato a causa del terrorismo brigatista e delle politiche securitarie appoggiate anche dal Pci. Democrazia Proletaria chiaramente non riteneva più la rivoluzione dietro l’angolo, però non si rassegnava né alle scorciatoie della lotta armata né al blocco delle rivendicazioni operaie.
Chi sono i principali esponenti di Democrazia proletaria a Lucca? Quali sono le loro storie politiche?
Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare una distinzione fra le tre fasi della vita di Dp a Lucca e nel paese. La prima è quella che va dalla sua costituzione fino alla debacle elettorale con il cartello Nuova sinistra unita (1975/1979) ; la seconda fase, dalla ricostruzione dalle macerie fino al rientro in Parlamento (1980/1983); la terza, che passando per la scissione dei Verdi arcobaleno arriva fino allo scioglimento di Dp (1983/1991). Del primo periodo ricordo soprattutto Gildo Tognetti, già dirigente di rilievo nello Psiup a livello nazionale, che poi si allontanerà nell’80. Altri compagni furono Claudio Orsi, già dirigente sindacale lucchese, proveniente da AO che resterà attivo fino alle elezioni dell’83; poi Eugenio Baronti e Danilo Ascareggi (ex Lega dei comunisti), Marcello Nelli (ex Pdup e Acli) e, dalla valle del Serchio, Leonardo Mazzei e Mario Regoli (ex Stella rossa se non sbaglio); tutti resteranno più o meno in Dp fino alla fine, confluendo in Rifondazione.
La terza fase fu quella di maggiore espansione in termini di iscritti e militanti: soprattutto dopo le amministrative del 1985, in cui ottenemmo un buon risultato – considerando le nostre forze – livello locale (un consigliere provinciale e un consigliere nella circoscrizione Lucca-Centro) entrarono compagni storici del movimento lucchese del ’68, come Francesco Giuntoli, Daniele Squaglia, Virginio Monti, Tommaso Panigada e Luca Franceschi, oltre ad altri compagni e compagne (seppur poche purtroppo) più giovani.
Dp è sempre stata molto critica verso l’Urss e i paesi del “socialismo reale”. In cosa consisteva questa critica?
Personalmente a 14 anni, pur orientato vagamente a sinistra ho dovuto fare i conti – oltre che con la guerra del Vietnam e la sfortunata impresa del Che in Bolivia – con la Primavera di Praga e la sua repressione ad opera del Patto di Varsavia. Quindi fra il difendere a spada tratta la “Patria del Comunismo” anche quando andava contro altre esperienze che pure non rinnegavano il socialismo, e sposare tesi che bollavano come totalitario a prescindere il pensiero comunista, ho dovuto cercare progressivamente di approfondire le ragioni di questa deriva autoritaria dei sistemi socialisti e delle possibili alternative senza rassegnarsi al “migliore dei mondi possibili” rappresentato dal capitalismo. Anche per questo avevo aderito al Manifesto e mi trovai a mio agio in Dp. Fra le critiche maggiori al socialismo reale, pur riconoscendone la capacità di assicurare – a differenza dell’Occidente e dei paesi in via di sviluppo sotto il suo tallone – la soddisfazione generalizzata dei bisogni primari (sanità, occupazione, istruzione), era l’identificazione fra Partito e Stato, la burocratizzazione dei rapporti sociali, la mortificazione delle spinte dal basso, la bollatura di ogni dissenso come complotto e infine un’organizzazione del lavoro che non si discostava nei meccanismi fondamentali da quella alienante capitalistica. Per non parlare delle purghe staliniane e del sistema dei gulag, sebbene l’Occidente stesso – che favoriva i golpe in Grecia e America Latina, sosteneva il Franchismo spagnolo e la strategia della tensione in Italia – non fosse da meno.
Nel 1989 cade il muro di Berlino, e da lì a pochi anni scompare la stessa Unione sovietica. Quali furono le reazioni dentro la Democrazia proletaria lucchese?
Riprendendo quanto detto sopra, c’era stata una certa attenzione da parte di Dp verso l’area del dissenso all’Est (ricordo un numero di “Unità Proletaria” dei primi anni ’80 dedicato a Solidarnosc e, se ben rammento, la candidatura del dissidente polacco Wlodek Goldkorn alle elezioni europee dell’89), ed anche sulla repressione di piazza Tienanmen ci fu sconcerto. In merito al crollo del muro di Berlino non ricordo le posizioni del partito (ma sicuramente ve ne furono, in questo caso fallano le mie memorie); personalmente vidi con favore ciò che avveniva, sperai che l’esito fosse una liberazione del socialismo dalla cappa burocratica in cui era stato ingabbiato, senza – come è successo – cadere dalla padella nella brace di una riunificazione delle due Germanie all’insegna di una sorta di colonizzazione neoliberista. Ciò purtroppo è avvenuto in varie forme in tutti i paesi dell’Est, dove spesso una parte della vecchia classe dirigente “comunista” si è riciclata per governare la nuova situazione.
Il 1989 è anche l’anno della “svolta della Bolognina” e dell’avvio di quel processo che porterà alla trasformazione del Pci in Partito democratico della sinistra (Pds). Questa scelta suscita stupore all’interno di Dp?
Diciamo parzialmente stupiti (perlomeno nel mio caso) non tanto perché non vedessimo una certa mutazione genetica avvenuta nel tempo (da anni parlavamo di “socialdemocratizzazione”) soprattutto in parte del gruppo dirigente del Pci, quanto per la decisione di scioglierlo cambiando il nome. Se dopo a fuoriuscirne oltre agli ingraiani furono i cossuttiani, pareva che i più dipendenti dal filosovietismo non fossero questi ultimi ma proprio chi voleva rimuovere la parola “comunista” dal nome. Come a dire: la fine dell’esperienza sovietica equivale alla fine del comunismo stesso, dunque si cambia nome. Chiaramente iniziò ad esserci attenzione nei confronti di chi dissentiva da quella scelta; fra l’altro Dp aveva già subito l’uscita di Capanna (che aderisce ai Verdi), Ronchi Tamino, Franco Russo (metà del gruppo parlamentare) e Molinari con loro vari consiglieri amministrativi, per cui l’eventualità di nuove aggregazioni poteva essere benvenuta.
A distanza di pochi anni dalla fine del Pci, anche la storia di Democrazia proletaria giunge al termine: nel 1991 infatti il partito confluisce nella neonata Rifondazione comunista. Quale strada scegliesti allora, e perché? Quale fu il dibattito sul territorio circa l’adesione al Prc?
Praticamente, se nel 1989 eravamo riusciti alle Europee a confermare un deputato – Eugenio Melandri – la scissione dell’area interna verde, che aderì alla lista Verdi Arcobaleno, indebolì l’immagine del partito sebbene, esclusi i non pochi rappresentanti nelle istituzioni, la maggior parte del corpo militante fosse rimasto in Dp. Anche a Lucca fu così: a livello provinciale uscirono soprattutto i viareggini. Comunque il dato nuovo della formazione, sul finire del 1990 del Movimento per la Rifondazione comunista riaccese -pur fra i dubbi- le speranze per una nuova aggregazione . Ricordo una manifestazione a Camp Derby nel febbraio-marzo 1991, contro la Prima guerra del Golfo ancora in corso, cui parteciparono anche loro. Io, come la grande maggioranza degli iscritti lucchesi, decisi di aderire al Movimento (non ancora partito). Mi ricordo che la prima sede era una stanzetta, a Lucca, in Via Santa Chiara e la prima riunione cui partecipai mi sembra fu nell’autunno del ’91: le perplessità riguardavano soprattutto il rapporto con l’area cossuttiana (considerando le posizioni critiche sul socialismo reale) ma trovammo comunque abbastanza disponibilità, ho un buon ricordo dei primi anni. Per circa tre anni continuammo però a tenere la sede che avevamo in Via Fillungo, trasformandola in una piccola casa della sinistra, il “Circolo Utopia”.
1Critiche nei confronti della progressiva “istituzionalizzazione” del Pci erano già emerse in seno al partito stesso nel corso degli anni ’50, ad esempio con Pietro Secchia (vedi anche Vittoria, A., Storia del Pci, 1921-1991, Carocci, Roma 2007); l’episodio più emblematico resta però quello che vide protagonisti Adriano Sofri e Gian Mario Cazzaniga nel marzo 1964 alla Scuola Normale di Pisa, che contestarono a Palmiro Togliatti la mancata presa del potere rivoluzionaria in Italia nell’immediato dopoguerra, nonché il voto favorevole del Pci all’articolo 7 della Costituzione, che recepiva i Patti Lateranensi del ’29 (vedi anche Meucci, G., “Dalle aule alle piazze”, in Meucci G., Renzoni S., Il Sessantotto. Immagini di una stagione pisana, Pacini, Pisa 2017, pp. 39)
2Così un verso de “L’ora del fucile” (1971), del Canzoniere pisano: “In Spagna e in Polonia gli operai | dimostran che la lotta non si è fermata mai | contro i padroni uniti, contro il capitalismo | anche se mascherato da un falso socialismo. | Gli operai polacchi che hanno scioperato | gridavano in corteo: Polizia Gestapo! | Gridavano: Gomulka, per te finisce male! | Marciavano cantando l’Internazionale!” (vedi anche https://www.ildeposito.org/canti/lora-del-fucile)
4Il riferimento è al titolo del libro di Pucciarelli, M., Gli ultimi mohicani. Una storia di Democrazia proletaria, edito da Alegre nel 2011.
5Baronti, E., Con il piombo sulle ali, EDL, Lucca 2011, pp. 46-47; Eugenio Baronti (1954) ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale di Dp dal 1980, dopo esserne stato uno dei fondatori; nel 1991 aderisce al Prc, prima di uscire dal partito nel 2010; è stato anche consigliere comunale e assessore all’ambiente nel comune di Capannori.