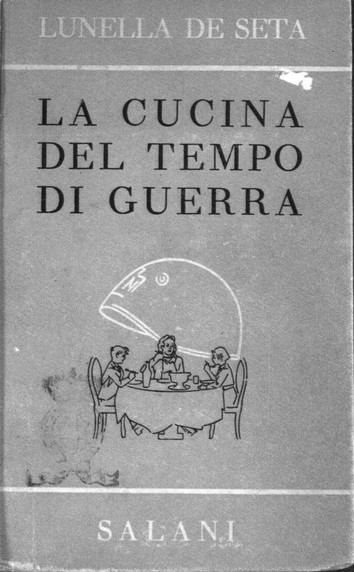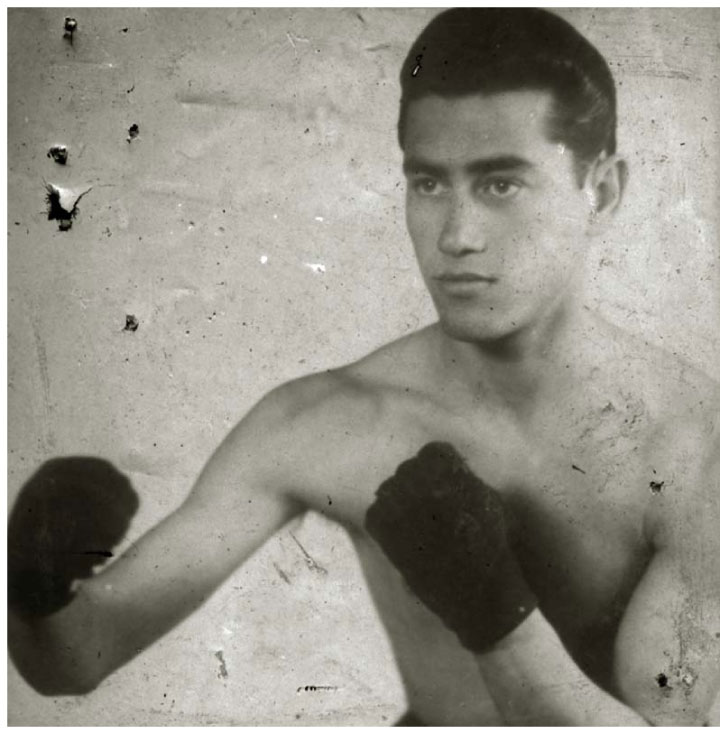Un secolo ed un architetto: Giovanni Michelucci

Il 7 aprile 2014 siamo giunti alla terza presentazione del documentario, sottotitolato in inglese, Giovanni Michelucci. Elementi di vita e di città, regia di Cristiano Coppi, al Cinema Odeon di Firenze realizzato con la Provincia di Pistoia la Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole con il contributo della Regione Toscana e in quest’occasione con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in collaborazione con l’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura DIDA/Festival Internazionale di Architettura in video MEDIARC.
Le precedenti presentazioni erano state al cinema Globo di Pistoia nel dicembre 2012 e al Museo MAXXI di Roma nel maggio 2012.
Il documentario racconta i cento anni vissuti da Giovanni Michelucci e i momenti che hanno segnato la sua vita di uomo e di architetto. Attraverso filmati dell’epoca, riprese delle sue opere più importanti e interviste, il documentario vuole descrivere la complessità ed il fascino di un personaggio di cui tanto si è scritto ma che ancora oggi conserva molti aspetti da esplorare. Collaboratori, architetti e storici dell’architettura, come Claudia Conforti, Paolo Portoghesi, Corrado Marcetti, Mauro Innocenti, Marco Dezzi Bardeschi, Francesco Dal Co, solo per fare qualche nome, hanno raccontato le molteplici sfumature di uomo che ha attraversato un secolo, il secolo breve cogliendone i mutamenti. La puntuale regia di Cristiano Coppi si è avvalsa di un comitato scientifico composto da Andrea Giraldi, Matilde Montalti e Alice Vannucchi.
Nato il 31 dicembre 1890 a Pistoia in una famiglia proprietaria di un’officina per la lavorazione artigianale e artistica del ferro, si diploma all’istituto Superiore di Architettura dell’Accademia di Belle Arti, nel 1914 ottiene la licenza di professore di disegno architettonico; insegnerà presso l’istituto superiore di architettura di Firenze e sarà eletto Preside della Facoltà di Architettura nel 1944.
Durante la grande guerra Michelucci realizza una cappella sul fronte orientale vicino a Caporetto: più volte sarà costretto a confrontarsi con gli effetti della catastrofe (la ricostruzione del centro di Firenze dopo la seconda guerra mondiale, la risistemazione del quartiere popolare di S. Croce dopo l’alluvione, la chiesa a Longarone dopo la tragedia del Vajont). Dopo la guerra lascia le “Officine Michelucci”. All’ambiente artistico pistoiese, in cui svolge un ruolo importante di riferimento intellettuale, appartiene anche Eloisa Pacini, raffinata pittrice, che sposa nel 1928 conosciuta frequentando politici, intellettuali, pittori e musicisti mondanità di Roma dove vive dal 1925.
La sua adesione al regime fascista e oculate frequentazioni lo portano nel 1933 ad essere coordinatore del gruppo toscano e alla vittoria nel concorso per la Stazione di S. Maria Novella a Firenze con un’opera di valore internazionale per le qualità funzionali e per l’inserimento nel contesto storico e urbano.
 Dopo la guerra, che osserva da lontano isolandosi nella sua casa alla Cugna, immersa nella natura della montagna pistoiese e che sarà nuova fonte di ispirazione, crea la rivista “La Nuova Città”, espressione di un nuovo atteggiamento verso la società, dialogante e partecipativo, propone per la ricostruzione della zona attorno a Ponte Vecchio ipotesi innovatrici che s’infrangono di fronte alla tendenza conservatrice della città. Nel 1948 Michelucci lascia la presidenza della Facoltà di Architettura di Firenze passando alla facoltà d’ingegneria di Bologna; continua la ricerca di un nuovo linguaggio dell’architettura: la concezione dello spazio percorribile, la città variabile, un nuovo rapporto antico-moderno che si esprime anche nell’uso congiunto della pietra e del mattone con il cemento armato, l’acciaio e i nuovi materiali, così le idee prendono forma come per la Chiesa di San Giovanni Battista sull’Autostrada del Sole, a Campi Bisenzio, conclusa nel 1964, trait d’union di un paese in pieno miracolo economico, nella quale Michelucci anticipa i temi di una Chiesa in mutamento come sarà sancito dal concilio Vaticano II, o con la Chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di S. Marino.
Dopo la guerra, che osserva da lontano isolandosi nella sua casa alla Cugna, immersa nella natura della montagna pistoiese e che sarà nuova fonte di ispirazione, crea la rivista “La Nuova Città”, espressione di un nuovo atteggiamento verso la società, dialogante e partecipativo, propone per la ricostruzione della zona attorno a Ponte Vecchio ipotesi innovatrici che s’infrangono di fronte alla tendenza conservatrice della città. Nel 1948 Michelucci lascia la presidenza della Facoltà di Architettura di Firenze passando alla facoltà d’ingegneria di Bologna; continua la ricerca di un nuovo linguaggio dell’architettura: la concezione dello spazio percorribile, la città variabile, un nuovo rapporto antico-moderno che si esprime anche nell’uso congiunto della pietra e del mattone con il cemento armato, l’acciaio e i nuovi materiali, così le idee prendono forma come per la Chiesa di San Giovanni Battista sull’Autostrada del Sole, a Campi Bisenzio, conclusa nel 1964, trait d’union di un paese in pieno miracolo economico, nella quale Michelucci anticipa i temi di una Chiesa in mutamento come sarà sancito dal concilio Vaticano II, o con la Chiesa di Borgo Maggiore, nella Repubblica di S. Marino.
 Nel 1967 progettò con Mauro Innocenti l’ospedale di Sarzana affrontando così il tema della degenza, ma la costruzione, avviata nel 1974 si protrasse per decenni e non poté vederla ultimata.
Nel 1967 progettò con Mauro Innocenti l’ospedale di Sarzana affrontando così il tema della degenza, ma la costruzione, avviata nel 1974 si protrasse per decenni e non poté vederla ultimata.
Nel 1972 nel saggio Brunelleschi mago,pubblicato con l’editore ed amico pistoiese Tellini, con la postfazione di Mario Aldo Toscano. Bruno Zevi scrive su “L’Espresso” dei colloqui informali e antiaccademici di Michelucci con Brunelleschi. Il titolo è suggerito da un passo di Kafka “Perché mago? Non so, ma è capace di provocare un vivo sentimento di libertà…”. Wanda Lattes in un intervista a Michelucci presso la sua casa al Roseto a Fiesole descrive il libro come un “volumetto elegante, raffinato senza illustrazioni, spoglio di banali concessioni alla civetteria consumistica” con chiaro intendimento pedagogico e civico, nato non ambizione filologica ma come proseguimento di quelle lezioni impartite per anni in cattedra. Mario Toscano l’ha ascoltato per anni, poi ha iniziato a registrare i suoi discorsi spontanei; uno scritto che nasce quindi come discorso socratico tra un docente e tanti non individuati discenti.
 Nel 1974 muore la moglie Eloisa ed inizia un nuovo decennio creativo e progettuale. Nel 1982 Giovanni Michelucci costituisce con la Regione Toscana ed i comuni di Fiesole e Pistoia la “Fondazione Michelucci”, mentre una donazione di disegni al Comune di Pistoia costituisce il “Centro di documentazione Giovanni Michelucci” di Pistoia.
Nel 1974 muore la moglie Eloisa ed inizia un nuovo decennio creativo e progettuale. Nel 1982 Giovanni Michelucci costituisce con la Regione Toscana ed i comuni di Fiesole e Pistoia la “Fondazione Michelucci”, mentre una donazione di disegni al Comune di Pistoia costituisce il “Centro di documentazione Giovanni Michelucci” di Pistoia.
Le pagine de La Nuova Città, riflettono su temi come Carcere e città, Scuola e periferia, Città e follia, e portano all’ideazione del Giardino degli incontri nel carcere fiorentino di Sollicciano, un progetto sviluppato dal 1986 con i detenuti per creare un luogo di incontro con i familiari, ultimato nel 2007. Il 31 dicembre 1990 muore a Fiesole.
Alice Vannucchi è ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e della società Contemporanea di Pistoia, è membro della redazione della rivista “Quaderni di Farestoria”, è docente nella scuola primaria dal 2007. Fra le sue pubblicazioni: Il rientro in città: il problema degli alloggi, in Pistoia fra guerra e pace a cura di M.Francini, I.S. R.Pt. Editore, 2005. Teorie di democrazia in Italia e Francia nel dopoguerra in “Quaderni di Farestoria”,anno VIII-n2 maggio –agosto 2006,pag.61-69. Le scuole di partito nel PCI di Togliatti.Il caso toscano (1945-1953) in “Quaderni di Farestoria”,anno XII-n 2- maggio –agosto 2010,pagg.33-45. Ha curato la mostra e il numero monografico Cupe Vampe: la guerra aerea a Pistoia e la memoria dei bombardamenti, ISRPt. Attualmente si occupa di storia sociale e storia dell’editoria.