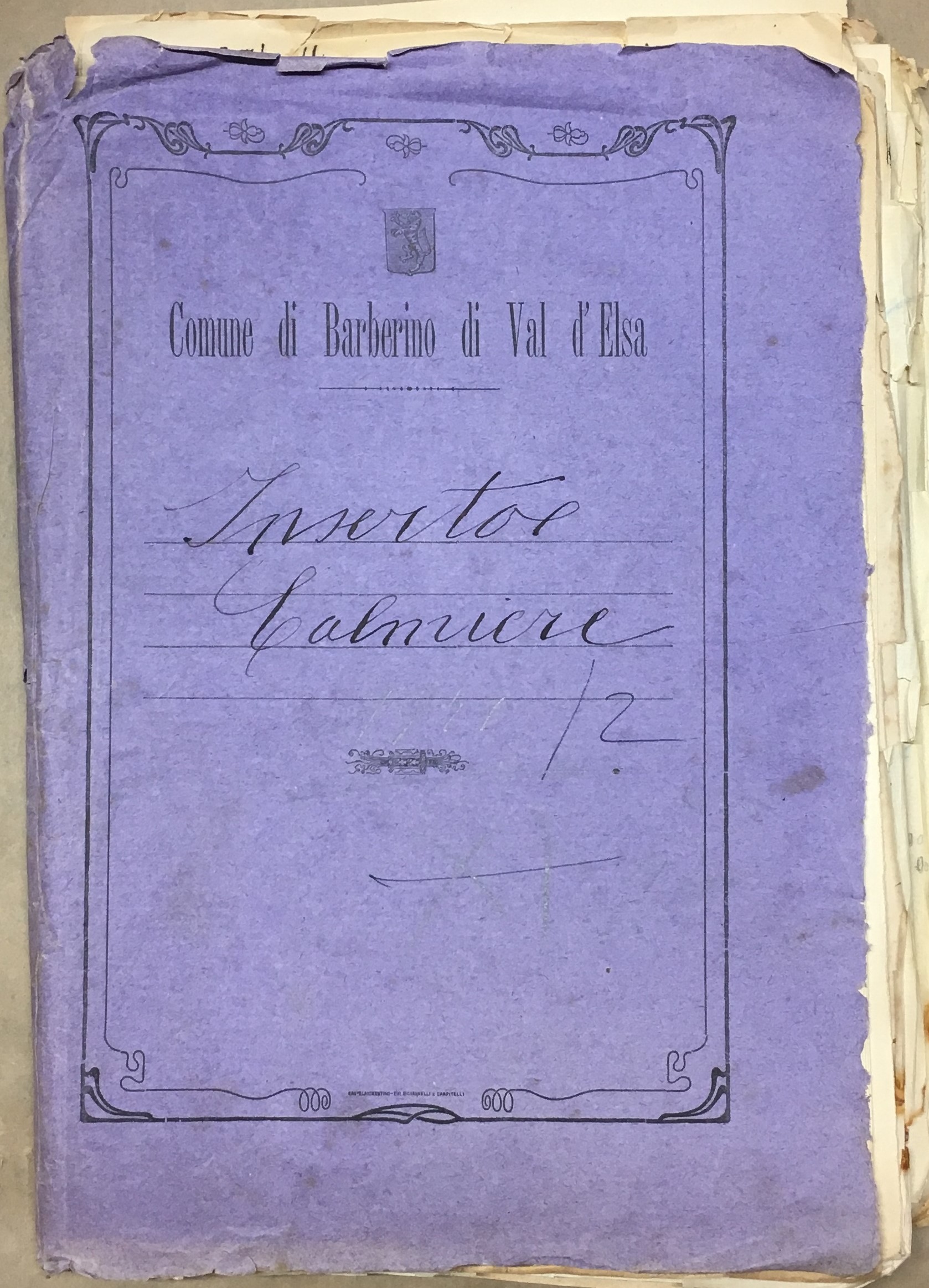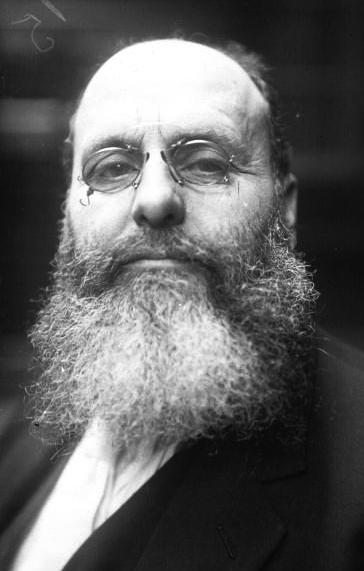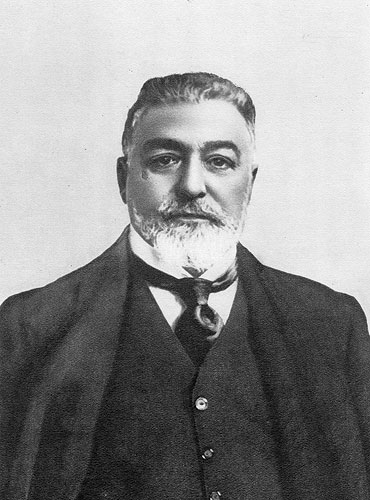Ebrei in Toscana XX-XXI secolo è il titolo di una Mostra tutta concentrata sull’età contemporanea. Perché questa scelta? Le ragioni sono molte e di diversa origine. Intanto perché è il periodo più vicino, quello che storicamente ci coinvolge di più. Ma, e non secondariamente, perché sentiamo il bisogno di ampliare sia la possibilità di una conoscenza più articolata cronologicamente che quella di affrontare questo tema per un pubblico non solo specializzato. L’idea è quella di analizzare la storia della comunità ebraica, così importante per la nostra regione e non solo, focalizzando l’attenzione su quegli avvenimenti più direttamente coinvolti, nel bene e nel male, con il nostro presente. Tale necessità si è particolarmente fatta urgente perché a partire dalla Legge sulla Memoria, istituita nel 2000, la vicenda ebraica toscana e nazionale è stata in qualche modo risucchiata e appiattita sulla tematica delle leggi razziali, della persecuzione e della deportazione. Ci sembra giusto ed opportuno uscire da quel periodo e narrare la storia di una minoranza in un quadro più articolato, più complesso di avvenimenti, un quadro capace di ridare evidenza alle caratteristiche sociali, culturali, politiche di questo gruppo. Evidenziare la loro capacità di collocarsi dentro il panorama delle idee non solo nazionali ma anche internazionali, di partecipare al farsi del destino politico e morale del paese.

La famiglia Castelli con figli e nipoti (Fonte: Archivio privato famiglia Castelli)
L’idea progettuale nasce all’interno di un Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea, quello di Livorno, l’ultimo nato nella rete degli istituti regionali. Può darsi che ad un osservatore esterno questa appaia anche come una decisione piena di arroganza. Noi pensiamo di no. Forti della nostra esperienza di gestione, nella città di Livorno, della grande Mostra della Fondazione Gramsci di Roma su: Avanti popolo. Il Pci nella storia d’Italia. Forti dell’esperienza dell’allestimento della Mostra sui manifesti politici: Rosso creativo. Oriano Niccolai 50 anni di manifesti, abbiamo deciso di affrontare una nuova sfida. L’idea che soggiaceva a questa nostra intenzione poi concretizzatesi era che gli Istituti come il nostro sono a pari dignità di altri enti culturali, sia pubblici che privati, soggetti produttori di cultura, e anche di cultura alta.
L’idea però è divenuta realtà concreta perché si è incontrata con la sensibilità della Regione Toscana che ha accolto il nostro progetto e l’ha sostenuto con generosità sia finanziaria che collaborativa, sia da parte della Presidenza, sia da parte dell’Assessorato alla Cultura. Non solo, durante tutto il periodo di realizzazione abbiamo sempre avuto al nostro fianco gli uffici della Cultura della Regione, in particolare, Massimo Cervelli, Claudia De Venuto, Floriana Pagano, Elena Pianea e Michela Toni e l’appoggio morale e intellettuale di una figura fondamentale per le politiche della Memoria, Ugo Caffaz. E dall’inizio abbiamo avuto a fianco le competenze della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Il tema della Mostra si è fatto strada in noi anche perché la città di Livorno era ed è una delle sedi più significative della presenza ebraica in Italia e il nostro Istituto, sin dal suo nascere, ha collaborato e collabora con la Comunità ebraica locale. Questa stessa vicinanza amplia il bisogno di raccontare una memoria dentro la cornice vasta della storia novecentesca, dare la possibilità ai cittadini tutti e in particolare ai giovani, di approfondire i motivi che conducono alla tragedia della Shoah ma anche di raccontare come si esce da quella esperienza e come ci si ricostruttura, sia come comunità, che come singoli. Il momento in cui comincia a prendere forma questa proposta, non era un momento ancora così tragico come quello che stiamo adesso vivendo. Se ne vedevano però tutte le avvisaglie all’orizzonte. Forse tutti ricordano l’uccisione di tre bambini davanti ad una scuola ebraica di Tolosa, nel marzo del 2012.
Eravamo consapevoli poi che il gruppo di lavoro che avremmo messo insieme avrebbe avuto a sostegno una ricca bibliografia frutto di lavori ultradecennali particolarmente vivaci, come quelli promossi dalla stessa regione Toscana sotto la guida di Enzo Collotti, così come tutto il materiale preparatorio per i viaggi della Memoria che la stessa Regione ha realizzato nel corso degli anni. Eravamo cioè sicuri di essere in buona compagnia.
La volontà di raccontare oltre cento anni di storia con un allestimento espositivo viene dal desiderio di utilizzare una modalità d’approccio capace di parlare anche al mondo dei non addetti ai lavori, e soprattutto ai più giovani. L’utilizzazione nel corpo della Mostra di riproduzioni di carte d’archivio, di copertine di libri, di disegni ma soprattutto di un apparato di riproduzioni fotografiche risultato delle donazioni di famiglie e di fondazioni culturali, arricchisce i testi, già di per sé particolarmente densi. Testi che abbiamo scelto di fare bilingui: in italiano e in inglese, in modo da aprirli alla fruizione di un pubblico potenzialmente molto più vasto di quello italiano. Sono testi che si prestano ad una possibilità di letture trasversali, di arricchimenti di senso, di interconnessioni e di suggestioni. Il team di lavoro che si è raggruppato attorno all’Istoreco, formato da specialiste della tematica come Barbara Armani, Ilaria Pavan, Elena Mazzini oltre alla direttrice dell’Istoreco, Catia Sonetti, si è poi arricchito di altri due narratori che hanno elaborato due pannelli specifici: Enrico Acciai, che ha curato quello sullo sfollamento degli ebrei livornesi, e Marta Baiardi, che ha scritto quello sulle memorie della deportazione. Un materiale esteso, coeso, uniformato da alcune scelte di scrittura condivise e rispettate con acribia che hanno, a nostro parere, dato il tono giusto alla Mostra. La traduzione è stata assegnata ad una specialista, la dottoressa Johanna Bishop, che ci ha garantito la qualità del lavoro. Tutti i nostri sforzi sono stati sorretti dalla volontà di far arrivare l’allestimento sui diversi territori regionali e anche esterni alla Toscana. Perché questo nostro piano si concretizzi, si dovrà incontrare con la volontà degli amministratori locali e con la possibilità di reperire altre risorse per i nuovi allestimenti, ma siamo fiduciosi che il desiderio di compartecipare a questa avventura renderà tutto ciò realizzabile. Del resto questa scelta è anche la strada più sicura per una reale e completa valorizzazione dello sforzo compiuto sia in termini finanziari che in termini scientifici.
Il risultato, di cui solo noi siamo responsabili, è anche il frutto della collaborazione con le diverse comunità ebraiche presenti sul territorio, collaborazione che è stata sempre continua e proficua. I loro presidenti, i loro archivisti e bibliotecari sono venuti incontro alle nostre richieste concedendoci materiali d’archivio e fotografici, sia delle Comunità stesse che dei componenti le medesime, in un rapporto di totale e rispettosa autonomia. Non solo. Abbiamo potuto realizzare alcune videointerviste a esponenti del mondo ebraico, che saranno riversate con un montaggio ad hoc in alcuni video che vanno ad arricchire il materiale documentale della Mostra.
Dal punto di vista del percorso seguito, dopo la stesura del progetto, si passa alla sua realizzazione che vede per oltre un anno tutti gli interessati coinvolti impegnarsi nello studio, nella ricerca archivistica e bibliografica, nella raccolta delle fonti iconografiche. Superata questa prima fase, ci siamo dedicati alla stesura vera e propria dei pannelli e poi alla sua realizzazione digitale con le professionalità specifiche dell’Agenzia Frankenstein di Giuseppe Burshtein di Firenze, in particolare con Cristina Andolcetti, Maddalena Ammanati, Stefano Casati, Federico Picardi e Isabella d’Addazio Quest’ultima fase è quella che ci ha permesso in itinere l’anteprima visiva di quello che andavamo facendo. Occorre dire che il controllo dei contenuti non è mai stato piegato alle esigenze della comunicazione anche se questa ha costretto tutti ad una sintesi espressiva, non proprio consueta per delle storiche e storici italiani. Vogliamo dire però che non ci siamo fatti prendere la mano dalla necessità della “leggerezza”, che nel nostro caso rischiava di farci dimenticare il forte sentimento divulgativo che ci animava. Siamo però stati attenti a tutti i suggerimenti degli addetti ai lavori che ci hanno consentito, perlomeno in parte, di superare certe difficoltà dei temi trattati per veicolare i nostri contenuti nel modo più accessibile possibile. Perlomeno questo era il nostro scopo.

Bagni Pancaldi (Livorno) Anni ’30 – Aleardo lattes e famiglia (Archivio privato famiglia Lattes Cabib)
La Mostra si sviluppa secondo un arco cronologico che va dalla Grande Guerra ai giorni nostri. Presenta anche alcuni pannelli introduttivi, uno sul perché questa Mostra, uno generale sulla presenza ebraica nella regione a partire dal periodo tardo medioevale, e l’altro specifico per l’età liberale, anteprima al secolo XX. Dopo aver analizzato la Grande guerra, la prima vera manifestazione dell’avvenuta emancipazione, ed esserci soffermati sul tema del sionismo, affronta in una sezione di grandi dimensioni, per forza di cose, il ventennio fascista con le colonie e l’impero, analizza sia il fronte degli antifascisti che quello dei sostenitori del regime, le leggi razziali del ’38, la persecuzione del 1943-1945. La Mostra si chiude infine con il secondo dopoguerra, toccando la problematica della ricostruzione dopo il ritorno dai campi, la battaglia per riavere i beni che erano state requisiti, il lento ricollocarsi dentro lo scenario postbellico, i rapporti con Israele. Questa è la sezione per la quale l’apparato storiografico al quale guardare, soprattutto in lingua italiana, è risultato più debole e carente. In ogni sezione analizzata emerge come il gruppo degli ebrei si collochi esattamente alla stessa maniera di tutti gli altri cittadini italiani del momento. Appoggia Mussolini con entusiasmo o perlomeno con un atteggiamento di condiviso conformismo alle opinioni della maggioranza oppure si schiera contro in una opposizione lucida ed eroica con quei pochi che vedono e capiscono prima degli altri il significato del regime e il futuro di guerra e di persecuzione che si intravede all’orizzonte. È possibile comprendere attraverso i nostri testi, e soprattutto con le fotografie a corredo, come fino all’ultimo la consapevolezza di quello che stanno rischiando, la possibilità di perdere i beni e le vite, non sia particolarmente radicata. O forse, accanto a questa sottovalutazione del pericolo, si nasconde l’abitudine plurisecolare a sopravvivere nelle disgrazie, a ridere nel bisogno, ad affrontare con allegria ed ironia le sorti peggiori, carattere che emerge proprio nei frangenti più drammatici. Così si spiega ad esempio la fotografia della famiglia Samaia che mentre sta per uscire dal paesino di Monte Virginio, vicino Roma, il 25 marzo 1944, di nuovo in fuga per trovare salvezza, trova il modo di farsi fotografare e a commento della foto scrive: Via col vento!
Le immagini, a corredo, nell’insieme, racconta più dei testi scritti la “religione” della famiglia che pervade queste comunità. Non viene sprecata nessuna occasione per fotografarsi in gruppo ed il gruppo si sviluppa e si espande attorno alla coppia degli anziani. Particolarmente indicative in questo senso sono le foto a corredo donateci dagli eredi della famiglia Castelli. Ma non sono da meno quelle, più vicine a noi nel tempo, della famiglia Cividalli, Orefice, della famiglia Levi, dei Viterbo o dei Caffaz, della famiglia Samaia, e molte altre ancora. Certo l’amore per la famiglia pervade anche tutti gli altri italiani. Nessuno o quasi ne è escluso. Quello che qui vediamo è la documentazione fotografica dei passaggi importanti: le nozze, le feste di purim, il bar mitzvah per i ragazzi o il bat mitzvah per le ragazze, perché anche se l’adesione alla religione dei padri è, perlomeno fino alle leggi razziali, piuttosto debole, fatta più di consuetudine che di una adesione forte e vissuta con convinzione, importante è attraverso la ripetizioni di ritualità, come la preparazione di alcuni dolci tipici o il pranzo in comune in certi momenti, mantenere la coesione del gruppo. Gruppo nel quale molto spesso vengono inseriti, senza particolare travaglio, anche gli elementi “gentili” assorbiti con i matrimoni misti. Questo come dicevamo sopra fino alle leggi razziali.
Nel secondo dopoguerra, la scoperta della tragedia che si è abbattuta sul popolo ebraico rinsalda le tradizioni, aumenta i viaggi in Israele e la scelta di andare a viverci, riavvicina alla religione dei padri anche chi se ne era distaccato, fino ad arrivare al nostro presente, fatto di piccole e piccolissime comunità orgogliose della propria specificità, molto presenti sul piano culturale e molto attive nel dialogo interreligioso.
La Mostra è arricchita di diversi video in cui scorrono i montaggi tratti da alcune videointerviste realizzate nel corso della preparazione della Mostra. Si vedono donne e uomini ragionare sulla loro appartenenza, sulla storia della loro famiglia, sul loro sentimento religioso, sui conti che hanno fatto come singoli rispetto alla loro maggiore, o minore, o assente, appartenenza alla comunità ebraica.
Naturalmente nella Mostra non c’è affatto tutto quello che si può raccontare su questa minoranza, mancano alcuni pezzi importanti come le vicende, fra l’altro segnate da numerosi episodi di antisemitismo, della minoranza ebraica italiana, quasi tutta di provenienza labronica, in Algeria o in Marocco. Non c’è stata la possibilità di raccontare nessuna storia di genere, anche se attraverso il materiale raccolto, tra cui molte lettere e molti diari inediti, ci siamo fatti un’idea piuttosto articolata delle condizione della donna dentro la comunità ebraica. In qualche modo sicuramente privilegiata perché istruita e capace di saper leggere e scrivere, conoscere una lingua straniera, suonare uno strumento musicale ma assolutamente ostacolata nel suo desiderio di intraprendere libere professioni o attività lavorative vere e proprie. Questo perlomeno fino alla conclusione del secondo conflitto. Come succedeva nelle famiglie non ebree dell’Italia liberale e fascista del secolo scorso. Non abbiamo potuto approfondire il tema dei rapporti con lo Stato italiano sul versante della restituzione dei beni sottratti, né quello dei processi intentati contri fascisti e delatori.
La Mostra poteva chiudersi con l’immagine di una svastica disegnata in anni recenti sulla facciata della sinagoga di Livorno. Abbiamo deciso di no. Non era il caso. Tutto il nostro lavoro ha senso anche perché sottintende il desiderio di un rispetto reciproco nelle riconosciute diversità che all’interno del nostro orizzonte odierno, che non è più quello nazionale, ma perlomeno europeo, vedono di nuovo muri che si ergono, leggi di discriminazione strisciante farsi avanti e ancora rumore di bombe e sangue versato contro istituzioni e luoghi Kasher. Noi pensiamo e percepiamo il nostro lavoro solo come piccolo tassello per un dialogo di pace e ci siamo rifiutati di chiudere con un’immagine senza speranza.
Livorno, 24 ottobre 2016