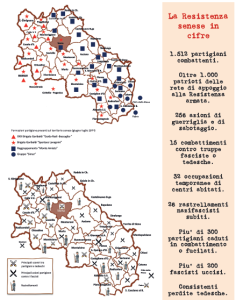ARNALDO DELLO SBARBA, ANATOMIA D’UNA CADUTA

Era stato protagonista della politica toscana da fine ‘800 in poi. Nel 1924 Mussolini lo voleva nel “Listone” fascista.
Ma contro l’ex ministro riformista insorse lo squadrismo pisano.
Dalla rilettura di archivi pubblici e privati, in parte inediti, il ritratto di una classe dirigente che allevò il fascismo e ne fu divorata.
Che nel giro di pochi giorni, o forse di poche ore, si sarebbe giocato tutta la sua vita politica, Arnaldo Dello Sbarba (1) lo sapeva da tempo. E a quella vigilia elettorale dell’anno 1924 (2) era arrivato come lui sapeva fare: ben preparato.
Aveva dalla sua Benito Mussolini, vecchia conoscenza d’epoca socialista e ora duce del fascismo vittorioso. Aveva conquistato Cesare Rossi (3), numero due del regime e potente capo dell’ufficio stampa del governo. Nella circoscrizione, nella quale Dello Sbarba aveva recitato da primattore per quattro legislature, puntavano su di lui le élite fiancheggiatrici che speravano così di moderare e controllare lo squadrismo (4).
Nella base fascista Arnaldo poteva contare sul Fascio di Pisa, guidato dal capitano Bruno Santini (5), che sul “caso Dello Sbarba” aveva ricevuto istruzioni “inequivocabili” dal duce. Santini capeggiava in quei giorni il movimento dei “dissidenti” contro il segretario federale Filippo Morghen (6), sostenuto invece dai “ras” provinciali (7). E da quando Morghen s’era avventurato a giurare: «Nel fascismo, o me o Dello Sbarba» (8), Santini s’era convinto che poteva usare Dello Sbarba per togliersi Morghen dai piedi.
Considerati dunque tutti i pro e i contro, Arnaldo riteneva di poter vincere la partita. Sarebbe stato ammesso nella “Lista Nazionale” di Mussolini, con la certezza di tornare in parlamento. Voti personali ne aveva in quantità, al resto ci avrebbe pensato il diluvio di seggi garantiti ai fascisti dalla legge Acerbo.
Eppure, compiuti cinquant’anni il 12 agosto 1923, Arnaldo Dello Sbarba si avvicinava all’anno nuovo in stato di grande agitazione. Alla vigilia di Natale, il suo fedele segretario Carlo Conti (9) aveva riferito al fratello Bruno Dello Sbarba di «gravi preoccupazioni politiche non ancora ultimate [anche se] ben incamminate (…) Ci vorranno ancora dei giorni nei quali Arnaldo, che non sta bene soprattutto di cuore, ha bisogno di calma più assoluta (…) . Scrivigli per tranquillizzarlo e incitarlo a vincere la più aspra battaglia» (10).
Finito in mezzo alle lotte intestine del fascismo pisano, nel novembre del 1923 Arnaldo era stato addirittura aggredito alla stazione di Pisa da una squadraccia comandata dal conte Giuseppe Della Gherardesca (11).
Di questo si era immediatamente lamentato con Cesare Rossi. L’aggressione, scrive Arnaldo a Rossi il 10 novembre 1923, non è stata affatto «frutto di uno stato di esaltazione personale» ma della volontà di «costringermi fuori dalla vita pubblica».
Arnaldo riferisce a Rossi che in una riunione della federazione fascista, successiva all’aggressione,
in cui il Gherardesca urgentemente chiamato partecipò, […] si proclamò che io ero un comunista, antitaliano e anti-patriota, e che coloro che mi avevano fatto affronto avevano compiuta opera italianissima, da deplorar semmai per essere stata solo nei limiti di minacce e di ingiurie (…). Fui interventista della primissima ora, partecipai alla manifestazione di Quarto (12) e scoppiata la guerra mi scrissi volontario. Non ho, in coscienza, nulla da rimproverarmi (…) alle accuse di chi, come il Gherardesca fu in quegli anni noto tedescofilo.
Lei mi è testimone – continua la lettera di Arnaldo a Rossi – con quale ardore nel 1921 io, nella circoscrizione di Pisa Lucca Livorno e Massa Carrara, difesi il blocco nazionale ed affermai le ragioni del fascismo, allo stesso modo che nelle sventurate elezioni del 1919, per riaffermare le ragioni della guerra e della patria, fui esposto a tutti gli oltraggi e a tutti gli attentati dei socialcomunisti. Venuto il governo fascista gli ho dato disinteressatamente ed incondizionatamente tutto il mio consenso, fino a partecipare alla commemorazione della marcia su Roma. Della mia devozione per il Presidente non ho bisogno spero neanche di intrattenermi (13).

Primo maggio 1900. Arnaldo saluta il nuovo secolo con la prima pagina de L’Avanti.
(Archivio privato famiglia Dello Sbarba)
Questo Arnaldo Dello Sbarba del 1923 non era evidentemente più quello «degli anni della sua splendida gioventù», raccontati da Arnaldo Fratini (14) nella sua storia del socialismo volterrano, «che germogliò per la cura, l’ardore e il coraggio con cui lui, insieme ad altri ottimi compagni, volle e seppe coltivarlo». Non era più il battagliero direttore de «Il Martello», uno dei primi giornali del socialismo toscano (15), né il giovane avvocato che nel 1898 aveva difeso, a fianco di Pietro Gori, i lavoratori in sciopero a Campiglia e nel 1900 aveva combattuto per la grazia all’anarchico Cesare Batacchi, rinchiuso nel mastio di Volterra per una bomba mai lanciata (16).
Aveva cambiato rotta: c’era stato l’appoggio alla campagna coloniale di Libia del 1911 (17), l’espulsione dal PSI nel 1912, l’interventismo, la guerra, il “Biennio Rosso” vissuto dalla parte opposta della barricata, all’ombra del liberalismo giolittiano.
Deputato ininterrottamente dal 1911, nei governi di Nitti e Giolitti, Arnaldo era stato sottosegretario alla Giustizia nei mesi insanguinati dall’insorgenza del fascismo. Nel debole governo Facta era stato infine ministro del lavoro, finché la marcia su Roma non aveva mandato tutti a casa. Dopo di che, da deputato, aveva votato per il primo governo Mussolini, usando poi la presenza in parlamento per intessere relazioni nei palazzi del nuovo potere.
Il suo riferimento più importante era diventato Cesare Rossi, che in quell’inizio del 1924 stava lavorando per allargare il consenso al fascismo e farne la spina dorsale di un nuovo stato. La candidatura di un Arnaldo Dello Sbarba, ex ministro dell’era giolittiana, era funzionale a questa strategia.
Così Cesare Rossi si era fatto il regista della candidatura Dello Sbarba nel listone fascista. All’inizio del 1924 aveva ordinato a Luigi Freddi, capo ufficio stampa del PNF, di impedire all’ala intransigente del fascismo pisano di usare il settimanale «L’Idea fascista» per «scocciar l’anima a Dello Sbarba (…) poiché costui (che fra parentesi è molto intelligente e abbastanza ben visto dal Presidente, il quale gli ha anche affidato l’incarico, insieme ad altri due o tre Deputati, di costituire un gruppo di sinistri fascistofili) finirà per essere compreso nel Listone. (…) Io mi riprometto di difenderlo al momento opportuno» (18).
Il tandem Rossi-Freddi aveva anche imbastito una massiccia campagna di stampa per Arnaldo, trainata da «Il Nuovo Giornale» di Athos Gastone Banti e dal «Corriere italiano» di Filippo Filippelli (19).
Per dividere il fronte degli intransigenti, Cesare Rossi aveva mobilitato con un telegramma il principe Piero Ginori Conti (20), proprietario della Boracifera di Larderello e ras dei ras provinciali:
Consiglio inviare senz’altro Presidente Mussolini telegramma in cui si prospettino opportunità positive soprattutto elettorali inclusione Dello Sbarba testimoniando, come per mio conto ho già fatto e farò ancora, il suo contributo [di] affiancatore [del] movimento fascista in varie sue fasi.
Intanto Arnaldo Dello Sbarba stava preparando un promemoria per illustrare i suoi meriti «di affiancatore del fascismo». Nel suo archivio se ne trovano diverse bozze. Un primo schema lo redige Carlo Conti e per Arnaldo rivendica la lotta contro il popolare segretario provinciale del PSI Carlo Cammeo e le manovre messe in atto per destituire, in combutta col prefetto filofascista Renato Malinverno, i “sindaci rossi” Giulio Guelfi di Cascina ed Ersilio Ambrogi di Cecina (21).
Un canovaccio è incaricato di stenderlo anche l’altro segretario, il cavalier Vittorio Fagioli di Marciana Marina, luogotenente di Arnaldo per la provincia di Livorno:
I socialisti ufficiali gli dichiararono guerra implacabile […]. Nelle elezioni del 1919 la campagna bolscevica fu esclusivamente contro l’on. Dello Sbarba, che fu coperto di contumelie come guerrafondaio, indicato all’ira delle folle e in un sobborgo di Pisa gli fu perfino tirato in faccia manciate di sterco e di mota gridando: Eccoti la Patria! (22).

1920, Arnaldo sottosegretario alla Giustizia nel V° governo Giolitti
(Archivio privato famiglia Dello Sbarba)
Il promemoria definitivo, in terza persona e da spedire a Roma, Arnaldo lo scrive di suo pugno. Nella prima parte ripercorre le prove del suo amor di Patria, già ricordate nella lettera a Cesare Rossi. Poi passa agli esempi concreti, che letti oggi fanno venire i brividi.
Sottosegretario alla giustizia con Giolitti – scrive di sé Arnaldo Dello Sbarba – si batté col noto maestro Cammeo in una elezione provinciale memorabile e difese i fascisti sempre. Avvenuta la uccisione Cammeo (Mussolini ebbe con lui in proposito una corrispondenza telegrafica) procurò la scarcerazione della Rosselli e degli altri accusati (23). Quando, dopo i fatti di Sarzana (24), fu arrestato Santini, andò a Massa per farlo scarcerare. Quando fu ucciso Menichetti (25) in una imboscata comunista a Ponte a Moriano, ne seguì a capo scoperto il feretro.
Ministro del lavoro, parlando in una solenne riunione a Larderello (il senatore Ginori Conti presente e testimone) fece pubblica esaltazione del fascismo. Idem per l’inaugurazione del monumento ai caduti a Bagni di San Giuliano [e] il 26 ottobre 1922 in un pubblico discorso a Casanova di Piemonte […].
Dopo l’avvento del governo fascista, […] si fece sollecito di infondere nelle masse operaie, su cui ha vivo ascendente, il senso di fiducia e disciplina al governo dell’on. Mussolini, che esaltò […] ai metallurgici di Viareggio, ai contadini di Rosignano, agli operai di Ponte a Moriano, ai cavatori di alabastro di Castellina, ai mezzadri di Collesalvetti. […]. Nell’anniversario della Marcia su Roma – a dimostrare che fascismo e nazione si identificano – partecipò ai pubblici cortei (26).
È perseguitato dai ras locali con la scusa che egli ha una mentalità socialista, quella che servì sempre senza infingimenti […] e che anche oggi, per la parte che tende all’elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici, non avulse ma integrative dei supremi interessi della Patria, ha il suo più grande interprete in Mussolini e la pratica nei sindacati nazionali fascisti.
La candidatura Dello Sbarba viene discussa a Roma dalle massime cariche del fascismo dal 4 all’11 febbraio 1924. Ne abbiamo sul «Messaggero Toscano» il resoconto di Bruno Santini, presente come segretario del fascio di Pisa, che riferisce di aver dichiarato in diverse riunioni tra il 4 e il 9 febbraio, a Costanzo Ciano, presente Morghen, a Cesare Rossi, alla Pentarchia (la commissione elettorale a cinque) presieduta da Aldo Finzi
che l’on Dello Sbarba aveva forti correnti contrarie nel partito Fascista e una ragguardevole forza sua fuori dal partito, tra tutti coloro che per quindici anni erano stati da lui beneficiati, aiutati, sorretti. Se l’on. Dello Sbarba fosse entrato nella Lista Nazionale del Partito Fascista, questa avrebbe guadagnato voti di molti elementi non fascisti.
Alla seduta decisiva dell’11 febbraio 1924 partecipa Mussolini in persona, che ha l’ultima parola sulle candidature. «Davanti a S.E. Mussolini, presente S.E. De Bono – racconta Santini – ripetei le stesse dichiarazioni. Il Presidente mi lesse alcuni appunti riguardanti l’on. Dello Sbarba, che riflettevano la sua posizione rispetto al Fascismo», e qui Santini cita a memoria la scarcerazione degli assassini di Cammeo, quella dello stesso Santini a Massa e il discorso filo fascista a di San Giuliano Terme. «Altro lesse il Presidente che io non ricordo. Ricordo che le dichiarazioni del Presidente furono esplicite, nette, recise» (27).
Ai vertici fascisti Mussolini aveva letto dunque proprio il promemoria scritto da Arnaldo. E aveva deciso. L’annuncio arriva a Dello Sbarba con un biglietto proveniente dai corridoi della Pentarchia:
Caro Arnaldo, stamani la tua questione è stata decisa favorevolmente. Tu sei stato ammesso come era giusto e doveroso. [La firma è purtroppo indecifrabile].
«Comincia circolare voce tua inclusione, studio affollato, entusiasmo vivissimo» telegrafa Conti ad Arnaldo il 12 febbraio. Il mattino dopo il segretario viene convocato dal prefetto Renato Malinverno, preoccupato della piega presa dagli avvenimenti. Alle 16,30 Conti riferisce ad Arnaldo:
Alle 11:00 sono stato chiamato dal prefetto. Ha cominciato col prospettarmi il pericolo di dimissioni, di astensioni eccetera. L’ho fermato subito su questa strada dicendogli chiaro e tondo che avevo saputo da Dario Lischi (28), tornato stanotte da Roma, le parole chiare e inequivocabili dette dal Duce al Santini: “Dì ai Pisani che Dello Sbarba è nella lista per mio volere e nessuno ce lo toglie, che è anche l’ora di smetterla con i campanili – essendo la lista Nazionale – anche se i campanili sono storti e artistici come quelli di Pisa”.
Il prefetto evidentemente non conosceva questo episodio che gli ha fatto impressione. Allora ho cominciato a parlare descrivendogli la situazione vera, (i grandi consensi eccetera) che è in tuo favore. Quanto a dimissioni, astensioni ecc ., gli ho detto saranno in numero molto ridotto seppur vi saranno. Che in ogni modo si tratterà di qualche capo malinconico e scornato. (…) Che la verità vera è questa: Medoro (29) e gli altri della federazione avevano corso troppo nel farti la guerra e si trovavano perciò impegnati fino al collo (…) per giustificare dinanzi alla Pentarchia la loro imbecillità e creare fantasmi di agitazione.
Poi uscendo gli ho detto: Scusi lei sente di essere il prefetto? Lui mi ha risposto: Ah per questo Le assicuro che io eseguirò e farò rispettare gli ordini! Basta così! Ho la convinzione di averlo lasciato persuaso.
Il 14 febbraio anche la stampa dà la notizia dell’inclusione di Arnaldo nel listone fascista. Ma gli avversari non si sono dati per vinti.
Il 15 febbraio una lettera proveniente da Pisa avverte Dello Sbarba:
Carissimo onorevole, sono arrivati stamani da Roma gli energumeni Carosi, Biscioni, De Guidi, Parenti ed altri che lunedì notte, appena appresa la notizia della sua inclusione nel Listone, partirono per impressionare le direzione del partito. Minacciarono distacco dal Partito ufficiale, costituzione di fasci autonomi, rappresaglie ecc. e secondo quanto essi affermano sarebbero riusciti a persuadere il Direttorio e l’on. Giunta a far pressione presso il Duce per ottenere il loro intento (30).
Il 17 febbraio il segretario provinciale Filippo Morghen – che si era istallato in permanenza a Roma presso l’hotel Continental, a due passi dalla stazione – dirama a tutti i fasci l’ordine di inviare ai vertici nazionali telegrammi contro l’inclusione di Dello Sbarba nel listone.
Morghen ha dalla sua la deliberazione del 2 febbraio della federazione fascista pisana che si era pronunciata per l’esclusione di Dello Sbarba e un’ordine del giorno approvato dall’assemblea dei sindaci fascisti in cui essi «confermano di ritenere Dello Sbarba politicamente non degno di essere compreso nella Lista Nazionale». Se Mussolini lo avesse ciò nonostante inserito, i sindaci fascisti minacciano di dimettersi in massa. E se qualcuno se ne fosse dimenticato, il 18 febbraio ci pensa il sindaco di Collesalvetti Gino Lavelli de Capitani, proprietario di fabbriche nella piana pisana, a spedire a tutti i sindaci una copia della delibera approvata, invitandoli a passare ai fatti (31).
Il 19 febbraio Carlo Conti informa Arnaldo dei metodi adottati dagli intransigenti.
Alla famosa adunanza, molti sindaci non erano presenti e, tolti 3 o 4, gli altri dichiarano che fu loro imposto di votarti contro. A Volterra si vive nel terrore, girano col nerbo per impedire che ti si facciano telegrammi o si faccia il tuo nome. Sono 7 o 8, ma armati, e fanno paura alla gente. Soltanto perché il Quadri fece pubblica dichiarazione di soddisfazione per la tua inclusione, la farmacia ora è guardata dai carabinieri”.
Lo stesso Conti è stato minacciato con un biglietto anonimo: «Diciamo a lei diabolico segretario di smetterla perché prima del suo padrone sarà soppresso». Conti commenta: «Niente po’ po’ di meno! Povero, grande Mussolini, da qual gente è qui rappresentato!».
Il fatto è che il «povero grande Mussolini» ha già fatto marcia indietro, cedendo alle pressioni del fascismo intransigente. Accade così ora nel microcosmo pisano ciò che in grande si ripeterà nel gennaio del ’25, come reazione al delitto Matteotti. Messo di fronte all’alternativa drastica, e rimangiandosi le promesse di moderazione, il duce sceglierà sempre di appoggiarsi all’ala più violenta del fascismo.
Alla sera di quel tormentato 19 febbraio 1924, l’agenzia Stefani batte infine il dispaccio che riporta la versione definitiva della Lista Nazionale per la Toscana. Arnaldo Dello Sbarba non vi compare più.
È successo che per tagliare la testa alle lotte interne, Mussolini ha deciso per la Toscana una lista “fascistissima”, composta di sole camicie nere. Accanto ai 24 nomi scelti dal duce vengono indicate con puntigliosità le cariche fasciste e i meriti di guerra: combattente, decorato, grande invalido e così via. Per Pisa in lista compaiono Guido Buffarini Guidi (32), sindaco e presidente dei combattenti, e Lando Ferretti (33), «ferito in guerra e decorato», entrambi candidati proposti dalla federazione pisana. Non vi compare invece l’uomo che il direttorio aveva proposto come primo: Filippo Morghen. L’eliminazione di Dello Sbarba ha trascinato con sé anche il suo arcinemico – almeno in questo Bruno Santini aveva visto giusto.
Il quale Santini, qualche giorno appresso, si prende pure la soddisfazione di rivelare sulla stampa gli intrallazzi di Morghen, che, mentre scatenava le camicie nere contro Dello Sbarba, dietro le quinte tentava un accordo con il vituperato ex ministro. Santini racconta che, nelle concitate giornate in cui a Roma si discuteva della candidatura Dello Sbarba, Morghen lo aveva fatto contattare da tre suoi uomini della commissione elettorale pisana che gli avevano promesso di «cessare la campagna contro di Lei» in cambio dell’impegno dello stesso Dello Sbarba a sostenere l’ingresso nel Listone «di nomi nostri, designati dalla Federazione» – tra i quali compariva come primo proprio il Morghen (34). È probabile che questo doppio gioco abbia convinto il duce a escludere pure lui dalla lista.
«Che farà ora Dello Sbarba?» si chiede il Messaggero Toscano la mattina del 20 febbraio. Il giornale prospetta due strade: presentare una lista propria, o aderire alla lista “Democratici Sociali” creata da due sue vecchie conoscenze, Mario Supino, avvocato, esponente della “democrazia massonica” di Pisa, e Augusto Mancini (35), filologo e deputato radicale, che di questa «lista parallela» aveva già informato Arnaldo per lettera il 15 febbraio.
In realtà, Arnaldo avrebbe avuto anche una terza opzione: confluire nella “lista bis” in cui Mussolini aveva dirottato in Toscana i tre deputati liberali uscenti, restati anche loro fuori dalla lista “fascistissima”. E cioè il livornese Guido Donegani, presidente della Montecatini, il senese Gino Sarrocchi, liberale della destra salandrina contiguo al fascismo, e l’agrario grossetano Gino Aldi Mai (36). Questa “lista bis” avrebbe pescato nei seggi spettanti all’opposizione, ma era appoggiata dal governo e sarebbe poi confluita nella maggioranza. Teoricamente, l’opzione ideale per Dello Sbarba: garantita nel risultato, indipendente nella forma, fascista nella sostanza. Ma – informava il «Messaggero Toscano» – «i liberali non ne vorranno sapere di Dello Sbarba», ormai sgradito al fascismo locale e temibile concorrente nelle preferenze.

1916, Arnaldo sottotenente nei gruppi di artiglieria avanzata della Val Lagarina a Coni Zugna e Zugna Torta.
(Fondo A. Dello Sbarba Biblioteca Guarnacci di Volterra)
La mattina del 20 febbraio Arnaldo è ancora deciso a non mollare. Solo e arrabbiato nel suo ufficio di deputato a Roma, prende carta e penna e scrive a Mussolini per annunciargli che lui si candiderà comunque.
Caro Presidente, ieri discutendosi in Pentarchia la lista per la Toscana, il mio nome non fu incluso nella lista nazionale, non già perché mi si potesse rimproverare alcuna colpa verso la Patria o verso il Fascismo, ma solo perché tal Morghen, segretario provinciale di Pisa, per risentimenti personali spintisi fino ad una vera e propria caccia all’uomo, ha creato una situazione di grottesco imbottigliamento antisbarbiano che ieri (domandalo al comm. Cesare Rossi) egli non riuscì a giustificare […]. D’altronde io so di non avere demeritato né della Patria né del Fascismo, cui ho dato lealmente consigli e aiuti; so di avere numerosi amici in Toscana, i quali non possono e non vogliono tollerare questa forma di ostruzionismo politico, e quindi, non perché malato di parlamentarismo, ma perché […] devo difendere la mia dignità umana, io vado ad appellarmi al giudizio degli elettori, ai quali chiarirò che […] solo da loro, che mi diedero per 4 legislature il viatico, io posso accettare oggi il congedo dalla vita politica” (37).
Alla sera, però, Arnaldo ci ripensa. Per tutto il giorno ha ricevuto messaggi che lo spingono a più miti consigli. Il fedele e accorto Carlo Conti, già la sera del 19 febbraio, lo ammoniva: «I pochi amici coi quali ho parlato sono poco favorevoli a liste bis o parallele».
La mattina dopo anche Gino Sossi, avvocato, compagno in politica, socio negli affari e marito della sorella Adele, gli aveva scritto:
Non so se tu accetterai di fare parte di una lista parallela, ma il mio avviso è che tu debba accettare se sicuro della riuscita. Se dovessimo fare la lotta delle preferenze con Donegani, Sarrocchi ecc. credo che potremo essere battuti. Perciò sii vigile, l’unica cosa da evitare è di accingersi alla lotta e rimanere a terra.
Anche l’industriale farmaceutico pisano Alfredo Gentili, suo fedele sostenitore, lo metteva in guardia dal candidarsi «nella lista bis, che qui è chiamata la lista dei cani rognosi». Infine, da Pisa gli aveva telegrafato la moglie Maria Ziffo:
Amici interpellati ritengono conveniente tuo disinteressamento eventuale lista liberale perché lotta ridurrebbesi favorire influenti liberali privilegiati [da] centri elettorali industriali.
A sera, dunque, Arnaldo Dello Sbarba si era di nuovo seduto alla scrivania per scrivere una seconda lettera a Mussolini e poi fargliela recapitare subito a mano dal servizio parlamentare. Sono le ultime parole – almeno per ora! – di una lunga carriera politica:
Illustre Presidente – scrive Arnaldo – la situazione di ostilità e di dissenso che si è riacutizzata, in questi giorni, fra fascisti pisani per la cocciuta volontà di alcuni di essi, ingiustamente prevenuti contro di me ed immemori della mia opera sempre onesta e fermamente patriottica anche in ore oscure, che rivendico in pieno, mi decide a rinunciare alla formazione di una lista propria […]. Ma se rinuncio a rientrare in Parlamento, ove le mie forze elettorali mi avrebbero certamente riportato, non intendo disertare il campo della lotta imminente. Perciò, inviterò con pubblico manifesto i miei amici a votare compatti e fervorosi la Lista Nazionale, con l’augurio che gli infatuati miei oppositori non mi impediscano almeno di portare il mio personale disinteressato aiuto alla forte battaglia che tu combatti – con pugno sicuro – per la più grande vittoria dell’Italia.
In soli cinque giorni Arnaldo Dello Sbarba si era giocato la sua carriera politica, e aveva perso.
Qualche settimana dopo lo conforta sua madre da Volterra:
Arnaldino mio – scrive Isola Veroli – non posso descriverti la consolazione. Sapendo la guerra che ti facevano e conoscendo questa gente, avevo sempre paura che ti facessero del male. Anche Bruno mi scrive che è contentissimo della tua decisione, prega e spera che tu non cambi. Mi dici che presto verrai a Volterra. Io non ci credo finché non ti vedo e il desiderio è tanto grande” (38).
Il 4 aprile 1924, alla vigilia di elezioni che a Pisa si sarebbero svolte per la prima volta da vent’anni senza un Dello Sbarba in qualche lista, si fa vivo di nuovo l’amico industriale Alfredo Gentili:
Il governo dovrebbe esserle grato (esiste oggi la gratitudine a Roma?) per il suo atteggiamento. Avremo la possibilità non lontana di vedere un segno della gratitudine mussoliniana per lei?
Gentili allude a quella prossima “infornata di nuovi senatori” per nomina governativa di cui già parlano i giornali (39). Il Duce avrebbe ripescato anche Arnaldo? Amici, sostenitori, segretari, e prima di tutti lui stesso, ci contano.
Le “infornate” arriveranno una dopo l’altra, ma il turno di Arnaldo Dello Sbarba non arriverà più. Al contrario, il fascismo pisano vuole liberarsi definitivamente di lui.
Il 2 gennaio 1925, al culmine della crisi seguita al delitto Matteotti e alla vigilia del discorso con cui Mussolini assumerà in parlamento la responsabilità dell’assassinio (40), un corteo di fascisti furibondi attraversa Pisa come “una colonna di fuoco” (41). Oltre a distruggere il circolo repubblicano e il quotidiano cattolico «Il Messaggero toscano», al grido di “fuori i massoni dal fascismo” i fascisti devastano la loggia massonica, l’abitazione e lo studio del gran maestro Alfredo Pozzolini e l’abitazione e lo studio al Palazzo alla Giornata di Arnaldo Dello Sbarba.
Pochi mesi dopo, Arnaldo deciderà di abbandonare Pisa per Roma: «Ho dovuto constatare scrive al fratello Bruno (42) – che a Pisa non c’è aria per me, e non c’è lavoro».
NOTE:
(1) Arnaldo Dello Sbarba (1873-1958) è stato dalla fine dell‘800 alla prima metà del ‘900 un protagonista della politica in provincia di Pisa (compresa l’area da Rosignano all’Elba). Laureato in Giurisprudenza a Pisa, consigliere in comune a Volterra e poi in provincia, è parlamentare dal 1911 al 1924. Diviene sottosegretario nei governi Nitti e Giolitti (1920-1921) e ministro per il Lavoro nei governi Facta (1922). Naufragata la candidatura nel “Listone” fascista del 1924 e entrato nel mirino dei fascisti, abbandona Pisa per Roma. Fino al 1929 è sottoposto a vigilanza di polizia. Nel 1943 il prefetto della RSI emette contro di lui mandato di cattura. Dopo la Liberazione di Pisa, il 29 dicembre 1944 è ammesso nel CLN provinciale su nomina del neonato “Partito Democratico del Lavoro”, nonostante la decisa opposizione di partigiani e CLN di Volterra che lo accusano di complicità col fascismo. Nel dopoguerra ricopre numerose cariche, tra cui quella di Presidente della Cassa di Risparmio di Pisa e della Domus Galileiana. Cfr. A. Biscioni, Dello Sbarba Arnaldo, in Dizionario biografico degli italiani Treccani, 1990, https://www.treccani.it/enciclopedia/arnaldo-dello-sbarba_(Dizionario-Biografico).
Gran parte delle sue carte sono conservate nel Fondo A. Dello Sbarba nell’archivio della Biblioteca Guarnacci di Volterra (d’ora in poi BGVolterra/FAdS), Cfr. E. Dello Sbarba e S. Trovato, Inventario dell’archivio di Arnaldo Dello Sbarba, «Rassegna volterrana», a. 90, 2013. Per questo articolo sono stati esaminati inoltre archivi privati ancora inediti, custoditi dalla famiglia (d’ora in poi APAdS), l’Archivio di Stato di Pisa, la Biblioteca Capitolare dell’Arcidiocesi di Pisa, la SMSBiblio di Pisa, la Biblioteca delle Oblate e l’Archivio di Stato di Firenze. Un piccolo “fondo Dello Sbarba” è anche presso l’Archivio centrale dello Stato.
(2) Sulle elezioni del 6 aprile 1924 Cfr. R. De Felice, La legge elettorale maggioritaria e le elezioni politiche del 1924, in Mussolini il fascista, 1. La conquista del potere 1921-1925, Torino, Einaudi, 1966. Sulla situazione in Toscana in quel periodo si v. A. Giaconi, La fascistissima: il fascismo in Toscana dalla marcia alla “notte di San Bartolomeo”, Foligno, Il formichiere, 2019.
(3) Cesare Rossi (1887-1967), sindacalista rivoluzionario, interventista, giornalista con Mussolini al «Popolo d’Italia», co-fondatore dei Fasci nel marzo 1919. Mussolini lo incaricò di organizzare la “Ceka fascista” che rapì e uccise Matteotti. Accusato del delitto, in un memoriale indicò Mussolini come mandante. Fu prosciolto in istruttoria. Scappò in Francia, ma fu arrestato nel 1928 e condannato dal Tribunale speciale a diversi anni di carcere e confino. Nel 1947 al nuovo processo Matteotti – in cui chiamò a deporre in suo favore anche Arnaldo Dello Sbarba – venne assolto per insufficienza di prove. Cfr. M. Canali, Cesare Rossi da rivoluzionario a eminenza grigia del fascismo, Il Mulino, Bologna, 1991; M. Franzinelli, Matteotti e Mussolini, Milano, A. Mondadori, 2024.
(4) Cfr. P. Nello, Liberalismo, democrazia e fascismo. Il caso di Pisa, 1919-1925, Pisa, Giardini, 1995. La responsabilità delle vecchie élite dominanti nello sviluppo del fascismo (sottovalutazione o condivisione?) è un nodo storiografico fondamentale, oggi particolarmente attuale. Le élite politiche formatesi in epoca liberale stentarono a comprendere la natura del fascismo e che sarebbe diventato il loro “rottamatore”. Ma furono proprio le vecchie classi dirigenti a contribuire a creare, ciascuna corrente a modo suo, il clima favorevole al fascismo e a sostenerlo. Molti liberali lo tennero addirittura a battesimo. Giovani liberali furono tra i fondatori del fascio di Pisa e mantennero a lungo la doppia militanza. Furono originariamente liberali diversi fascisti di spicco qui citati, come Piero Ginori Conti, Costanzo Ciano, o lo stesso Filippo Morghen. C’era poi la composita galassia dei “democratici” (“democrazia massonica” inclusa) che si era candidata nel 1919 nell’”Unione democratica” e nel 1921 nel “Blocco Nazionale”, sempre con capolista Arnaldo Dello Sbarba. La loro convinta campagna interventista per la guerra come compimento del Risorgimento e rigeneratrice dei popoli incontrò il dannunzianesimo prima e il fascismo poi. A Pisa, dove l’interventismo attingeva al mito di Curtatone e Montanara, il fascismo partì da una generazione di studenti-combattenti motivati da una parte del vecchio corpo docente a combattere il “nemico interno” dei neutralisti, degli anti-nazionali, dei socialisti.
Tra gli interventisti democratici, inoltre, i social-riformisti finirono per sottomettere la lotta di classe agli “interessi della Nazione”, tanto più che nei mesi della neutralità italiana il Partito socialista riformista, cui apparteneva Arnaldo Dello Sbarba, puntellò al potere un liberale di destra come Salandra, già orientato all’intervento e sabotatore dei negoziati con l’Austria. Questo composito “radicalismo nazionale”, intriso di polemica antigiolittiana, antisistema e soprattutto antisocialista, pervase buona parte dell’intellighenzia italiana e nel dopoguerra accompagnò consapevolmente l’ascesa del fascismo, condividendone i valori e spesso anche le azioni.
(5) Bruno Santini, nato a Carrara nel 1895, studente di giurisprudenza a Pisa, capitano degli alpini, avvocato. Alla guida della componente ex combattentistica, animata da toni anti-borghesi, diventa segretario del Fascio di Pisa nel dicembre 1920 e guida gli assalti alla sinistra, ai sindacati, alle leghe rosse, ai sindaci socialisti. Entrerà in conflitto col segretario federale Filippo Morghen e dopo alterne vicende verrà espulso e costretto ad lasciare Pisa nel 1925. Cfr. M. Canali, Il dissidentismo fascista, Pisa e il caso Santini, 1923-1925, Roma, Bonacci, 1983.
(6) Filippo Morghen nasce a Castellina Marittima nel 1882 da una famiglia di incisori e acquafortisti (il nonno Raffaello era al servizio del granduca Ferdinando III). Laureato in giurisprudenza a Pisa, è combattente, avvocato e possidente. Da Filippo Morghen Arnaldo Dello Sbarba aveva acquistato in società col fratello Bruno la cava di alabastro del Marmolajo di Castellina Marittima, dove sindaco era proprio quel Carlo Conti che fu amico, segretario e consigliere di Arnaldo (vedi nota 6). In APAdS sono conservati gli atti di compra-vendita della cava e il relativo carteggio.
(7) Sul “dissidentismo” pisano e il conflitto Santini-Morghen è bene non fermarsi alla semplice dicotomia “normalizzatori contro intransigenti”. C’è infatti da chiedersi quanto di “ideale” ci fosse nei conflitti tra fascisti per i quali, dopo la marcia su Roma, si erano spalancate le porte del potere assoluto. Il controllo del partito consentiva loro di occupare importanti posizioni e ottenere consistenti arricchimenti personali. Più forte del confronto sulle idee, era dunque la lotta per accaparrarsi i rilevanti vantaggi derivanti da un movimento che stava trasformandosi in regime. Vedi i già citati lavori di P. Nello e M. Canali, oltre a M. Mazzoni, Livorno all’ombra del fascio, Firenze, L.S. Olschki, 2009.
(8) Sull’aut aut di Morghen Cfr. il «Messaggero Toscano», 29 febbraio 1924.
(9) Carlo Conti (1879-1943), più volte sindaco di Castellina Marittima ‒ suo feudo politico ‒, amico, segretario particolare e ascoltatissimo consigliere di Arnaldo Dello Sbarba, è stato poeta e giornalista per diverse testate, tra cui: «La nuova Italia», da lui fondato, «La Nazione», «Il Telegrafo», «Il Giornale d’Italia», «Il Ponte di Pisa», «Camicia nera», il giornale della corrente di Santini, di cui era amico. Collaboratore della casa editrice Nistri-Lischi, repubblicano filodemocratico e massone, tentò senza successo di riunificare in un’unica formazione le varie anime della “democrazia massonica” pisana. Nell’aprile 1923 inaugurò il suo terzo mandato da sindaco con un discorso di entusiastico sostegno al governo Mussolini. Cfr. In memoria di Carlo Conti, Lallo, a cura dei giornalisti pisani, Pisa, V. Lischi e figli, 1963, e Discorso di Carlo Conti pronunciato per l’insediamento dell’amministrazione comunale di Castellina Marittima il 20 aprile 1923, Pisa, Nistri-Lischi, 1923, ristampato da Tagete, Pontedera, 2005.
(10) Lettera di Carlo Conti a Bruno Dello Sbarba, fratello minore di Arnaldo, del 24 dicembre 1923 in APAdS.
(11) Giuseppe Della Gherardesca (1876-1968), Conte Palatino, Nobile dei Conti di Donoratico, Patrizio fiorentino, di Pisa e di Volterra, Nobile di Sardegna. Esponente di spicco dell’aristocrazia agraria e del fascismo toscano, dominatore della zona di Castagneto Carducci e Bolgheri. Podestà di Firenze dal 1928 al 1933, Senatore del Regno dal 1929 al 1943, carica da cui decadde nel 1945 in seguito all’epurazione antifascista.
(12) A Quarto il 5 maggio 1915, per il 55° anniversario della spedizione dei Mille, Gabriele D’Annunzio pronunciò, davanti a oltre ventimila persone, un’“orazione” per invocare l’intervento nella guerra contro l’Austria-Ungheria, che ebbe una forte eco e segnò la definitiva egemonia nazionalista sul movimento interventista, agli inizi spinto dall’“interventismo democratico” di personaggi come Leonida Bissolati, compagno di partito di Arnaldo Dello Sbarba.
(13) Lettera di Arnaldo Dello Sbarba a Cesare Rossi del 10 novembre 1923, in BGVolterra/FAdS, Carteggio, b. 4. I documenti citati di seguito, salvo diversa indicazione, si intendono provenienti da questo archivio, stessa posizione.
(14) Arnaldo Fratini (1895-1973) è stato la memoria storica del socialismo a Volterra. Alabastraio, entrato giovanissimo nel PSI, dal 1919 ne fu più volte segretario e consigliere comunale e fu perseguitato dal fascismo. Cfr. A. Fratini, Appunti per una storia del socialismo volterrano, «Volterra», dal n. 9 (set. 1969) al n. 11 (nov. 1970).
(15) «Il Martello» venne fondato il 6 ottobre 1894 dal ventunenne Arnaldo Dello Sbarba con Giulio Topi (nel 1920 primo sindaco socialista di Volterra) sull’onda delle lotte contro il governo Crispi. Il giornale dovette chiudere il 13 settembre 1895 avendo collezionato tre processi in 12 mesi.
(16) Cfr. D. Benvenuti, Le cravatte nere, storie degli anarchici a Volterra, Volterra, Distillerie, 2009.
(17) L’appoggio alla conquista della Libia comportò l’espulsione dal PSI (con una mozione promossa da Benito Mussolini) della corrente riformista di Bissolati e Bonomi di cui faceva parte anche Arnaldo Dello Sbarba. Cfr. M. Degl’Innocenti, Il socialismo italiano e la guerra di Libia, Roma, Editori riuniti, 1976, anche I. Bonomi, Dal socialismo al fascismo, Milano, Garzanti, 1946.
(18) Cfr. Canali, Il dissidentismo fascista…, cit., p. 55.
(19) Athos Gastone Banti (1881-1959), giornalista “spadaccino” (molte sue polemiche finivano in duello) fu amico e sostenitore di Arnaldo Dello Sbarba. Redattore capo del «Telegrafo», corrispondente di guerra per il «Giornale d’Italia», dal 1919 al «Nuovo Giornale» di Firenze, organo ufficioso degli ambienti massonici, la cui sede venne data alle fiamme nel 1924 dai fascisti. In seguito Banti torna al «Giornale d’Italia», ma finisce nei guai con Mussolini per un articolo sul caffè bevuto dal Duce in tempi d’autarchia. Nel dopoguerra fonda e dirige «Il Tirreno» di Livorno fino al 1957. Filippo Filippelli (1890-1961), fascista della prima ora, giornalista dal 1920 al «Popolo d’Italia», nel 1922 diventa segretario di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce. Nell’aprile 1923 è azionista, amministratore delegato e direttore del «Corriere Italiano», creato dai vertici fascisti con fondi messi a disposizione da gruppi industriali come Ansaldo, Eridania, Ilva, Fiat ecc. Il giornale funzionava anche come collettore di finanziamenti occulti gestiti da Arnaldo Mussolini per il fascismo e per la stessa famiglia Mussolini. Filippelli fornì a Amerigo Dumini (per il «Corriere italiano» ispettore delle vendite) la Lancia con cui Matteotti venne rapito ed ucciso. Ricercato, rivelò in un memoriale l’esistenza della “Ceka del Viminale”, comandata da Dumini. Venne arrestato il 17 giugno 1924 e due giorni dopo il giornale cessò le pubblicazioni. A proposito di fondi, nell’archivio Arnaldo Dello Sbarba (BGVolterra/FAdS, carteggio, b. 4) esistono le lettere indirizzate ad Arnaldo, firmate dal direttore dello stabilimento Solvay di Rosignano, che accompagnano quattro assegni di £ 5.000 ciascuno emessi dalla Solvay a favore dei due giornalisti: due intestati a Filippelli datati 22 febbraio e 27 marzo 1924, due intestati a Banti datati 14 aprile e 7 maggio 1924. Arnaldo fa da intermediario tra la Solvay e i beneficiari.
(20) Piero Ginori Conti (1865-1939), Principe di Trevignano, conte palatino, nobile romano, patrizio di Firenze e di Pisa e nobile di Livorno. Parlamentare dal 1900 al 1921. Sposa Adriana del Larderel e ne eredita le proprietà. Alla guida della Società Boracifera Larderello, inventa lo sfruttamento della geotermia per produrre elettricità. Crea il primo fascio fuori dalla città di Pisa e stronca così lo sciopero del 1920 alla Boracifera, imponendo l’eliminazione di molti diritti, licenziamenti di massa e successivamente l’obbligo di iscrizione al PNF per i dipendenti. Sostenitore di Mussolini, alla sua morte il fascismo lo celebra con funerali di Stato. Cfr. il volume apologetico di R. Martinelli, Il fascismo a Larderello, Firenze, Sansoni, 1934. Inoltre, M. Fontani e M. G. Costa, Come la chimica Toscana si prostrò di fronte al fascismo: il caso di Piero Ginori Conti, https://chimicanellascuola.it/index.php/cns/article/view/chimica-toscana-fascismo-il-caso-piero-ginori-conti/65
(21) Promemoria Carlo Conti, due pagine scritte a mano: “Chiedere chi, a proposito di sindaci rossi, aiutò il Comune di Cascina a liberarsi del famigerato sindaco Guelfi, insistendo presso l’autorità governativa e giudiziaria perché promuovessero un’inchiesta amministrativa contabile prima, la procedura penale poi? Il prefetto Malinverno dirà che tutta questa opera fu compiuta dall’onorevole Dello Sbarba (…)”. Su Giulio Guelfi (1888-1939) Cfr. Massimiliano Bacchiet, “Guelfi Giulio” in ToscanaNovecento: https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/16235-guelfi-giulio?i=12. Renato Malinverno fu prefetto filofascista di Pisa dal 1° settembre 1921 al 14 aprile 1924.
(22) Promemoria Fagioli: sette pagine scritte a mano intestate Camera dei Deputati. “Si venne alle elezioni del 1921 e Dello Sbarba fu accolto come capo del Blocco Nazionale (…). In quell’occasione corse tutta la circoscrizione, parlando patriotticamente ed esaltando le nuove correnti del fascismo (…). A Volterra, dove nel 1919 i bolscevichi avevano proibito a Dello Sbarba l’entrata, egli fu ricevuto trionfalmente da cortei capitanati dai fascisti Pedani, Maffei ecc. (…)”. Paolo Pedani era ispettore della zona di Volterra, Gherardo Maffei segretario del fascio di Volterra e commerciante di alabastro. Nel 1924 entrambi furono protagonisti della campagna contro la candidatura Dello Sbarba.
(23) Il commando fascista che uccise Carlo Cammeo era composto dallo studente Elio Meucci, da Mary Rosselli-Nissim, figlia di un patriota mazziniano e fanatica attivista interventista durante la Prima guerra mondiale, e da Giulia Lupetti, figlia del comandante del presidio militare di Pisa. Cfr. Massimiliano Bacchiet, Un’ora di dolore per il proletariato pisano, in ToscanaNovecento: https://www.toscananovecento.it/custom_type/unora-di-dolore-per-il-proletariato-pisano/
(24) Il 21 luglio 1921, Sarzana fu attaccata da una colonna di circa 500 squadristi comandati da Amerigo Dumini, ma stavolta furono affrontati da Carabinieri e Guardie regie, cui seguì la resistenza antifascista spontanea della popolazione e degli Arditi del Popolo. Fu uno dei pochi episodi di resistenza armata ai fascisti, che ebbero diversi morti e feriti e molti arrestati.
(25) Tito Menichetti, giovane fascista ex ufficiale, fu ucciso il 25 marzo 1921 durante una spedizione punitiva a Ponte a Moriano e celebrato come il “primo martire” del fascismo pisano. I Fasci organizzarono i suoi solenni funerali cui parteciparono tutte le istituzioni. L’Università accolse il feretro in Sapienza con la partecipazione del senato accademico oltre che del Rettore Ermanno Pinzani, che poi, sugli studenti universitari fascisti caduti nel 1921, così scrisse : Nell’anno scolastico testé decorso (…) quei martiri (…) hanno offerto la loro vita giovanile, preziosa e piena di entusiasmi in olocausto ai santi ideali di patria, giustizia e libertà”. Cfr. E. Pinzani, Inaugurazione degli studi. Relazione del Rettore, «Annuario della R. Università di Pisa per l’Anno Accademico 1921/1922», Pisa, Tip. Mariotti, 1922, p. 24.
(26) Nel corteo che attraversa “una città imbandierata”, Arnaldo Dello Sbarba è in prima fila insieme al sindaco Buffarini Guidi, al prefetto Malinverno, al senatore Supino e al deputato Ruschi. Cfr. «Messaggero toscano», 29 ottobre 1923.
(27) Cfr. «Messaggero Toscano», 21 febbraio 1924.
(28) Dario Lischi “Darioski” (1891-1938), giornalista, colonna dell’«Idea fascista», organo della federazione fascista pisana, del cui consiglio federale fu più volte membro, autore di numerosi libri, tra cui La marcia su Roma con la colonna Lamarmora (1923), Viaggio di un cronista fascista in Cirenaica (1934) e Tripolitania Felix (1937). Cfr. P. Nello, Liberalismo, democrazia e fascismo…, cit., p. 136.
(29) “Medoro” nomignolo dato dai pisani a Filippo Morghen a causa delle sue traversie coniugali. Ispirato alle vicende di Angelica nell’Orlando Furioso.
(30) Sandro Carosi (1899-1965), uomo di fiducia di Morghen, era farmacista e sindaco di Vecchiano, definito dal prefetto Malinverno «uno squilibrato per temperamento violento». Tra gli altri, uccide a freddo il tipografo Ugo Rindi l’8 aprile del 1924. Ebbe il compito di minacciare ripetutamente Arnaldo Dello Sbarba. Giuseppe Biscioni, “ras” di Calci, partecipò all’assassinio Rindi. Daniele De Guidi era il “ras” di Rosignano Marittimo. Lamberto Parenti era squadrista a Cascina e Navacchio. Francesco Giunta (1887-1971), segretario del PNF dal 1923 al 1924 e parlamentare dal 1921 al 1943, fu il persecutore della minoranza slovena di Trieste. Nel 1945 la Jugoslavia lo dichiarò criminale di guerra, ma l’Italia non concesse l’estradizione.
(31) L’ordine del giorno dei sindaci e la lettera del sindaco di Collesalvetti viene spedita da Carlo Conti ad Arnaldo il 19 febbraio 1924.
(32) Guido Buffarini Guidi (1895-1945), laureato in Giurisprudenza, volontario nella Prima guerra mondiale, massone nella loggia Darwin di Pisa. Avvocato e sindaco fascista di Pisa dove fu anche podestà e federale, membro del Gran consiglio del fascismo, sottosegretario agli interni (1933-1943), fu ministro dell’Interno nella Repubblica Sociale Italiana e corresponsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Venne fucilato dai partigiani il 10 luglio 1945.
(33) Lando Ferretti (1895-1977), combattente di due guerre, capo-corso alla scuola Normale di Pisa, deputato fascista dal 1924 al 1939. Dirigente sportivo, in era fascista fu presidente del CONI e commissario della Federazione italiana gioco calcio. Nel 1942 tenne una conferenza a Firenze nel 1942 indicando “il comune nemico nel trinomio giudaismo, plutocrazia, bolscevismo” e proponendo la ghettizzazione degli ebrei. Nel dopoguerra fu a lungo senatore del MSI (1953-1968) e membro del comitato organizzatore delle olimpiadi di Roma del 1960.
(34) Cfr «Il Messaggero Toscano» del 21 febbraio 1924.
(35) Mario Supino (1879-1938), avvocato, collega e amico di Arnaldo, già dirigente dell’Associazione nazionale combattenti di Pisa, per conto della massoneria si candidò alle elezioni politiche del 1924 nella lista democratico sociale, con scarso successo. Augusto Mancini (1875-1957) fu docente di filologia all’università di Pisa. Interventista, deputato repubblicano dal 1913 al 1924. Primo presidente del CLN di Lucca e primo rettore dell’università di Pisa liberamente eletto.
(36) Guido Donegani (1877-1947) fu presidente della società Montecatini, deputato del partito fascista dal 1921 al 1939, massone. Nel 1921 era stato eletto con Arnaldo Dello Sbarba nella lista dei “Blocchi Nazionali”. Gino Sarrocchi (1870-1950), deputato della destra liberale dal 1913 al 1929, ministro ai Lavori pubblici del primo governo Mussolini, si dimise dopo il delitto Matteotti. Nel 1929 fu nominato senatore. Dopo il 25 luglio 1943 si ritirò a vita privata. Gino Aldi Mai (1877-1940) eletto deputato a Siena in una lista agraria-liberale che poi confluisce nel PNF, rieletto dal 1924 al 1934, poi nominato senatore.
(37) APAdS, minuta a mano di 15 pagine in piccolo formato intestate “Camera dei Deputati”.
(38) In APAdS.
(39) Cfr. «La Nazione» del 17 giugno 1924, che cita indiscrezioni su possibili nomi.
(40) Cfr. R. De Felice, Mussolini il fascista, 1. La conquista del potere 1921-1925, cit., cap. 7: Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio.
(41) Cfr. M. Canali, Il dissidentismo fascista…, cit., pp. 80-83.
(42) Lettera del 26 agosto 1925, in APAdS.
 Riccardo Dello Sbarba
Riccardo Dello Sbarba
Volterra, 1954. Laureato in filosofia a Pisa, docente di ruolo, giornalista professionista. Fin da giovanissimo partecipa ai movimenti degli studenti medi e universitari, milita nel gruppo del “Manifesto” di Pisa e scrive corrispondenze per il quotidiano. Dal 1986 al 1988 è nominato dalla Regione Toscana nel CdA del Parco di S. Rossore. Collabora con «Il Tirreno». Nel 1988 si trasferisce a Bolzano, dove lavora al quotidiano «Alto Adige» fino al 1992, al settimanale in lingua tedesca «ff» fino al 2001 e dirige il quotidiano «Il Mattino» fino al 2003. Cura il volume: Alexander Langer, Scritti sul Sudtirolo – Aufsätze zu Südtirol, Merano, A&B, 1996 ed è autore di: Südtirol-Italia: Il calicanto di Magnago e altre storie, Trento, Il Margine, 2003. Per quattro legislature, dal 2004 al 2023, è consigliere per i Verdi del Sudtirolo nel Consiglio provinciale di Bolzano, di cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Collabora alla Biblioteca F. Serantini su temi inerenti la storia politica e sociale della provincia di Pisa.