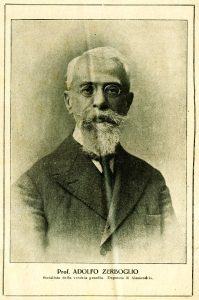La vita di Idalberto Targioni: una ricostruzione attraverso le carte d’archivio

Il fondo Idalberto Targioni viene depositato nel 2019 presso l’archivio dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea da Simonetta Chiappini, erede delle carte familiari. Si tratta di un archivio di persona composto da materiali prodotti dal soggetto e da documentazione raccolta e conservata postuma dagli eredi.
Il fondo Targioni consente di ricostruire la vicenda di una figura insieme affascinante e contraddittoria. Nato trovatello, Targioni porta con sé per tutta la vita lo stigma delle origini, sintetizzato nell’epiteto con cui veniva appellato da ragazzino, “il Bastardo”. Contadino autodidatta, si costruisce uno spazio di riconoscimento pubblico grazie alla parola: diventa un abile poeta estemporaneo, capace di imporsi nelle gare di improvvisazione e di conquistare il soprannome di “Usignolo”.
Militante socialista e acceso anticlericale, diventa protagonista della vita politica locale, ottenendo il soprannome di “Diavolo Rosso” e arrivando a ricoprire la carica di sindaco di Lamporecchio. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, inizialmente schierato su posizioni neutraliste, si converte all’interventismo e successivamente al fascismo, fino a diventarne uno dei principali esponenti nel territorio pistoiese. Questo passaggio segna una frattura profonda nella sua vita, nonché nella memoria pubblica del personaggio: Targioni diventa “il Convertito”, e la sua parabola politica e personale conosce una progressiva marginalizzazione, fino a cadere nell’oblio.
Una prima restituzione complessiva della figura di Targioni è offerta dal lavoro del Prof. Roberto Bianchi, che nel 2018 pubblica Una storia, un archivio. Idalberto Targioni nell’Italia tra Ottocento e Novecento[1], volume che rappresenta un primo punto di riferimento per la ricostruzione biografica del personaggio. Nell’appendice del libro trovano spazio l’elenco di consistenza dell’archivio, curato da Daniele Lovito, e una significativa testimonianza dell’erede Simonetta Chiappini.
La vicenda di Idalberto Targioni permette di interrogare, attraverso una prospettiva microstorica, alcuni nodi centrali della storia italiana tra Ottocento e Novecento: la formazione politica dei ceti popolari, il rapporto tra autodidattismo e militanza, le fratture prodotte dalla guerra e il passaggio di una parte del socialismo al fascismo. In questo senso, lo studio del fondo Targioni offre un osservatorio privilegiato sugli intrecci tra esperienza individuale e processi storici più ampi.
Idalberto Targioni nasce a Firenze il 19 ottobre del 1868, quando la città era capitale del Regno d’Italia. A poche ore dalla nascita viene portato dalla levatrice Irene Gragnani allo Spedale degli Innocenti insieme al segno di riconoscimento (un pezzo di tela verde ricamata) destinato a consentire un eventuale riscatto del bambino, ancora oggi conservato presso l’archivio dell’istituzione.
Battezzato col nome di Edelberto, inizia subito l’iter riservato agli esposti. I tenutari cui viene affidato sono contadini, in linea con le politiche dello Spedale degli Innocenti che, in accordo con l’Accademia dei Georgofili, individuano nel mondo mezzadrile l’unico sbocco lavorativo, sociale ed economico per i trovatelli. Questo sistema orienta da subito il destino sociale dei gettatelli toscani, inscrivendoli in un orizzonte di lavoro agricolo e di subalternità che Targioni cercherà sempre di oltrepassare.
Nella sua autobiografia inedita e dattiloscritta – Cinquant’anni della mia vita – Targioni racconta della sua infanzia e adolescenza, di come siano state segnate dalla costrizione del mondo rurale e da episodi di sfruttamento, dalla volontà di emanciparsi, dalle punizioni, nonché da un costante senso di impotenza che traduce in una aggressività difficile da contenere[2].
Dopo vari passaggi presso famiglie affidatarie, i tenutari dai quali si stabilizza sono Domenico e Giuditta Capecchi, del Popolo di San Baronto, nel comune di Lamporecchio a Pistoia. Pur impiegato come forza lavoro, impara a leggere e scrivere da autodidatta. Insofferente alla disciplina e profondamente ostile al lavoro dei campi, Targioni non sopporta di ubbidire ai comandi del padre. In più occasioni si allontana da San Baronto; una delle sue fughe più significative riguarda il periodo, tra il 1885 e il 1887, quando lavora alle Caldine, nel comune di Fiesole, alla costruzione della linea ferroviaria Firenze–Cecina. Qui si rende conto che le ingiustizie non dominano solo nelle campagne, ma anche tra gli operai nelle città. Il contatto col mondo del lavoro operaio favorisce l’incontro con la politica e col socialismo: sono gli anni della Seconda Internazionale e per Targioni la moderna tendenza del socialismo si innesta sul suo persistente desidero di riscatto, dando avvio a un impegno politico che nasce dal basso e si fa progressivamente più ambizioso.
Parallelamente, Targioni non smette mai di lavorare alla sua formazione. Racimola libri come può, impara molti classici a memoria e costruisce un patrimonio di letture che eccede di molto rispetto a quello tipico del mondo contadino. In linea con la tradizione della poesia estemporanea, diventa un eccezionale esempio di prontezza nell’improvvisare ottave cantando. Partecipa a molte gare di poesia – contrasti o contraddittori – alcune delle quali sono state da lui riscritte a mano o a macchina e sono oggi conservate nel fondo Targioni. I temi spaziano dalle donne, alla natura, alla politica. Alcuni dei suoi canti conobbero una notevole fortuna, diffondendosi oralmente tra Pistoia e Firenze e mantenendosi vivi nella memoria locale.[3]
Accanto all’attività estemporanea, Targioni pubblica diversi componimenti. Tra questi, il Canzoniere di poesie popolari (1895) e il Canzoniere di poesie sociali (1912). Il primo, tratta prevalentemente di temi bucolici e idilliaci, sebbene nelle poesie coeve rimaste manoscritte emerga già un deciso interesse per la cosa pubblica e la giustizia sociale. Il secondo, è invece dedicato interamente a temi socialisti. Un socialismo che risulta di stampo umanitario e risorgimentale, povero di basi teoriche marxiste che dimostra di conoscere solo in modo superficiale.
Stabilizzatosi di nuovo a Lamporecchio nel 1891, Targioni si sposa e diventa padre della sua prima figlia, Velia. Tuttavia, la vita matrimoniale entra in crisi: Idalberto intrattiene diverse relazioni extraconiugali, la più rilevante con Sofia Bacarelli, dalla quale ha una figlia, Idalberta.; la convivenza con Sofia dura fino alla morte di lui, come attestano le lettere tra Sofia e Velia.
Nel 1895 si iscrive al Partito Socialista Italiano e inizia una costante e impegnata militanza politica. È affascinato dalla prospettiva offerta dall’ideologia socialista da lui descritta come «la migliore, la più giusta, l’unicamente vera, […], fulgidamente bella»[4].
Nel 1901, in un contesto locale privo di organizzazioni socialiste strutturate, Targioni contribuisce alla fondazione di un circolo di Studi Sociali a Lamporecchio. Nel 1898 affida il manifesto del proprio credo politico al componimento Un colloquio con la mia musa, scritto durante la detenzione nel carcere delle Stinche di Pistoia in occasione dei moti del maggio ‘98. Attraverso la personificazione della musa-socialismo, il testo restituisce l’adesione ideale e militante a una causa percepita come strumento di emancipazione degli “infelici” [5].
L’impegno per la propaganda socialista continua assiduamente in giro per la Toscana e anche all’estero. Il primo riconoscimento che Targioni ottiene arriva nel 1901, quando viene eletto consigliere comunale a Lamporecchio. Insieme a lui, venne scelto anche l’amico Domizio Torrigiani[6], un avvocato che avrebbe fatto carriera nel Grande Oriente, una delle più strutturate logge massoniche d’Italia. Targioni in questo periodo scrisse su vari periodici, quali: «La Martinella» di Colle Val d’Elsa dal 1899 al 1901, «l’Avvenire» di Pistoia dal 1901 al 1915 – ne fu direttore dal 1908 al 1913 –, «Vita nuova di Empoli» dal 1901 al 1915.
Nel biennio 1911-1912, Targioni si distingue come protagonista della campagna socialista contraria alla guerra in Libia: le sue conferenze in versi e i suoi articoli su «l’Avvenire» gli valgono un elogiativo articolo in prima pagina sull’ «Avanti!», dove viene definito «uno dei nostri più ferventi e modesti propagandisti del socialismo»[7].
Tra il 1913 e il 1914 inizia per Targioni una fitta campagna elettorale: si candida per il PSI alle elezioni politiche del 1913 per il Collegio di Pistoia I. Anche se non viene eletto, per Targioni si sta avvicinando l’opportunità più importante della sua carriera politica da socialista. Il momento che segna l’apogeo del suo percorso politico, è l’elezione a sindaco di Lamporecchio nel 1914, unitamente alla nomina di consigliere comunale a Cerreto Guidi (FI). L’amministrazione Targioni è la prima socialista del circondario di Pistoia.
Tuttavia, la sua posizione di sindaco si incrina ben presto: la riforma tributaria varata da Targioni per finanziare un ambizioso programma riformatore incontra l’ostilità di una ristretta cerchia di notabili locali, verosimilmente timorosi che il nuovo sistema fiscale possa intaccare le loro ricchezze; questi trovano un alleato nel segretario comunale, entrato in contrasto con il sindaco per motivi apparentemente marginali. A ciò si aggiunge l’attenzione delle autorità prefettizie, che sottopongono l’operato dell’amministrazione a continui controlli, ufficialmente motivati da presunti favoritismi in materia fiscale ma sostanzialmente volti a colpire uno dei principali esponenti del neutralismo pistoiese.
Con l’approssimarsi dell’entrata in guerra dell’Italia, Targioni viene arrestato con l’accusa di aver fomentato manifestazioni antibelliciste a Empoli. L’episodio segna un punto di svolta decisivo: sentendosi abbandonato dai compagni di partito e percependo l’inevitabilità del conflitto, si sposta su posizioni interventiste e decide di uscire dal Partito Socialista Italiano; per coerenza rassegna le dimissioni da consigliere comunale a Cerreto Guidi e da sindaco di Lamporecchio, ma queste ultime non vengono accettate e Targioni continua a guidare il Comune nel pieno del conflitto.
Nel primo dopoguerra, ormai orientato verso posizioni sempre più nazionalistiche e bollato dai suoi ex compagni come traditore, viene duramente contestato dai socialisti durante un comizio al teatro Berni di Lamporecchio in occasione delle festività pasquali; il 14 giugno viene infine costretto a lasciare la carica di primo cittadino[8]. Si avvicina progressivamente al fascismo, diventando uno dei principali animatori nel Montalbano e nei territori limitrofi. Nel 1921 fonda il Fascio di combattimento di Lamporecchio e si afferma come attivo propagandista nelle provincia fiorentina, affiancando all’azione politica un’intensa attività giornalistica: collabora con periodici fascisti — tra cui «Giovinezza» (1921-1923), «La Riscossa» (1921-1922), «L’Azione fascista» (1922-1923) e «Battaglia fascista» (1924-1926) — e fonda due testate proprie, «L’Alleanza» (1921) e «L’Ordine» (1922).
Nel 1923 viene nominato segretario dei sindacati fascisti per l’agricoltura della provincia di Firenze e nel 1924 è eletto consigliere provinciale. Nonostante questi incarichi, i suoi rapporti con gli apparati del Partito nazionale fascista si deteriorano progressivamente: deluso dallo scarso riconoscimento ottenuto per il lavoro svolto, Targioni si ritira gradualmente dalla vita pubblica. Minato da cattive condizioni di salute e da ristrettezze economiche, muore a Lamporecchio il 25 maggio 1930.
Il fondo Idalberto Targioni consta di quattordici buste archivistiche e di circa duecento volumi a stampa; al termine del lavoro di inventariazione, curato da Marta Bonsanti, la documentazione viene organizzata in sette serie, restituendo una struttura coerente a un corpus documentario ampio e articolato. La prima serie raccoglie la corrispondenza di Targioni, familiare e non; la seconda e la terza comprendono la produzione edita e inedita di carattere letterario e politico; la quarta è dedicata alla documentazione relativa al fascio di Lamporecchio e alle organizzazioni sindacali fasciste; la quinta conserva i documenti personali, tra cui atti giuridici e materiali fotografici; la sesta riunisce materiali a stampa, in parte riconducibili alla biblioteca privata del soggetto produttore; l’ultima serie è composta da documentazione prodotta o raccolta dai familiari, in larga misura postuma.
Per ricostruire la sua vita sono stati altresì consultati: l’Archivio dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze, il Casellario Politico Centrale, l’Archivio del Comune di Lamporecchio, l’ Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura di Pistoia e l’Archivio della Questura di Firenze.
Il fondo Targioni non è solo un insieme di documenti ma una finestra aperta su una vita immersa nelle grandi trasformazioni politiche e sociali a cavallo tra Ottocento e Novecento. È una memoria viva, che continua a parlare a chi la interroga, offrendoci la possibilità di ripensare il passato e di scoprire nuove sfumature di una figura complessa come quella di Idalberto Targioni.
Nel solco del lavoro del Prof. Roberto Bianchi, la figura di Targioni è stata indagata e approfondita dalle ricerche di Giulia Bruni – confluite nella sua tesi magistrale Idalberto Targioni. L’uomo, il poeta e il politico. Una biografia dalla nascita alla Grande Guerra, Università di Firenze, 2024 – e di Andrea Cerofolini che, nella sua tesi magistrale attualmente in fase di stesura, ha proseguito l’indagine concentrandosi sulla seconda parte della vita di Targioni, segnata dall’adesione al fascismo.
[1] Roberto Bianchi, Una storia, un archivio. Idalberto Targioni nell’Italia tra Ottocento e Novecento, Firenze, Firenze University Press, 2018
[2] Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT), fondo Idalberto Targioni, S.II Manoscritti di Targioni, B.6, Segnatura II.5.1, Cinquant’anni della mia vita (ricordi e memorie), 1920, pagine non numerate.
[3] Su questo si può consultare l’intervista a Florio Londi, Carmignano (PO) del 14/02/1993. Testimonianza orale rilasciata a Giovanni Contini e Doriano Cirri, conservata presso Archivio della cultura contadina, Comune di Carmignano. L’intervista completa si trova alla pagina web: https://www.comune.carmignano.po.it/output_allegato.php?id=409448 consultata il 16/05/2024.
[4] Cinquant’anni, cit., pp. nn.
[5] «La Martinella», I.Targioni, Un colloquio con la mia musa, 1° maggio 1899.
[6] Il fondo Domizio Torrigiani è stato donato dagli eredi all’Isrt nel 2010.
[7] «Avanti!», T.Tosi, Un poeta socialista improvvisatore, 26 settembre 1911.
[8] L’intera vicenda è ricostruita dal punto di vista del protagonista in I.Targioni, Vent’anni di propaganda e cinque anni d’Amministrazione Socialista nel Comune di Lamporecchio, Tipografia Grazzini, Pistoia, 1920.