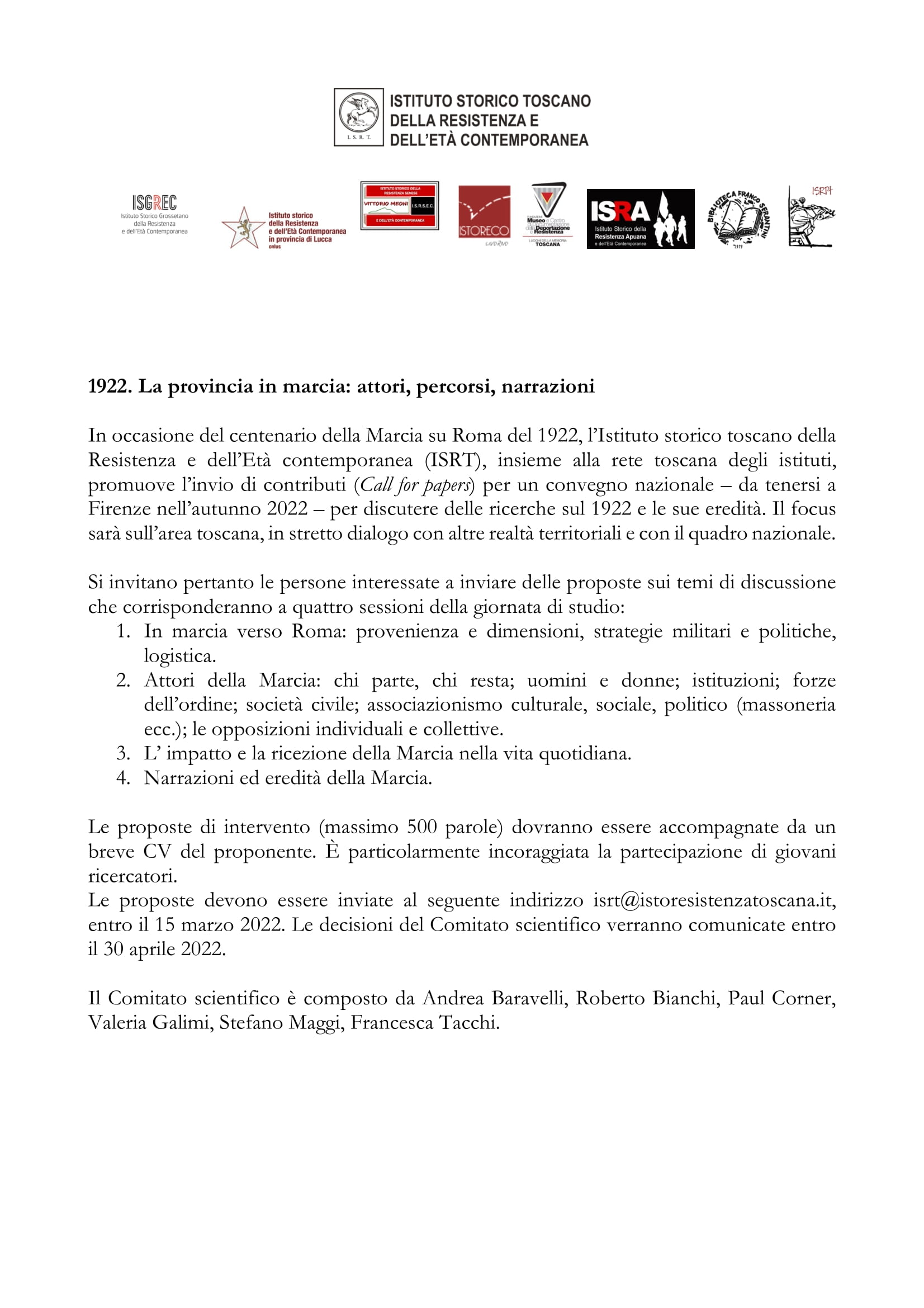L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT), nell’ambito dell’attività culturale triennale sostenuta dal Comune di Firenze e in collaborazione con MAD – Murate Art District bandisce, per l’anno scolastico 2021/2022, la seconda edizione del contest Generation Florence 2020, denominato
Next Generation Florence 2022: gioventù ribelle
rivolto alle/gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Firenze, frequentanti regolarmente le classi quarte e quinte.
ALLEGATI per partecipazione al bando sulla pagina del Contest sul sito ISRT
Bando
Art. 1 Finalità
Alla vigilia delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, l’ISRT invita le/gli studentesse/i a diventare protagoniste/i di una rinnovata narrazione sulla Resistenza quale snodo identitario della città di Firenze. Obiettivo del contest è quello di creare un percorso entro il quale le/i partecipanti possano esprimere le loro riflessioni, sensazioni o vissuto su una tematica relativa ad avvenimenti sviluppatisi in un contesto e in un tempo distante dalla loro realtà, ma che mostrano affinità con la contemporaneità da loro vissuta. In tal senso, i seminari proposti saranno volti a indirizzare una riflessione personale e collettiva sul tema perno del contest.
Il concorso intende così promuovere un avvicinamento alla storia contemporanea e, nello specifico, alla storia di Firenze nella Resistenza; ulteriore obiettivo del progetto è, dunque, la promozione della creatività e del protagonismo intellettuale e artistico delle/gli studentesse/i coinvolte/i, che saranno chiamate/i ad agire attraverso una nuova forma di interazione culturale declinata mediante forme e linguaggi per loro di uso quotidiano.
Altro obiettivo del concorso è porre in contatto le/gli studentesse/i con realtà culturali presenti sul territorio fiorentino, che si contraddistinguono per il loro elevato profilo culturale e professionale.
Art. 2 Destinatari
È ammesso a partecipare al contest chi frequenta le classi quarte e quinte di una delle scuole secondarie di secondo grado con sede nel Comune di Firenze. La partecipazione è individuale, libera e non vincolata all’appartenenza ad un corso di studi specifico.
Art. 3 Tematica di sviluppo degli elaborati
L’opera prodotta dai partecipanti dovrà essere sviluppata all’interno del tema proposto. L’aderenza al tema è vincolante per la partecipazione al concorso:
Resistenze/esistenze: Resistenza nella sua dimensione rinnovata e ampliata di esistenze giovani, fra scelte difficili e lotte per un mondo in cambiamento.
Art. 4 Categorie
Le/i partecipanti potranno restituire la propria visione della tematica oggetto del contest attraverso l’uso di uno dei seguenti linguaggi:
Narrativa: saggio, racconto o intervista (anche fittizia). Le/I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, in formato digitale, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza del testo non dovrà superare le 12.000 battute, note e spazi compresi, e sarà accompagnato da una Guida alla lettura di un massimo di 2.000 battute, note e spazi compresi.
Fotografia: le/i partecipanti potranno presentare un book, in formato digitale, con un minimo di 5 e un massimo di 10 fotografie di loro produzione, rigorosamente inedite, accompagnate da una Guida alla lettura di un massimo di 2.000 battute, note e spazi compresi.
Art. 5 Percorso formativo
È previsto un percorso formativo, composto di seminari e incontri online, volto a stimolare riflessioni e approfondimenti sulla tematica oggetto del presente e/o sui linguaggi espressivi indicati all’Art. 4 Categorie del presente bando.
Gli incontri saranno svolti online nel periodo compreso fra i mesi di marzo e maggio e saranno così organizzati:
- n. 2 seminari, che verteranno su Scelte e sui Luoghi della Resistenza, a cura dell’ISRT;
- n. 1 workshop e/o consulenza, che verterà su Tecniche narrative;
- n. 1 workshop e/o consulenza, che verterà su Linguaggio delle immagini;
- n. 1 incontro, che verterà su Scelte e percorsi della Creatività, a cura della direttrice del MAD – Murate Art District dott.ssa Valentina Gensini, con l’eventuale partecipazione di artiste/i in residenza presso il MAD.
Per maggiori info e dettagli su orari e temi si rimanda all’All. 4 – Percorso formativo e al sito www.istoresistenzatoscana.it.
L’ISRT rilascerà un attestato di partecipazione per gli incontri seguiti.
Le/i partecipanti sono invitati a frequentare il percorso formativo; tuttavia l’adesione al percorso non è vincolante per la partecipazione al contest.
Il numero minimo di iscritti utili per l’attivazione dei workshop è di 10 partecipanti.
Art. 6 Premiazione
La premiazione dei primi, secondi e terzi classificati di ogni categoria avverrà presso MAD – Murate Art District in data da concordare, nel mese di ottobre 2022; qualora non fosse possibile, verrà effettuata online. Contestualmente, le opere vincitrici saranno esposte presso il MAD – Murate Art District in occasione della premiazione.
Il riconoscimento corrisposto per i primi tre classificati è di tipo culturale.
Art. 7 Premi
I premi sono così suddivisi:
1° classificata/o
Categoria Narrativa: workshop organizzato in collaborazione con La Scuola di Editoria
Categoria Fotografia: n. 1 buono iscrizione corso/workshop del valore di 100€ in collaborazione con l’Associazione culturale Deaphoto
2° classificate/i
n.1 abbonamento non nominale, di 5 ingressi, presso il cinema Spazio Alfieri
3° classificate/i:
n.1 buono spesa per l’acquisto di libri da spendere nella Libreria Claudiana o nella Libreria Florida
Art. 8 Iscrizione
L’iscrizione al contest prevede la compilazione digitale (PDF compilabile) del modulo di partecipazione (Allegato 1), nel quale andranno riportati:
- Nominativo
- Età
- Scuola di appartenenza
- Categoria scelta
- Eventuale adesione al percorso formativo (workshop e/o seminari).
Il file andrà poi rinominato: Categoria_CognomePrimaLetteraNome_Allnumero.pdf, dove la categoria è codificata in Narrativa e Fotografia (es. Narrativa_RossiG_All1.pdf).
Verrà inoltrata una mail di conferma di avvenuta iscrizione.
L’iscrizione, gratuita, deve pervenire all’ISRT tassativamente entro il 10 marzo 2022, pena l’esclusione dal contest.
Il modulo di partecipazione al concorso e al percorso formativo dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo e-mail: nextgenerationflorence@gmail.com.
Art. 9 Comunicazione e esperienze condivise
I/le partecipanti sono invitati/e a condividere riflessioni e fasi del processo creativo sulla pagina Facebook dell’ISRT, attraverso tag e hashtag relativi all’ISRT e al concorso stesso (@istoresistenzatoscana, #isrt, #nextgf2022, #nextgenerationflorence) e agli enti che collaborano al contest, al fine di creare una piazza virtuale nella quale poter entrare in contatto con gli altri/e partecipanti.
La condivisione di riflessioni e fasi del lavoro non è obbligatoria, non è vincolante per la partecipazione al concorso e non verrà esaminata ai fini della valutazione finale.
Art. 10 Invio elaborati
Gli elaborati, corredati di modulistica predisposta (Allegato 2 e Allegato 3 – Guida alla lettura), dovranno essere inoltrati tassativamente entro il 15 giugno 2022, pena l’esclusione dal contest, tramite invio per posta elettronica all’indirizzo nextgenerationflorence@gmail.com.
Gli allegati andranno rinominati:
Categoria_CognomePrimaLetteraNome_Allnumero.pdf
(es. Narrativa_VerdiM_All.2.pdf)
l’elaborato:
Categoria_CognomePrimaLetteraNome_Titolo
(es. Narrativa_VerdiM_Il mio lavoro).
I file inviati che peseranno più di 25 MB, potranno essere inviati attraverso la piattaforma WeTransfer (wetransfer.com).
Verrà inoltrata una mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Se all’atto di presentazione della modulistica il partecipante risulterà minorenne, sarà necessaria e obbligatoria anche la firma di un genitore o tutore.
Le opere partecipanti al contest non saranno restituite.
Art. 11 Collaborazioni
Il concorso è frutto della collaborazione fra l’ISRT e il MAD – Murate Art District (www.murateartdistrict.it/) e La Scuola di Editoria (lascuoladieditoria.net/) relativamente alla giuria, all’organizzazione del percorso formativo e all’elargizione dei premi; l’Associazione culturale Deaphoto. Didattica e Progettazione fotografica (www.deaphoto.it), lo Spazio Alfieri (www.spazioalfieri.it/), la Libreria Florida (www.libreriaflorida.it/) e Libreria Claudiana (www.claudiana.it/pagina/libreria-di-firenze-1.html) relativamente all’elargizione dei premi.
Art. 12 Selezione
La giuria è composta da esperti e da rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto, con una collaborazione a titolo gratuito. La giuria dovrà individuare i vincitori assoluti di ogni sezione e i secondi e terzi classificati. Le valutazioni della giuria saranno insindacabili.
Art. 13 Pubblicazione bando e comunicazioni
La segreteria organizzativa è curata da:
Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea
Indirizzo: via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze
Telefono: +39 3393476715
Sito: www.istoresistenzatoscana.it
E-mail: nextgenerationflorence@gmail.com
Orari: lunedì al venerdì dalle ore 9:30 – 13:00
Il bando, le informazioni e le comunicazioni relative al concorso sono resi pubblici nel sito indicato, nella sezione Didattica.
La modulistica, la richiesta di informazioni e le comunicazioni avverranno attraverso l’indirizzo e-mail indicato.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali saranno trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia dei dati personali e saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate, come enunciate nel presente bando. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso e dalle iniziative di cui all’art. 5, art.8 e art.10.
Art. 15 Accettazione bando
La partecipazione al concorso comporta accettazione incondizionata del presente Bando. La non accettazione anche di una sola di queste clausole annulla la partecipazione al concorso.