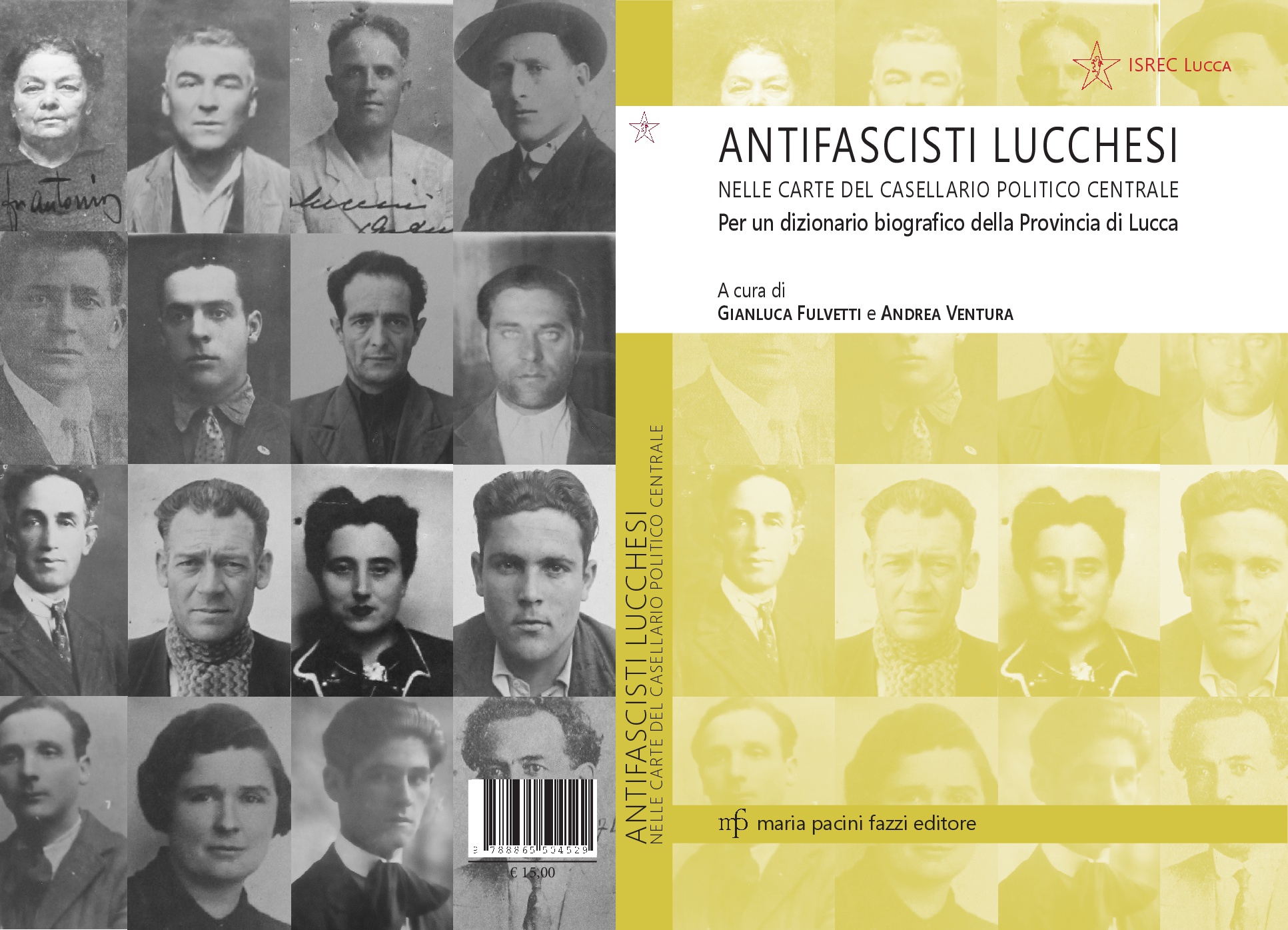Il cavallino di carta pressata. Ricordi della guerra di un bambino di 5 anni e mezzo.

Il 29 dicembre arrivò la notizia che a Poggibonsi alcune persone (dicevano i Livornesi, scappati dalla loro città a causa delle incursioni aeree americane) entrano nelle case e nelle botteghe per rubare.
Il mio babbo decise di tornare a Poggibonsi soprattutto per verificare se la bottega era chiusa bene…. Il mio babbo e la mia mamma stavano per partire, non volevano portarmi con loro, anche se non c’era sentore di bombardamenti. Io insistetti, piangendo a dirotto, perchè volevo prendere l’unico balocco che avevo: un cavallino di carta-pressata con le ruotine ed anche alcuni aranci e cavallucci attaccati a un alberello secco che rappresentava il mio primo albero di Natale. I miei si incamminarono, lasciandomi nell’aia; senza inizialmente farmi notare, li seguii giù per la discesa, giunto in fondo mi misi a strillare, non so se dalla paura o dalla voglia di seguire i miei genitori, fatto sta che alla fine il babbo preso dalla commozione disse: “Giù, gnamo, si starà a vede’”. Via verso Poggibonsi. Arrivati in paese si andò in Piazza del Comune a verificare la bottega: tutto bene. … Poi si andò andò a casa, in Via Grandi in fondo a Gallurì. Arrivati a casa, ricordo bene, per prima cosa misi nella tasca di una pastrano (cappotto) rigirato e che mi arrivava ai piedi il mio cavallino. Mentre si stava per cominciare a mangiare qualcosa portata da Linari, si sentì il rombo degli aerei, breve conciliabolo del mio babbo con la mia mamma e via verso il sottoscala; io alla svelta presi e misi in tasca qualche mandarino e due o tre cavallucci. Appena arrivati al sottoscala o forse un pochino prima, insieme al sibilo della sirena d’allarme venne giù l’inferno: boati, scoppi, polvere, fumo. grida. Per un tempo che non so quantificare, tutti fermi e stretti, poi il mio babbo uscì, chiamandoci “E’ passata!” La mia mamma aggiunse “Bisogna andare via subito!” Il mio babbo affermò (ripeto, le parole che riporto sono solo parzialmente da me ricordate, ma rammentate nel racconto di mio babbo; i miei ricordi sono lampi di memoria ma anche, per le scene più dure, sensazioni impresse nella mente in maniera emotiva ma indelebile): “Senza furia, tanto almeno per oggi non c’è pericolo, hanno di già bombardato e poi una volta basta che volete chi ci sia d’importante a Poggibonsi!” Il mio babbo esclamò : “Prima di ritornare a Linari sarebbe il caso di andare a vedere se la bottega è ritta e poi c’è Maria (sua sorella) alla Staggia (a lavare)”. Appena fatti pochi metri ci si accorse che Poggibonsi aveva subito un bombardamento immane. Gente che correva, polvere e fumo, la Via Montorsoli, per arrivare il Piazza del Comune dov’era la bottega, era interrotta all’altezza di Piazza del Teatro che bruciava in un mucchio di macerie, con un fumo acre e denso (era dovuto all’incendio degli scenari, della tappezzeria, dei costumi, delle pellicole cinematografiche); a me misero un fazzoletto davanti alla bocca per ripararmi dalla polvere, ma l’aria faticava ad arrivare ai bronchi ed ai polmoni.
Si passò da Via Maestra, ingombrata dalle macerie, poi in Piazza del Comune dove tutto era quasi intatto, anche la bottega; passavano persone con feriti portati sopra le porte o gli scurini delle finestre, che fungevano da lettiga. Chi correva di qua chi di là, apparentemente senza una meta. La mia zia non era rientrata a casa, in fondo a Via della Rocca, allora il mio babbo decise di andarle incontro. Non si poteva passare tra la Chiesa di sotto ed i Fossi, si tornò un po’ più giù verso l’attuale Coop. In un pezzo di muro rimasto in piedi una visione tremenda: una testa di un cavallo con vicino mezza ruota, attaccati a un brandello di muro rimasto ritto (dopo si seppe che era ciò che restava di Riccardo Barucci, del suo calesse e del suo cavallo, colpiti in pieno da una bomba). Appena arrivati in quella che era la Piazza dell’attuale stazione (nei Fossi) ecco che appare (nonostante l’invito di mia mamma a non guardare) una visione ancora più allucinante: tutto distrutto, morti, persone ferite, pezzi di persone grondanti sangue sparpagliati tra le macerie e in fondo alle buche provocate dalle bombe, muri e travi scarnificati.
Due particolari che non sono lampi di memoria ma ricordi chiarissimi. Arrivati a un certo punto, in fondo a una buca c’era un uomo che pareva vivo, con gli occhi spalancati, immobile. Esclama il mio babbo: “Guarda o che è Lucone![1]” poi lo chiamò: “Lucone o Lucone!” Nessuna risposta. “Vieni su, t’aiuto!” gli disse tirandolo per un braccio, ma il braccio si staccò dal corpo, senza sangue! Lo spostamento d’aria lo aveva come smembrato. La mamma mi coprì gli occhi, ma ormai tutto era fissato nella mia mente di bambino come in una indelebile pellicola.
Ci si spostò di lato e arrivati in un posto per me irriconoscibile (poi ho saputo che era ciò che restava del Tondino, così era chiamato un particolare agglomerato di case, sempre nei Fossi) un cagnolino bianco si avvicinò abbaiando insistentemente, il mio babbo lo scacciò, il cagnolino non solo insistette ma lo tirò per i pantaloni, allora si decise a seguirlo, si svoltò dietro un muro sbrecciato, ecco attaccati ad una parete per lo spostamento d’aria, un nonno e un bambino, color cioccolata. “Non guardare” urlò mia mamma. Io non riuscii nemmeno a piangere! Ecco che arrivò la mia zia con la paniera dei panni. Poi, forse perchè pieno di alte emozioni, la mia memoria si è persa… Si arrivò a Linari quando era sempre giorno.
Appena arrivato, nella mia puerile incoscienza, la prima cosa che feci, fu quella di prendere il mio cavallino di cartapressata e nasconderlo nel tronco vuoto di un vecchio olivo, subito lo coprii con della terra, per nasconderlo da viste indiscrete. Pensai “E se lo mettessi in una buca? Meglio lasciarlo nell’ulivo così non s’ammolla se piove” Ebbi ragione, alla fine dello sfollamento lo ripresi sano e salvo come ce lo avevo messo.
Cronologia essenziale
29 dicembre 1943 – Ore 12,30: il tremendo bombardamento che causa decine di morti e la distruzione di un’ampia zona del centro di Poggibonsi. L’azione è compiuta da 36 bimotori B-26 Marauders, sganciano 104 bombe da 500 libre, erano le ore 13,06.
1944 – I bombardamenti si susseguono, le incursioni saranno decine, alla fine della guerra oltre il 70% di Poggibonsi risulta distrutto (abitazioni, fabbriche, infrastrutture, viabilità stradale e ferroviaria). Questo il riepilogo degli attacchi nel territorio di Poggibonsi (da Franco Del Zanna cfr. nota 2) :
Missioni con aerei bombardieri n. 53, Aerei impiegati n.808, Bombe n. 4.351 per un totale di Tonnellate 1.236
14-18 luglio 1944 – Liberazione di Poggibonsi
[1] Era il soprannome di un suo biscugino, custode del mattatoio
Articolo pubblicato nel dicembre del 2018.