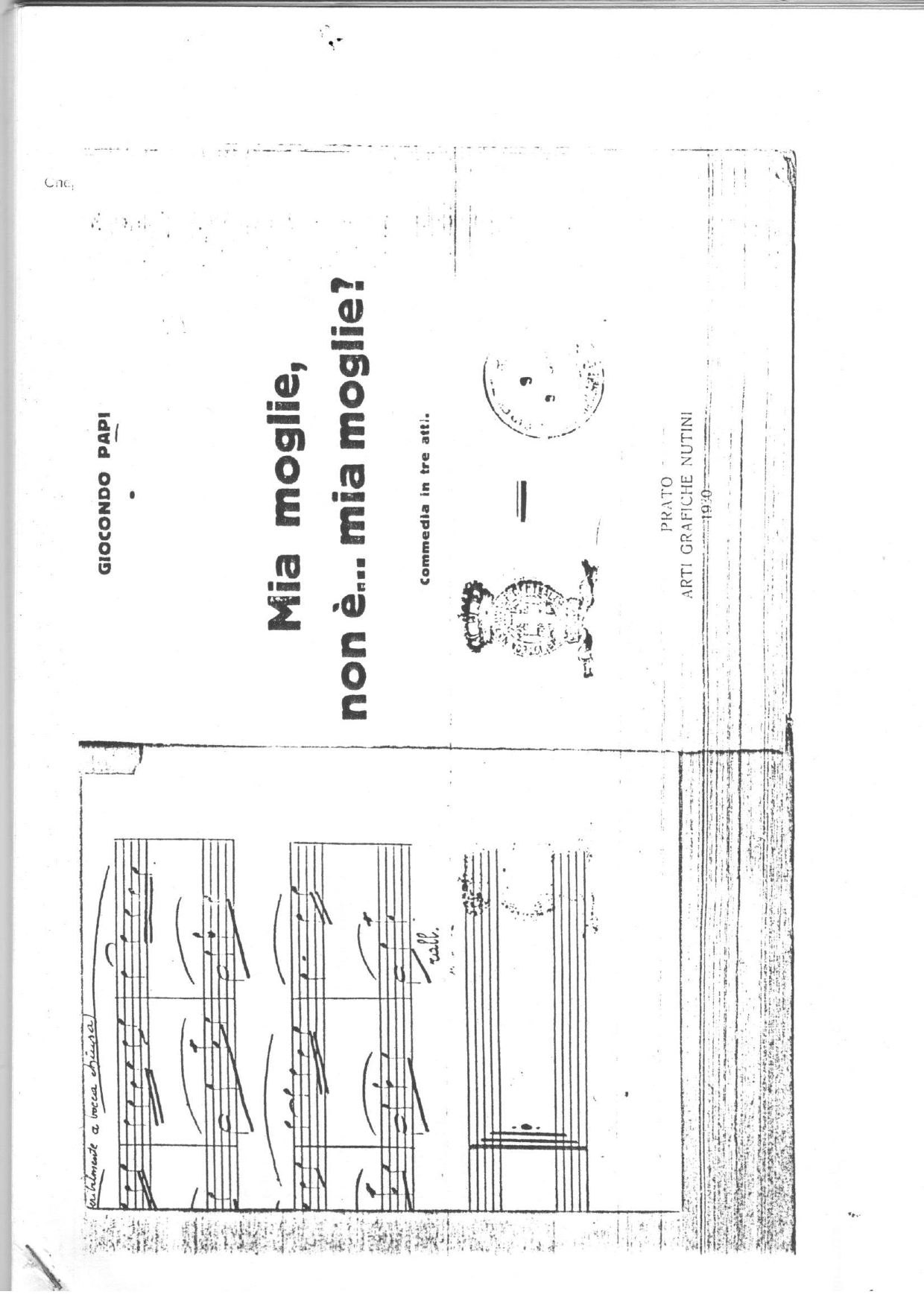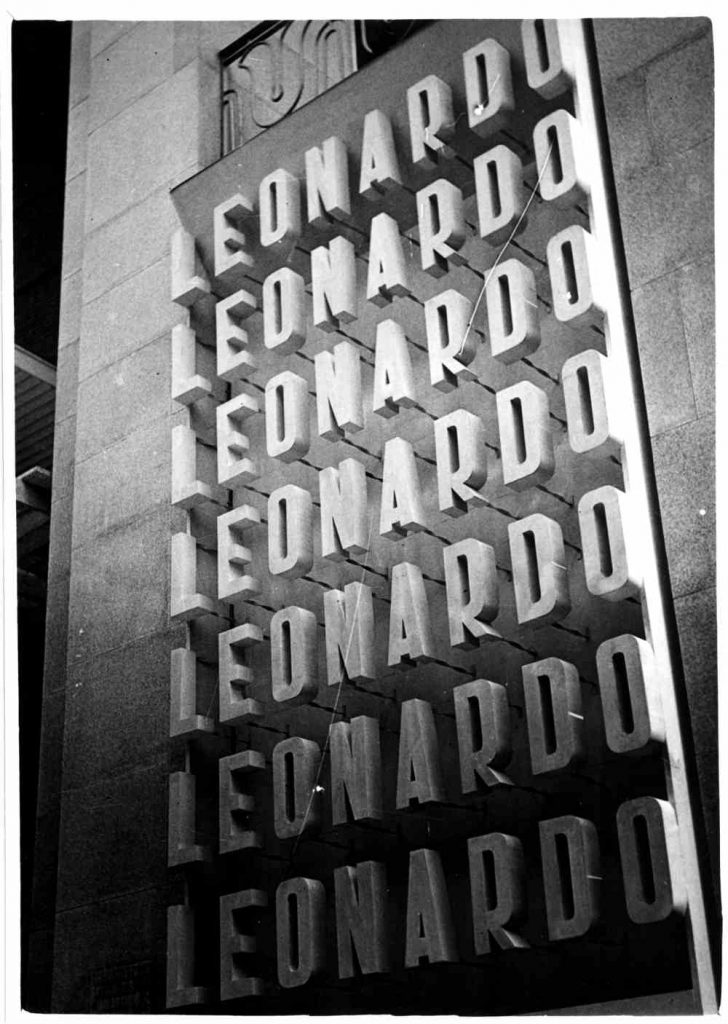CHE GENERE DI DIDATTICA?

Quando la Fondazione Carlo Marchi ha chiamato associazioni, scuole ed enti a rispondere al bando 2019 sul contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere, come ISRT abbiamo sentito il dovere e tutta l’importanza di presentare un progetto.
La violenza di genere e complessivamente il sistema di stereotipi legati al genere sono il frutto di una società costruita su radici di stampo patriarcale. L’urgenza sociale degli ultimi decenni ha spinto verso una forte riflessione che ha coinvolto le istituzioni del mondo. Prova ne sono le numerose direttive, le deliberazioni e gli inviti a porre rimedio, con speciale sguardo rivolto a coloro che hanno in mano la formazione delle giovani generazioni. Un’educazione di e al genere e lo smascheramento degli stereotipi legati ai rapporti maschile-femminile risultano quindi non più rimandabili e l’unico vero strumento sul medio-lungo periodo. A nostro avviso è stato quindi fondamentale intervenire proprio a partire dalla formazione e dalla didattica, quindi, sulla scuola.
Così è nato Un’altra storia. Percorsi di formazione e conoscenza contro la violenza di genere, un progetto che si pone l’obiettivo di produrre maggiore consapevolezza e dare gli strumenti per operare finalmente quel passaggio dalla teoria alla prassi quotidiana. Abbiamo pensato a due fasi: un corso di formazione per docenti delle scuole secondarie (previsto per marzo 2020, ma rimandato dopo il primo incontro causa emergenza covid-19) e un festival aperto alla cittadinanza (previsto per novembre 2020). Perché non solo il festival? Perché se con il festival ci proponiamo di portare alla luce la costruzione culturale dei generi e il valore normativo da essi assunto nel tempo rivolgendoci a un pubblico ampio e non specializzato, il corso di formazione è diretto specificamente a chi porta avanti quotidianamente il difficile compito di formare ragazze e ragazzi in un’età molto delicata. La scuola, infatti, è il contesto privilegiato in cui intervenire per prevenire il diffondersi e il radicarsi di culture sessiste, misogine e di violenza.
Quello che ci è sembrato immediatamente chiaro nella fase di progettazione è che per le-gli stesse-i docenti non è facile portare “il genere” nelle classi, per motivi vari e diversi. In parte per il pregiudizio che grava sul concetto stesso di “genere”, spesso frainteso, e a maggior ragione sul ruolo che la scuola dovrebbe assumere rispetto a un’educazione di e al genere. Un altro ostacolo molto importante è la mancanza di strumenti adeguati, di sostegni didattici che vadano ad accompagnare gli intenti e la passione di chi insegna. Per questo motivo, abbiamo strutturato il nostro corso intorno a un volume davvero innovativo uscito l’anno scorso per le edizioni Biblink: I secoli delle donne. Fonti e materiali per la didattica della storia (Biblink, 2019, www.biblink.it/catalogo/bl00120.html). Un “sillabo” agile ed efficace che consente l’approccio a una didattica diversa della storia, della filosofia, del diritto, dell’arte, della letteratura, utile a orientare la/il docente nei temi dell’educazione di genere attraverso un repertorio di materiali versatili da utilizzare all’interno dell’attività curricolare. Si tratta quindi di uno strumento con duplice funzione: di auto-formazione e successivamente di supporto nella costruzione di percorsi didattici che abbiano al centro lo sguardo di genere nelle varie discipline.
Il primo incontro di Un’altra storia, il 3 marzo scorso presso il Murate Art District (www.murateartdistrict.it), ha confermato le nostre idee, i presentimenti iniziali e le nostre speranze: un gruppo davvero gremito di docenti ha partecipato attivamente, molte le domande e le proposte in seguito agli interventi della professoressa Graziella Priulla (Università di Catania; Quale punto di vista? Didattica e genere) e della dottoressa Alessandra Celi (Società Italiana delle Storiche e co-curatrice del “sillabo”; I secoli delle donne. Strumento di formazione e autoformazione). Le-i docenti hanno espresso chiaramente la volontà di integrare una programmazione che da sempre esclude la prospettiva di genere e il desiderio di essere sostenut* da strumenti strutturati. I manuali risultano lacunosi, le donne sono assenti o relegate in box da colonnino, nei quali il loro apporto viene tratteggiato in una dimensione di eccezionalità, isolato dal contesto, mai approfondito. La cultura raccontata nei libri scolastici si delinea completamente al maschile, tagliando fuori dalla narrazione le donne e soprattutto il rapporto tra i generi nella costruzione (attraverso fatti storici, arte, letteratura ecc.) di un mondo di fatto condiviso.
Si tratta di un “vizio” di prospettiva millenario, che ha la stessa radice della famosa frase “La storia la scrivono i vincitori”. Infatti, nonostante le donne non costituiscano una minoranza vera e propria dal punto di vista numerico, ne hanno lo status. Occupano, cioè, una posizione di subalternità all’interno di una cultura che le ha invisibilizzate nelle narrazioni e ne ha fattivamente impedito il fiorire, escludendole dal sistema educativo, dai circoli culturali, limitandone i diritti e le possibilità. Lo stesso meccanismo ha minato i diritti civili, la libertà personale delle donne, e ne ha determinato i ruoli, i compiti, gli ambiti. Certo, oggi sono molte le conquiste ottenute attraverso il sacrificio e le battaglie di generazioni di donne (anche se queste conquiste non sono ancora distribuite in modo uniforme nel mondo), ma non è facile costruire nuove fondamenta al posto di fondamenta millenarie. Ne sono prova, come abbiamo visto, l’impostazione e i contenuti della didattica.
Quali sono le possibili ricadute dirette di una scuola che non si confronti con l’educazione di e al genere? Quali le conseguenze sulle-sugli studenti del non leggere mai nei loro testi di scuola (che rappresentano, in quella fase del percorso di formazione, le fonti cartacee più autorevoli e scientifiche a loro disposizione) storie di donne che hanno contribuito in modo sostanziale al corso degli eventi?
Il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) nella sua opera probabilmente più nota, Phänomenologie des Geistes (La fenomenologia dello spirito, Einaudi 2008) delinea il concetto di “riconoscimento”, ripreso e declinato sulla questione di genere dalla filosofa statunitense Judith Butler (1956) in Undoing Gender (Fare e disfare il genere, Mimesis 2014). Il riconoscimento è proprio il contrario dell’invisibilizzazione di un soggetto da parte di un altro soggetto, ovvero quella dinamica che si replica ogni volta che una maggioranza mette in ombra l’esistenza e la dignità di una minoranza. Il riconoscimento, invece, è quel processo che si costruisce nella relazione tra due soggetti, un percorso non necessariamente semplice, ma che conferisce valore, lo status di esistenza a entrambi i soggetti coinvolti.
Possiamo guardare all’assenza delle donne nei manuali scolastici e nella didattica come, di fatto, a un mancato riconoscimento. Quindi, possiamo facilmente immaginare quali tipi di considerazioni – anche inconsce – vengano introiettate dalle-dagli studenti. È proprio dal riconoscimento di valore che nasce il rispetto, la solidarietà, la cooperazione, la complicità. È nel mancato riconoscimento che possono instaurarsi una legittimazione delle disuguaglianze di genere e il rafforzarsi di modelli misogini e violenti, tutt’oggi vivi nel tessuto sociale. Il compito della scuola, però, dovrebbe essere quello di produrre una cultura nuova per le-i giovani, che veicoli i principi del rispetto e del valore delle diversità.
Dalla nostra esperienza, ancora in divenire, abbiamo còlto la consapevolezza delle-dei docenti, consapevolezza che, riteniamo, debba essere sostenuta e soccorsa, attraverso strumenti nuovi, attraverso un fare rete, attraverso percorsi nei quali sia possibile ripensare insieme alla didattica, porsi nuove domande per ottenere nuove risposte. Per questo motivo, non appena sarà possibile, riprenderemo Un’altra storia con la stessa passione, e attraverso il confronto, lo scambio immagineremo un’educazione di genere trasversale, pluridisciplinare, aperta alla costruzione di percorsi didattici molteplici.