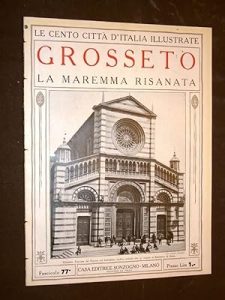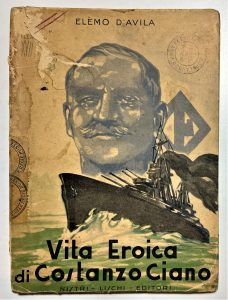«I nostri localisti sparirebbero, come gruppo organico,
se fosse possibile dimostrare, ciò che è augurabile,
che gli Etruschi non sono mai esistiti»[2]

La colonna romana collocata nel 1938 sul Bastione Mulino a vento,, oggi collocata nel Giardino dell’Archeologia
Il 24 maggio 1938 il prefetto di Grosseto, Enrico Trotta, su sollecitazione del R. Provveditore agli studi Niccolò Piccinni, inviò una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri per invitare ufficialmente il ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai a presenziare ad alcune cerimonie organizzate in diversi centri della provincia. Con ogni probabilità, l’invito mirava a richiamare l’attenzione del ministro su una grave anomalia: a Grosseto mancava una sede autorizzata a svolgere gli esami di abilitazione magistrale e di maturità classica, circostanza che la rendeva l’unico capoluogo di provincia in Italia in tale condizione. Si trattava, come si sottolineava, di una «questione di prestigio» per una città in rapida crescita demografica, ormai avviata verso la trasformazione da borgo rurale a moderno centro di servizi, nonché di un «riconoscimento di una legittima aspettativa dei cittadini, delle autorità e delle gerarchie fasciste»[3].
Il viaggio, previsto «possibilmente verso la metà del prossimo giugno», avrebbe visto la partecipazione del ministro all’«inaugurazione di oltre duecento gagliardetti delle scuole elementari» e alla «posa della prima pietra dell’Istituto tecnico minerario di Massa Marittima» che coronava «un’annosa aspirazione di quella città» a dotarsi di un istituto che formasse i quadri della maggiore industria del territorio. Tra le due iniziative, era poi stata programmata una cerimonia dall’alto valore simbolico: «l’inaugurazione di una colonna romana sulle mura medicee del capoluogo, in ricordo della celebrazione del bimillenario di Augusto»[4].
La mancata partecipazione del Ministro – impossibilitato a raggiungere la provincia per i «troppi impegni per l’anno in corso»[5] – non impedì tuttavia il regolare svolgimento della celebrazione augustea, il 17 di giugno, che si aprì con un’orazione pubblica del prof. Francesco Moggio del R. Liceo ginnasio “Carducci-Ricasoli” e vide la consegna «da parte delle scuole di una colonna romana, tratta dagli scavi dell’antica Roselle ed eretta sui bastioni della città, per significare la continuità dell’idea di Roma da Augusto a Mussolini», accompagnata dall’esecuzione, da parte del coro dell’Istituto magistrale, «dell’inno a Roma e degli altri della Patria fascista»[6].
Espressione di quella tendenza all’occupazione del tempo sociale, all’imposizione di un nuovo senso della Storia e alla riorganizzazione del calendario civile precocemente espressa dal regime[7], la celebrazione del bimillenario della nascita di Augusto costituì «l’apice dell’identificazione del fascismo con la romanità»[8]. A seguito della conquista dell’Etiopia, il regime aveva infatti accentuato la propria identificazione con un immaginario di tipo imperiale, elaborato e diffuso anche grazie all’opera di storici e intellettuali militanti, che contribuirono a trasformare Mussolini in «un vero e proprio alter ego di Augusto»[9].
Diversamente da altri anniversari legati a personaggi della res publica, come quelli dedicati alla nascita di Orazio (1930) e di Virgilio (1935), il bimillenario augusteo fu accompagnato da un articolato programma di celebrazioni. Sul piano nazionale esso trovò la sua espressione più evidente nell’inaugurazione della Mostra Augustea della Romanità, aperta a Roma il 23 settembre 1937 in concomitanza con la riapertura della Mostra della Rivoluzione fascista[10]. Parallelamente, a livello locale furono promosse iniziative di varia natura, nelle quali si realizzarono le più disparate pratiche di «appropriazione/reinvenzione della storia di Roma» in funzione propagandistica[11].

Area degli scavi archeologici di Roselle (Credits: https://museitoscana.cultura.gov.it)
A Grosseto, come si è visto, le celebrazioni assunsero la forma di una vera e propria riconsacrazione di un reperto archeologico elevato a simbolo della romanità. Ciò serviva a richiamare la filiazione diretta del capoluogo della Maremma dall’antica Roselle, oggetto di scavi nella seconda metà degli anni Venti sull’onda di un crescente interesse storico e identitario. Importante centro della dodecapoli etrusca, poi conquistata dai Romani e ulteriormente sviluppatasi a cavallo tra il III e il II secolo a.C. – quando fornì grano e legname per la flotta di Publio Cornelio Scipione diretta sulle coste cartaginesi – Roselle era divenuta sede vescovile tra il IV e il V secolo d.C. Fu progressivamente abbandonata dai suoi abitanti nei secoli successivi, e nel 1138 la cattedra vescovile venne trasferita nel borgo di Grosseto, sorto lungo la via Aurelia in una posizione più facilmente difendibile dagli attacchi provenienti dal mare[12].
Tra il 1937 e il 1938, parallelamente alle iniziative promosse in occasione del bimillenario augusteo, videro la luce alcuni contributi storico-archeologici dedicati al capoluogo e a diversi centri della provincia di Grosseto. Si trattava di lavori generalmente di modesto valore scientifico e poco inclini a confrontarsi con la ricerca accademica, ma che ben si prestavano a essere utilizzati come strumenti di celebrazione della romanità fascista[13]. Gli autori appartenevano ai diversi filoni della cultura erudita locale e avevano aderito con anticipo e convinzione alle politiche culturali del regime; la loro attenzione era orientata – per usare un’espressione di Luciano Bianciardi – verso il «problema delle origini»[14], in contrasto con l’approccio degli intellettuali più giovani, impegnati invece a costruire, attraverso la letteratura e le arti figurative, l’immagine di una provincia “redenta” dalla bonifica integrale e destinata ad assumere un ruolo di rilievo nella cultura nazionale[15].

A. Salvetti, 1929, Ritratto di Monsignor Antonio Cappelli, olio su tela, conservato nel Museo di arte sacra della Diocesi di Grosseto
Tra le figure più rilevanti di questo gruppo spiccava Antonio Cappelli – il «canonico dottissimo e sordo» ricordato da Geno Pampaloni[16] – punto di riferimento della cultura grossetana. Cappelli dirigeva il Museo civico, il Museo diocesano e la Biblioteca Chelliana, oltre al “Bollettino della Società storica maremmana”, rivista che nei primi anni aveva ospitato contributi di Gioacchino Volpe e del giovane Ranuccio Bianchi Bandinelli, prima di trasformarsi, nel 1931, nell’organo del locale Istituto fascista di cultura[17]. Fu proprio Cappelli a impegnarsi con particolare costanza nella costruzione di una mitologia storica fondativa del capoluogo, incentrata soprattutto sul periodo medievale[18].
Assai più attento agli studi e alla divulgazione delle più recenti scoperte archeologiche era il pubblicista Pietro Raveggi, fondatore del Civicum antiquarium annesso alla biblioteca di Orbetello e, dal 1936, membro della locale Commissione propaganda. A lui si devono ricerche sulla città lagunare, su Ansedonia-Cosa, Talamone e sull’area meridionale della provincia, caratterizzate da un livello scientifico più rigoroso rispetto alla produzione coeva[19]. Come Cappelli, Raveggi ricopriva da molti anni l’incarico di Regio ispettore onorario per le antichità e l’arte nella provincia, funzione che gli fu confermata proprio nell’anno del bimillenario augusteo[20].
Lo studioso che nel biennio 1937-1938 si impegnò più sistematicamente nella valorizzazione della romanità in chiave fascista – espressione di quel «filone erudito più attento alla retorica di campanile che al rigore della ricerca»[21] – fu tuttavia Adone Innocenti, autore di due contributi dedicati a Roselle. In un breve articolo, L’antica via Aurelia attraverso il territorio rosellano, egli ripercorreva la genesi di «una delle più famose e magnifiche strade romane», insistendo sulla sovrapposizione di parte del suo tracciato con un’arteria più antica che collegava Roselle e Vetulonia: «Ecco ancora una volta la voce solenne dell’Etruria antica nella Maremma, che vide le legioni romane marciare sulle strade consolari al cospetto del “Mare nostrum” solcato dalla potenza marinara di Roma»[22].
Come si evince da questo testo, anche per gli intellettuali locali più allineati all’ideologia fascista appariva molto complesso celebrare la presunta romanità di Grosseto senza far riferimento alla persistenza di un radicato “sostrato etrusco” che, fin dalla metà dell’Ottocento, era divenuto un elemento costitutivo dell’identità maremmana[23] inizialmente condivisa dalle élites cittadine e, in seguito, grazie al crescente numero di scoperte archeologiche, divenuto patrimonio della cittadinanza intera[24].

Il canonico Giovanni Chelli
A conferma di ciò – e riproponendo una polemica, di ascendenza sette-ottocentesca, nei confronti di Roma e della sua eredità storica – alcuni intellettuali cittadini, ancora alla fine degli anni Venti, continuavano a contrapporre etruschi e romani, richiamandosi alla narrazione codificata dal canonico Giovanni Chelli nel 1849, fondatore del museo e della biblioteca cittadini, il quale accusava i Romani di aver sfruttato in modo irrazionale le risorse naturali e di aver compromesso l’equilibrio ambientale della regione[25].
Un esempio significativo di tali frizioni, che ostacolarono sul piano locale la completa assimilazione degli Etruschi all’interno del «mito unitario della romanità»[26], è offerto dal fascicolo dedicato a Grosseto della collana Cento città d’Italia illustrate, pubblicato sul finire degli anni Venti da Sonzogno. Riflettendo sulla decadenza delle città etrusche e, più in generale, della Maremma, l’autore del saggio, il preside del R. Liceo-ginnasio “Carducci Ricasoli” Enrico Fatini, scriveva:
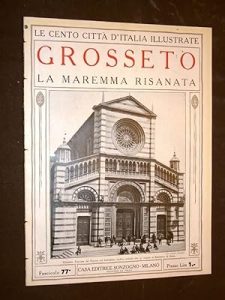
Cento città d’Italia illustrate, numero dedicato a Grosseto
Forse giova pensare che i Romani abbiano incontrata accanita resistenza nell’assoggettare questo popolo generoso e fiero, e però si siano mostrati inesorabili con esso, sino a disperderne la memoria per poterne soffocare con questa ogni anelito di libertà. Sotto i Romani, il paese, trascurato e disertato, iniziò il suo disfacimento[27].
Queste dinamiche legate all’identità etrusca non si spiegano soltanto in termini di continuità culturale. Dal canto suo, il regime fascista aveva promosso, a partire dal 1925, «un processo di istituzionalizzazione dello studio degli Etruschi» sul piano nazionale: dalla creazione della prima cattedra di Etruscologia all’Università di Roma, alla convocazione dei primi convegni nazionali, fino all’organizzazione dell’Istituto di studi etruschi[28]. Il fascismo mirava a individuare nel popolo etrusco l’origine di un primigenio laboratorio dell’italianità, che avrebbe trovato pieno compimento nella civiltà romana; dal punto di vista “razziale”, gli Etruschi venivano inoltre considerati l’anello iniziale di una continuità di sangue e di stirpe che, attraverso Roma, conduceva linearmente all’Italia di Mussolini, respingendo ogni ipotesi relativa a una loro presunta origine non autoctona.

Ascia bipenne rinvenuta nella c.d. Tomba del Littore a Vetulonia nel 1898
A sostegno di tale genealogia veniva spesso richiamata l’origine etrusca del simbolo stesso del regime: il fascio littorio, la cui legittimazione archeologica era affidata al ritrovamento, avvenuto a Vetulonia nel 1898, di un’ascia bipenne racchiusa da lamine in metallo rinvenuta nella cosiddetta Tomba del Littore[29].
Sul piano locale, l’idea di una filiazione diretta tra l’Etruria e la “Terza Roma” mussoliniana trovò terreno fertile tra gli intellettuali coinvolti nell’organizzazione della cultura e della propaganda. Come scriveva Pietro Raveggi a proposito della città di Heba, «il problema etrusco si confonde con quello delle origini stesse della civiltà italica» e solo grazie al fascismo e al Duce era stato possibile «dar vita e forma a questo rifiorente culto verso la nostra antica tradizione»[30].
Nel 1943 si ebbe invece un intervento culturale di più ampio respiro, promosso direttamente dal provveditorato agli studi. In quell’anno venne infatti avviata la pubblicazione, a cura dello stesso provveditorato, di una collana di monografie sugli etruschi da distribuire nelle scuole medie della provincia. Nella Premessa del primo volume, ristampa di una ricerca dell’etruscologo Pericle Ducati del 1933, il provveditore Ernesto Lama sottolineava il ruolo primigenio della civiltà etrusca nella genealogia italica:
gli Etruschi potrebbero rivendicare una precisa funzione, oltre che nell’etnogenesi italiana, anche nella formazione storica di Roma, che dalla cultura e dalla potenza degli Etruschi trasse efficaci elementi, specie nel primo periodo, per la sua grandiosa costruzione[31]
Successivamente Lama si rivolgeva agli alunni della Maremma, motivando le ragioni dell’iniziativa editoriale con queste parole, che richiamavano la necessità di integrare il piano dell’identità locale e di quella nazional-patriottica:
Il fascino e l’ansia che sospingono l’odierna Maremma a ricercare l’origine della sua gente nel proprio sottosuolo, disseminato di tombe e di avanzi gloriosi, sembra perpetuare una volontà di potenza giammai estinta, oltre che costituire una nobile rivendicazione dello spirito severo degli antichissimi padri, della loro vita operosa ed espansiva, delle loro molteplici e gloriose attività. Portare un qualche contributo a questa nobile aspirazione dei Maremmani e, nello stesso tempo, chiarire, precisare e divulgare problemi di cultura che valgano ad illuminare la perenne gloria legata in ogni epoca, sin dalle antichissime età, alla storia d’Italia, sono i motivi e le finalità che hanno ispirato questa raccolta di brevi monografie, la cui pubblicazione si inizia in un momento fatidico ed augurale della nostra Italia, come per trarre dal profondo della storia gli auspici per l’avvenire[32].
In conclusione, appare evidente come già in epoca fascista il culto della romanità fascista non avesse trovato, nel marginale contesto sociale e culturale grossetano, un terreno realmente fertile. Da questa discrepanza, si avviò così una dinamica destinata a emergere con particolare nettezza nel secondo dopoguerra, quando, tanto nell’ambito archeologico quanto nell’opinione pubblica locale, si sarebbe progressivamente consolidata una tradizione filoetrusca, mentre il disinteresse per l’eredità romana sarebbe risultato sempre più evidente, nonostante la presenza sul territorio di scavi di grande rilievo[33]. La forte identità etrusca della Maremma, costruita dalle élite intellettuali cittadine fin dall’Ottocento, non solo resistette alle pressioni ideologiche del regime, ma finì anzi per rimodulare almeno in parte e secondo una logica di continuità locale, la stessa ricezione della politica culturale fascista.
Note
[1] L’autore ringrazia Michele Gandolfi, Adolfo Turbanti ed Elena Vellati per aver letto e commentato la prima stesura di questo contributo.
[2] Luciano Bianciardi, I localisti in «La Gazzetta», 13 settembre 1952 ora in Id., Tutto sommato. Scritti giornalistici 1952-1971, vol. 1, ExCogita, Milano 2022, pp. 101-102.
[3] Archivio di Stato di Grosseto (ASG), R. Prefettura, Gabinetto, b. 690, lettera del prefetto Trotta alla Direzione generale dell’Istruzione media classica del ministero dell’Educazione nazionale, 26 aprile 1938. Sul peculiare sviluppo sociale e urbanistico di Grosseto si veda Gian Franco Elia, Città malgrado. Profilo dello sviluppo urbano, in Simone Neri Serneri, Luciana Rocchi (a cura di), Società locale e sviluppo locale. Grosseto e il suo territorio, Carocci, Roma 2003, pp. 105 e ss.
[4] ASG, R. Prefettura, Gabinetto, b. 691, lettera del prefetto Trotta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 24 maggio 1938.
[5] ASG, R. Prefettura, Gabinetto, b. 691, lettera del Ministro Bottai al prefetto Trotta, 10 giugno 1938.
[6] ASG, R. Prefettura, Gabinetto, b. 691, invito per la celebrazione del bimillenario augusteo, 14 giugno 1938.
[7] Cfr. Piergiorgio Zunino, L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del regime, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 63-129; Claudio Fogu, The Historic Imaginary: Politics of History in Fascist Italy, Toronto University Press, Toronto 2016; Paola S. Salvatori (a cura di), Il fascismo e la storia, Edizioni della Normale, Pisa 2020.
[8] Aristotle Kallis, “Framing” Romanità: The Celebrations for the Bimillenario Augusteo and the Augusteo-Ara Pacis Project, in “Journal of Contemporary History”, vol. 46, n. 4, 2011, pp. 809-831 [traduzione mia].
[9] Andrea Giardina, André Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 248.
[10] Cfr. Alessandro Cavagna, Il «benefico impulso di Roma»: la Mostra augustea della romanità e le province, in Paola S. Salvatori (a cura di), Il fascismo e la storia, cit., pp. 51-72.
[11] Cfr. Piergiovanni Genovesi, Propaganda di regime tra centro e periferia. Una celebrazione “locale” della romanità fascista, in “SPES”, n. 9, 2019, pp. 71-91
[12] Doro Levi, Il Museo di Grosseto e gli scavi di Roselle, “Maremma. Bollettino della società storica maremmana”, n. 3, 1926-1927, pp. 81-87.
[13] Cfr. ad esempio Adone Innocenti, Roselle e il suo territorio, Tipografia Fascista La Maremma, Grosseto 1938; Ildebrandino Rosso, Saturnia, Tipografia Fascista La Maremma, Grosseto 1938; Pietro Raveggi, Ansedonia, Tipografia Fascista La Maremma, Grosseto 1937; Id., Sull’identificazione di Talamone etrusco-romano, Bollettino di Statistica del Comune di Grosseto, aprile 1938, pp. 1-8
[14] Luciano Bianciardi, Il lavoro culturale, Feltrinelli, Milano 2009 [1957], pp. 5-12. Per una panoramica su queste figure si rimanda a Carlo Citter, Il progresso degli studi fra’800 e ‘900: la nascita dell’archeologia e i primi studiosi locali in Id., Antonia Arnoldus-Huyzendveld (a cura di), Archeologia urbana a Grosseto. Vol. I: La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone. Origine e sviluppo di una città medievale nella “Toscana delle città deboli”, All’insegna del giglio, Firenze 2007, pp. 5-6.
[15] Centrale fu l’esperienza della rivista di arti e letteratura Ansedonia diretta da Antonio Meocci. Cfr. Simone Giusti, «Ansedonia» e «Mal’aria», due riviste di letteratura e arte in Maremma in Enrico Crispolti, Anna Mazzanti, Luca Quattrocchi (a cura di), Arte in Maremma nella prima metà del Novecento, Silvana, Milano, 2006, pp. 305-309. Sul contesto generale mi permetto di rimandare a Stefano Campagna, «Dobbiamo aver coscienza del nostro provincialismo culturale». Intellettuali, politica e cultura a Grosseto dal fascismo al miracolo economico di prossima pubblicazione nel Quaderno n. 20 della Fondazione Luciano Bianciardi.
[16] Geno Pampaloni, Prefazione in Antonio Meocci, Maramad, Barulli, Roma 1969, p. 12. Su Antonio Cappelli si veda Mariagrazia Celuzza, Il canonico Antonio Cappelli (1868-1939) in Cristina Gnoni Mavarelli, Laura Martini (a cura di), La cattedrale di San Lorenzo a Grosseto. Arte e storia dal XIII al XIX secolo, Silvana, Milano 1996, pp. 105-116.
[17] Fondato nel 1923 da un comitato promotore composto da studiosi locali e di rilevanza nazionale, il Bollettino della società storica maremmana cessò definitivamente le sue pubblicazioni nel 1936. Sarà poi rifondato negli anni Sessanta. Cfr. Mariagrazia Celuzza, Etruschi per forza: l’archeologia della Maremma e l’identità del territorio in Ead., Elena Vellati (a cura di), La grande trasformazione. Maremma tra epoca lorenese e tempo presente, Isgrec-Effigi, Arcidosso 2019, p. 156.
[18] A questo proposito si veda Antonio Cappelli, La signoria degli Abati del Malia e la repubblica senese in Grosseto, Tipografia Fascista La Maremma, Grosseto 1931.
[19] Cfr. ad esempio Pietro Raveggi, La Sub-Cosa e il Vico Cosano: contributo allo studio dei suburbii e vichi etruschi in Alcune comunicazioni presentate al 1. Convegno nazionale etrusco, Stabilimento tipografia sociale, Cortona, 1926. Su Raveggi si veda Giovanni Damiani, Pietro Raveggi. La vita e le opere, Effigi, Arcidosso, 2015.
[20] Cfr. ASG, R. Prefettura, Gabinetto, b. 690, lettere della R. Sovraintendenza all’arte medievale e moderna per la Toscana al prefetto Trotta, 13 gennaio 1938.
[21] Carlo Citter, Il progresso degli studi fra’800 e ‘900, cit., p. 5.
[22] Adone Innocenti, L’antica Via Aurelia attraverso il territorio Rosellano, Tipografia Fascista La Maremma, Grosseto 1938, p. 6.
[23] Sulla lunga durata di questo fenomeno identitario cfr. Mariagrazia Celuzza, Luciano Bianciardi, gli etruschi, il medioevo e Grosseto: una questione di identità? in Valentino Nizzo, Antonio Pizzo (a cura di), Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci, Milano, Mimesis 2018, pp. 105-106.
[24] Cfr. Ead, Etruschi per forza, cit. pp. 146-155.
[25] «Sì, questi crudeli dominatori […] non furono lenti a rapire quanto nel mio seno si conteneva di bello e raro, ad arrogarsi il godimento di ciò che non potevano rapirmi, cioè la fecondità prodigiosa del mio suolo, le miniere inesauribili, le immense foreste necessarie un tempo alla costruzione navigli […]. Ma costoro ricambiarono tanti miei benefizi colla più nera ingratitudine; perché è da essi che io ripeto la prima cagione della insalubrità del mio clima» (Giovanni Chelli, La Maremma personificata che narra le sue passate e presenti vicende, Stamperia sulle logge del grano, Firenze 1846, pp. 54-55, cit. in ivi, p. 147)
[26] Andrea Avalli, Il mito della prima Italia. L’uso politico degli Etruschi tra fascismo e dopoguerra, Viella, Roma 2024, p. 6 [versione ebook].
[27] Le cento città d’Italia illustrate. Grosseto, la Maremma risanata, Sonzogno, Milano, s.d. [1926-1929], pp. 3-4.
[28] Cfr. Andrea Avalli, Il mito della prima Italia, cit., pp. 51-87 [versione ebook].
[29] Cfr. Paola S. Salvatori, Romanità e fascismo: il fascio littorio in “Forma Urbis”, n. 6, 2013, pp. 34-52.
[30] Pietro Raveggi, Heba e la sua necropoli, in “Maremma. Bollettino della società storica maremmana”, n. 3, 1934, p. 3.
[31] Ernesto Lama, Introduzione in Pericle Ducati, La formazione del popolo etrusco, R. provveditorato agli studi di Grosseto, Grosseto 1943 [1933], p. VII.
[32] Ivi, p. VIII.
[33] Cfr. Mariagrazia Celuzza, Etruschi per forza, cit. pp. 158.

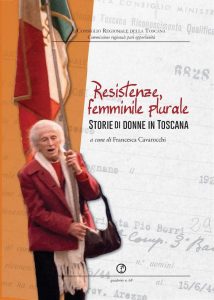 L’80esimo della Liberazione dal nazifascismo è stato costellato di iniziative, pubblicazioni, convegni caratterizzati sul tema delle Resistenze al femminile. Anche la Rete Toscana degli istituti storici della Resistenza si è inserito in questo filone con una prima sperimentazione di campagna social condivisa e una pubblicazione Resistenza, femminile plurale. Storie di donne in Toscana curata da Francesca Cavarocchi, che ha visto la partecipazione in sinergia di molte volontarie e molti volontari degli istituti locali. Il progetto, sviluppato sulla base della documentazione conservata e raccolta negli archivi della Rete, ha dato vita alla ricostruzione e all’analisi di cinquanta biografie di donne che hanno partecipato al processo resistenziale in Toscana; permettendo, inoltre, di riflettere anche sullo stato dell’arte delle conoscenze e degli studi relativi al tema.
L’80esimo della Liberazione dal nazifascismo è stato costellato di iniziative, pubblicazioni, convegni caratterizzati sul tema delle Resistenze al femminile. Anche la Rete Toscana degli istituti storici della Resistenza si è inserito in questo filone con una prima sperimentazione di campagna social condivisa e una pubblicazione Resistenza, femminile plurale. Storie di donne in Toscana curata da Francesca Cavarocchi, che ha visto la partecipazione in sinergia di molte volontarie e molti volontari degli istituti locali. Il progetto, sviluppato sulla base della documentazione conservata e raccolta negli archivi della Rete, ha dato vita alla ricostruzione e all’analisi di cinquanta biografie di donne che hanno partecipato al processo resistenziale in Toscana; permettendo, inoltre, di riflettere anche sullo stato dell’arte delle conoscenze e degli studi relativi al tema.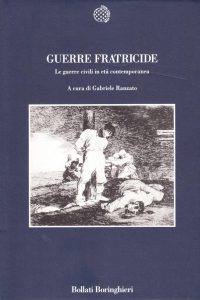 di partecipazione femminile nel Secondo conflitto mondiale e nella Resistenza. In un contesto bellico divenuto “totale” e civile, le donne attraversarono nuovamente lo spazio della guerra, condividendolo in promiscuità – anche in maniera conflittuale – con gli uomini. Non si trattò solo di una presenza nella lotta armata partigiana, ma anche di una partecipazione attiva all’interno di luoghi da sempre connotati in termini di genere: non solo la casa, ma anche spazi collettivi come i mercati, le piazze, le vie dei rifornimenti. Questo sconfinamento tra pubblico e privato aprì nuovi margini di azione politica e simbolica, mettendo radicalmente in discussione i ruoli di genere consolidati, come dimostra l’esempio di Francesca Rolla e delle donne della rivolta di piazza delle Erbe del luglio 1944.
di partecipazione femminile nel Secondo conflitto mondiale e nella Resistenza. In un contesto bellico divenuto “totale” e civile, le donne attraversarono nuovamente lo spazio della guerra, condividendolo in promiscuità – anche in maniera conflittuale – con gli uomini. Non si trattò solo di una presenza nella lotta armata partigiana, ma anche di una partecipazione attiva all’interno di luoghi da sempre connotati in termini di genere: non solo la casa, ma anche spazi collettivi come i mercati, le piazze, le vie dei rifornimenti. Questo sconfinamento tra pubblico e privato aprì nuovi margini di azione politica e simbolica, mettendo radicalmente in discussione i ruoli di genere consolidati, come dimostra l’esempio di Francesca Rolla e delle donne della rivolta di piazza delle Erbe del luglio 1944. All’interno delle riflessioni sul “fare storia” delle Resistenze al femminile è utile fare ricorso alla costruzione di narrazioni biografiche, poiché si tratta di una forma di restituzione duplice delle traiettorie individuali e delle pratiche di resistenza, a cui possiamo così (ri)dare luce e dignità, e al tempo stesso perché ci consente di socializzare gli avvenimenti storici attraverso la concretezza delle condizioni esistenziali reali delle attrici attive e trarre interpretazioni sul fenomeno generale. La storiografia femminista dagli anni Settanta ha permesso un allargamento del concetto stesso di resistenz(e), con la messa al centro del racconto storico delle soggettività, delle voci delle donne che hanno vissuto in prima persona e poi rielaborato nel corso degli anni della prima Repubblica la propria esperienza durante il biennio 1943-1945. Assunti tali dibattiti storiografici, dopo la stagione degli anni Novanta non abbiamo avuto nuovi impulsi metodologici né si è verificata un’ampia raccolta di nuove fonti e biografie, anche a causa della progressiva scomparsa delle protagoniste. Facciamo perciò ricorso alla storiografica, alla memorialistica, alla diaristica, a carte e ricerche di seconda mano che sappiamo restituirci dei frammenti, delle pratiche, dei nomi e delle biografie (quando siamo fortunate e forse soprattutto per i casi più noti). Un rigoroso approccio di metodo oggi ci interroga, quindi, sull’uso delle fonti primarie e secondarie con uno sguardo critico, capace di cogliere le distorsioni dei giudizi emessi nel corso di questi ottant’anni, comprese le categorie “stereotipate” e la rigida divisione delle pratiche armate e “disarmate”. Di fronte al reiterare dell’utilizzo di termini quali eroine, martiri, “poche feroci” in armi, “staffette”, abbiamo l’obbligo di procedere secondo una riflessione e una scrittura del racconto storico che non le riproponga assorbendone la forma acriticamente.
All’interno delle riflessioni sul “fare storia” delle Resistenze al femminile è utile fare ricorso alla costruzione di narrazioni biografiche, poiché si tratta di una forma di restituzione duplice delle traiettorie individuali e delle pratiche di resistenza, a cui possiamo così (ri)dare luce e dignità, e al tempo stesso perché ci consente di socializzare gli avvenimenti storici attraverso la concretezza delle condizioni esistenziali reali delle attrici attive e trarre interpretazioni sul fenomeno generale. La storiografia femminista dagli anni Settanta ha permesso un allargamento del concetto stesso di resistenz(e), con la messa al centro del racconto storico delle soggettività, delle voci delle donne che hanno vissuto in prima persona e poi rielaborato nel corso degli anni della prima Repubblica la propria esperienza durante il biennio 1943-1945. Assunti tali dibattiti storiografici, dopo la stagione degli anni Novanta non abbiamo avuto nuovi impulsi metodologici né si è verificata un’ampia raccolta di nuove fonti e biografie, anche a causa della progressiva scomparsa delle protagoniste. Facciamo perciò ricorso alla storiografica, alla memorialistica, alla diaristica, a carte e ricerche di seconda mano che sappiamo restituirci dei frammenti, delle pratiche, dei nomi e delle biografie (quando siamo fortunate e forse soprattutto per i casi più noti). Un rigoroso approccio di metodo oggi ci interroga, quindi, sull’uso delle fonti primarie e secondarie con uno sguardo critico, capace di cogliere le distorsioni dei giudizi emessi nel corso di questi ottant’anni, comprese le categorie “stereotipate” e la rigida divisione delle pratiche armate e “disarmate”. Di fronte al reiterare dell’utilizzo di termini quali eroine, martiri, “poche feroci” in armi, “staffette”, abbiamo l’obbligo di procedere secondo una riflessione e una scrittura del racconto storico che non le riproponga assorbendone la forma acriticamente.